Danilo Littarru
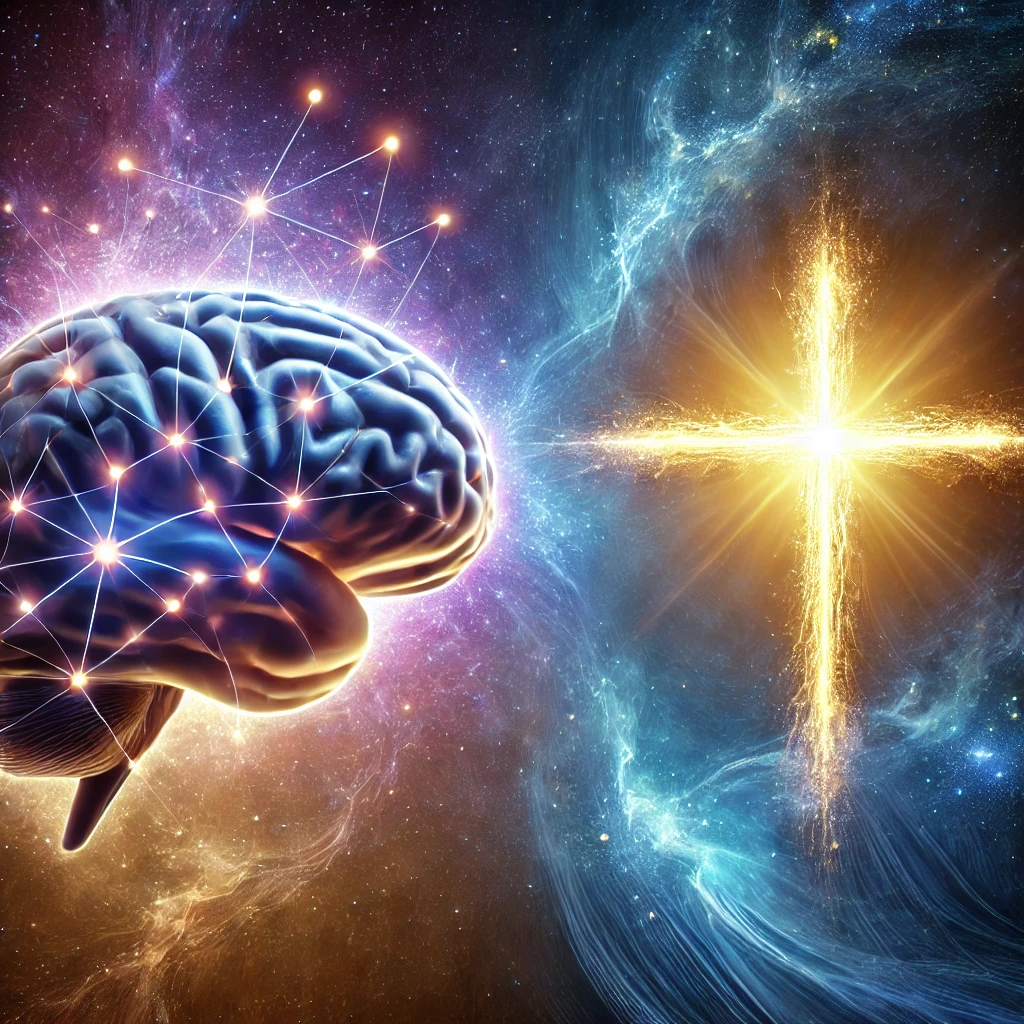
Il rapporto tra fede e neuroscienze rappresenta un argomento di grande interesse e complessità, capace di unire discipline apparentemente distanti in un dialogo ricco di implicazioni. Ciò che un tempo era dominio esclusivo della teologia — la capacità dell’essere umano di aprirsi al trascendente — oggi è oggetto di indagine scientifica. Siamo programmati per credere? Esiste una base neurobiologica che confermi l’idea, cara alla tradizione teologica, dell’uomo come capax Dei, ovvero “capace di Dio”? La scienza moderna cerca risposte a queste domande, esplorando la possibilità che nel cervello umano vi siano predisposizioni neuronali che favoriscono l’esperienza religiosa.
Negli ultimi trent’anni, molti studiosi hanno lavorato per comprendere il legame tra spiritualità e funzionamento cerebrale, dando origine a un campo interdisciplinare noto come neuroteologia. Questo ambito di ricerca si propone di esaminare come specifici processi neurobiologici siano associati alle esperienze religiose e spirituali. Uno dei pionieri di questa disciplina è Dean Hamer, genetista americano, il cui lavoro ha suscitato grande interesse, soprattutto in ambito divulgativo. Nel suo libro del 2005, Hamer affronta una serie di quesiti fondamentali: perché la spiritualità è una forza così universale? Perché tanti individui attribuiscono un valore così elevato alla dimensione spirituale, spesso più del piacere, del potere o della salute?
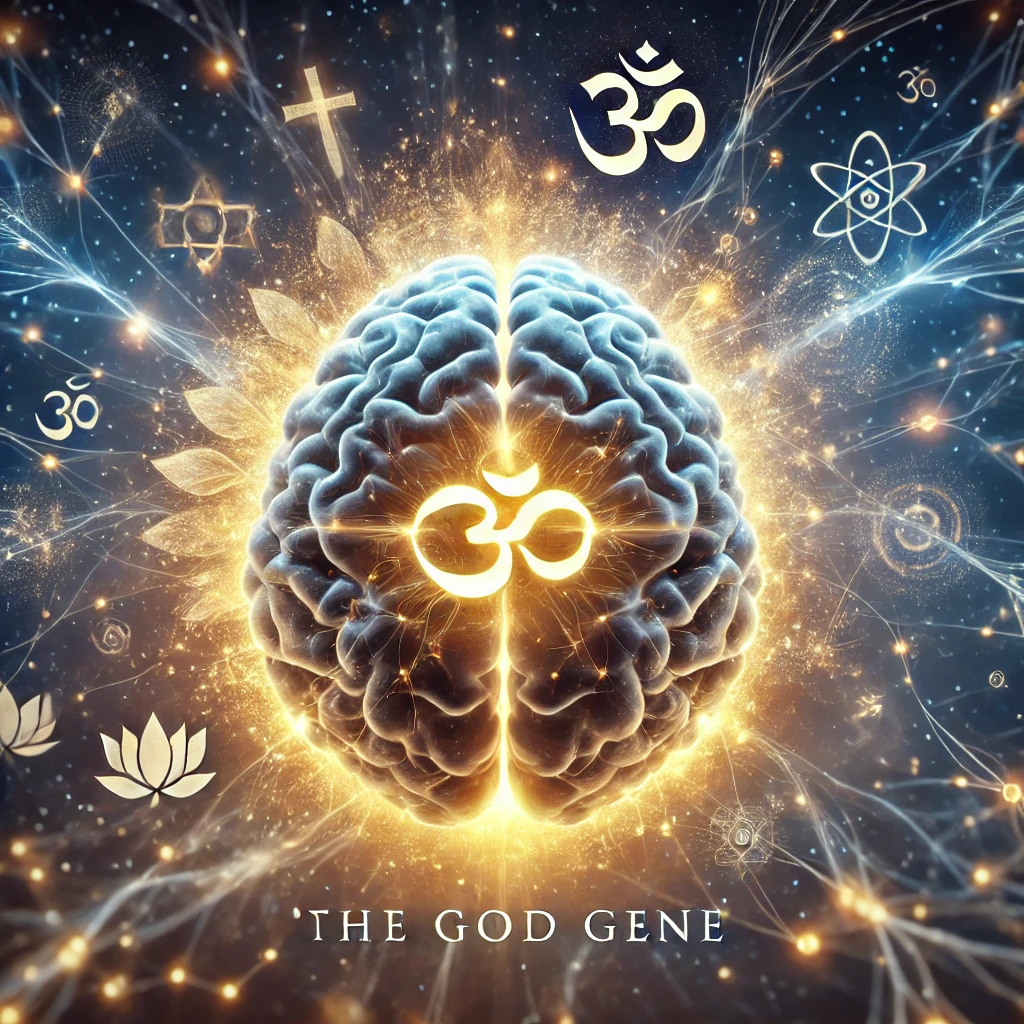
Hamer propone che la risposta a queste domande risieda, almeno in parte, nella genetica umana. Secondo la sua teoria, la spiritualità sarebbe una caratteristica evolutiva innata, radicata nel nostro patrimonio genetico. In particolare, Hamer identifica il gene VMAT2 (“vesicular monoamine transporter 2”) come potenziale responsabile del nostro “potenziale genetico” di credere. Questo gene, coinvolto nella regolazione dei neurotrasmettitori monoaminici come dopamina e serotonina, potrebbe influenzare la predisposizione individuale verso esperienze spirituali.
Uno degli obiettivi principali della neuroteologia è identificare aree specifiche del cervello coinvolte nelle esperienze religiose. Numerosi studi, utilizzando tecniche di neuroimaging come la risonanza magnetica funzionale (fMRI), hanno analizzato l’attività cerebrale durante la meditazione e la preghiera. Per esempio, esaminando monaci buddisti in meditazione profonda e suore cristiane durante momenti intensi di preghiera, i ricercatori hanno osservato che il cervello è attivo nel suo complesso, ma alcune regioni mostrano una maggiore sollecitazione.
Tra queste, l’area prefrontale — associata all’attenzione e alla consapevolezza — e il lobo parietale, implicato nell’orientamento spazio-temporale, sembrano giocare un ruolo chiave. Durante stati di “estasi spirituale”, il lobo parietale può mostrare una diminuzione dell’attività, fenomeno interpretato come una perdita del senso del sé e un’apertura verso una dimensione trascendente. Questi risultati suggeriscono che l’esperienza religiosa non è confinata a una singola regione cerebrale, ma emerge dall’interazione di diverse aree che modulano emozioni, cognizione e percezione.
Nonostante il fascino degli studi di neuroteologia, è importante sottolineare i rischi insiti in una spiegazione puramente scientifica della fede. Ridurre un’esperienza complessa e profondamente personale come quella religiosa a una mera attivazione neuronale rischia di impoverirne il significato. La fede non si limita a un insieme di processi cerebrali: essa coinvolge la dimensione etica, comunitaria e, per molti, il rapporto con una realtà divina trascendente.
Le neuroscienze, inoltre, devono affrontare sfide metodologiche significative. Per esempio, è difficile distinguere tra esperienze religiose autentiche e stati di coscienza alterati indotti da fattori esterni, come farmaci o stress. Il dialogo tra neuroscienze e teologia apre prospettive stimolanti, ma richiede un approccio equilibrato e rispettoso delle rispettive competenze.
Resta il fatto che l’uomo non è riducibile ai soli processi cerebrali: la sua apertura al trascendente e la ricerca di senso appartengono a una dimensione che va oltre la biologia. Tuttavia, è necessario tenere presente che, per la teologia cristiana, la fede si fonda sulla Rivelazione di Cristo, un elemento che segna una discontinuità fondamentale con il metodo scientifico.
