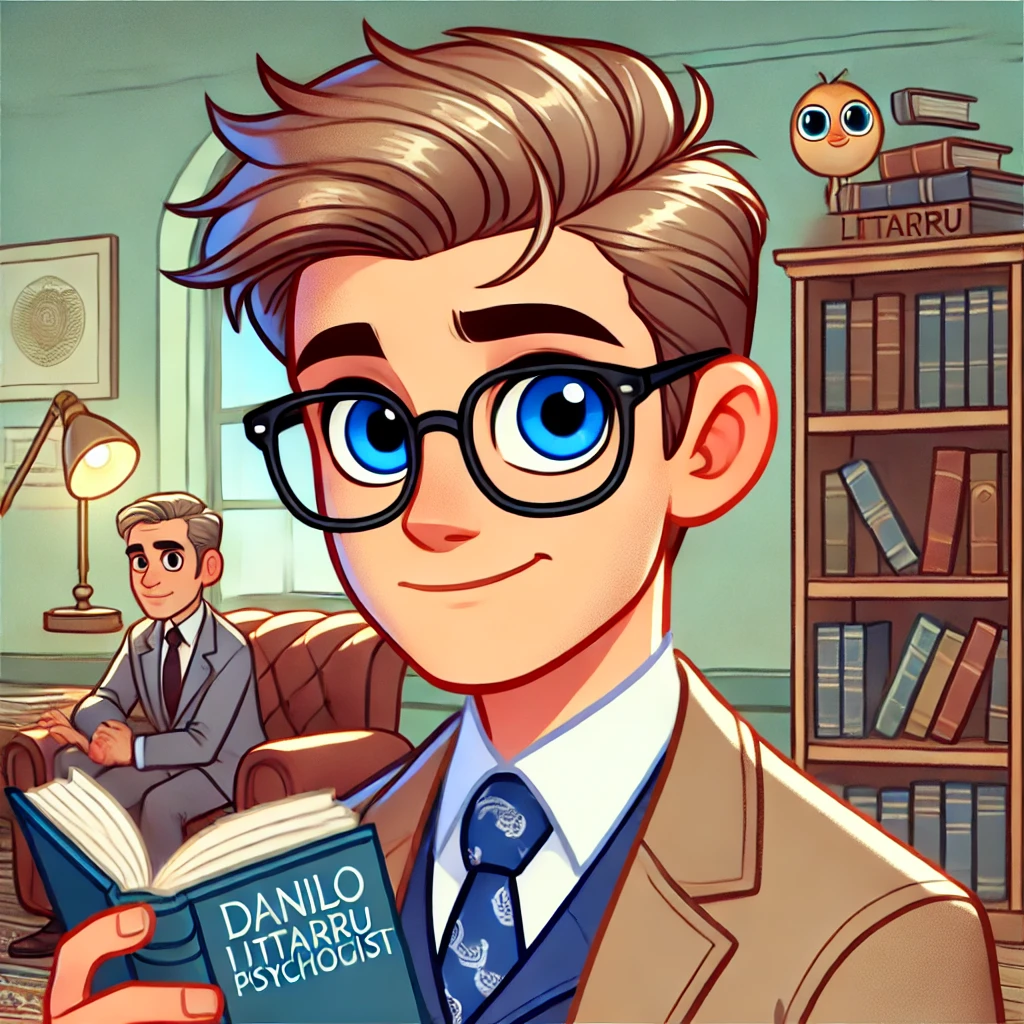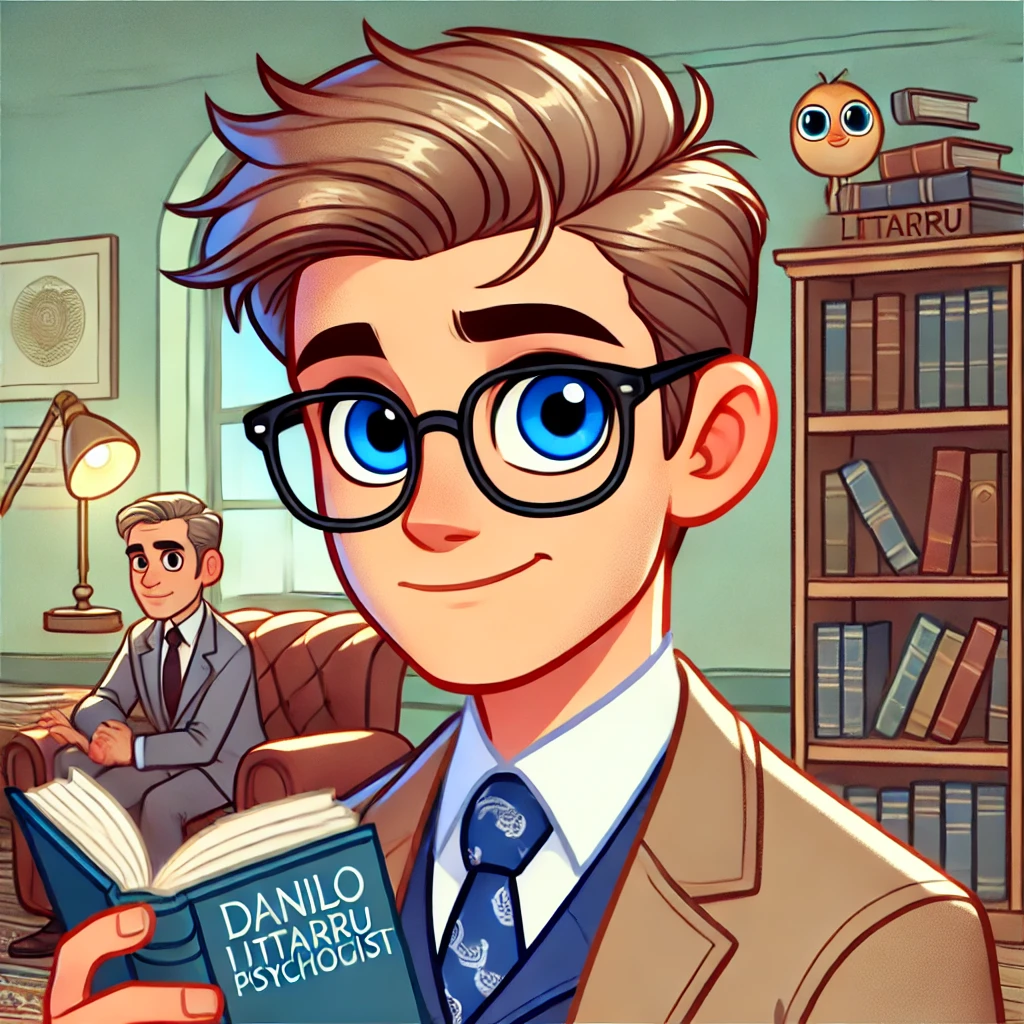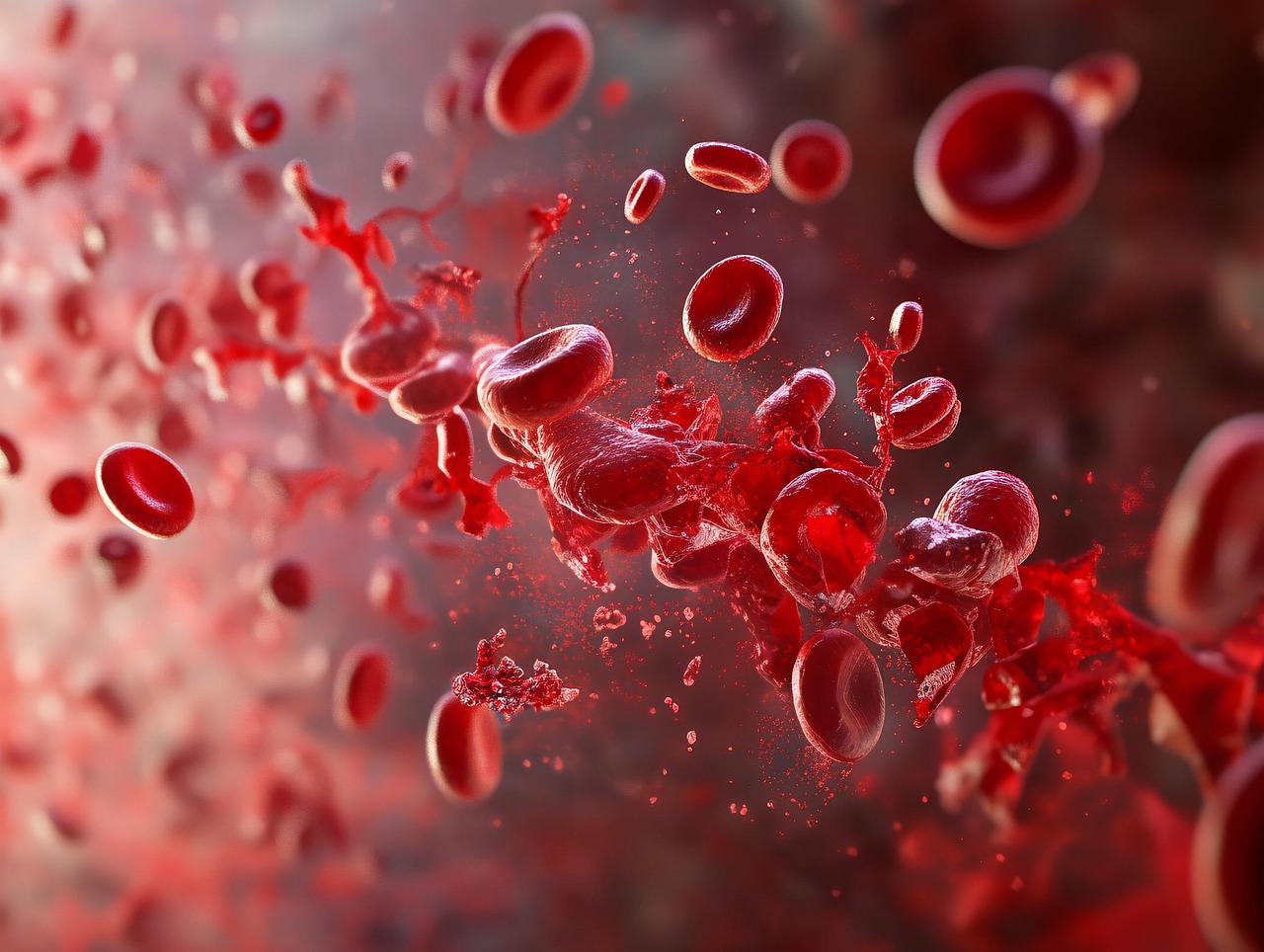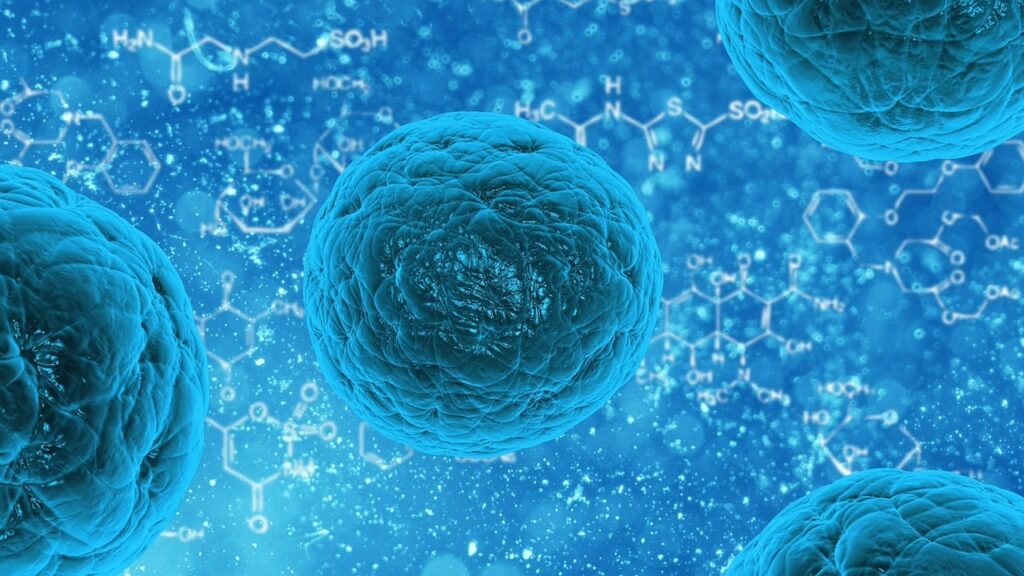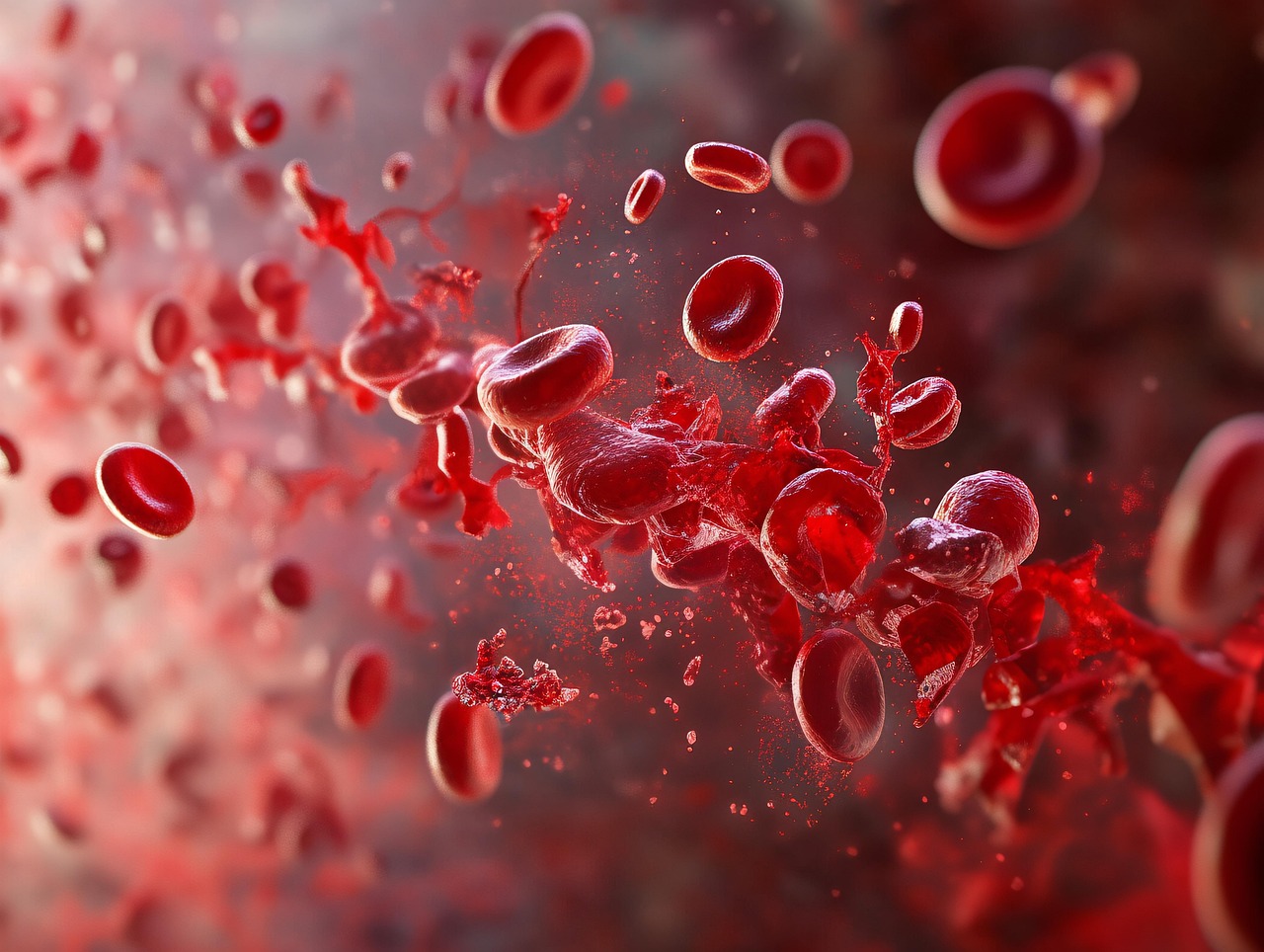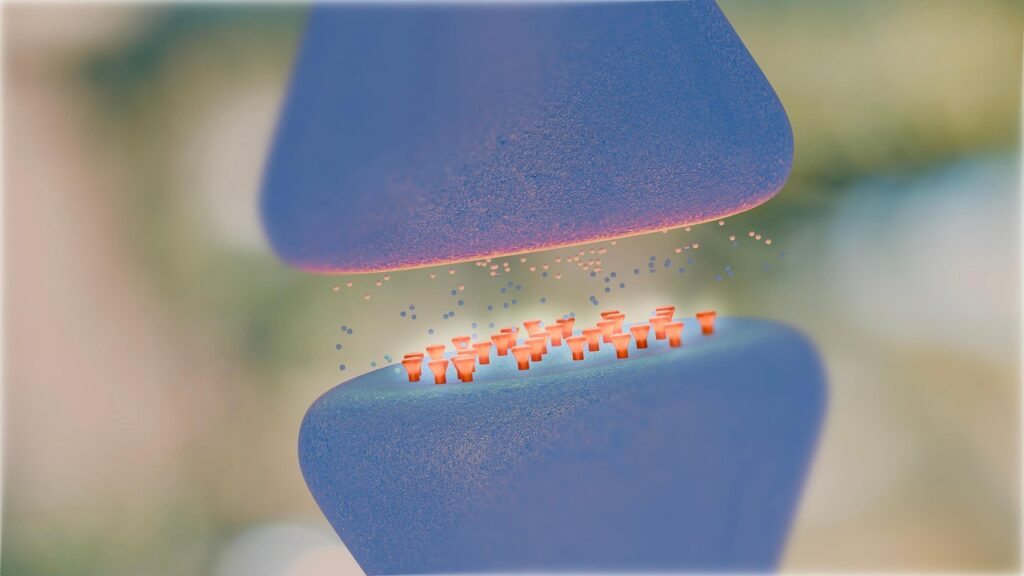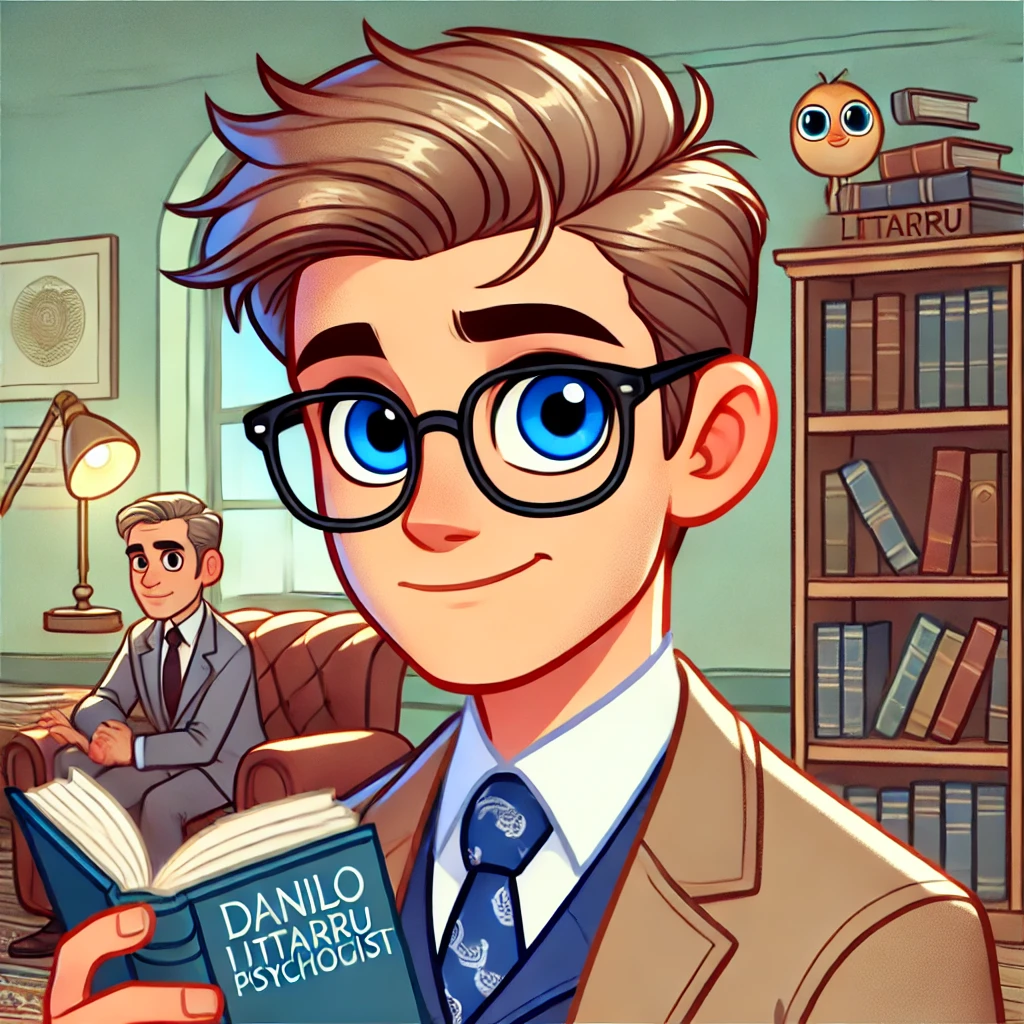L’ipocrisia educativa del nostro tempo: il vero scandalo non è il bosco, ma l’infanzia addestrata a obbedire agli algoritmi.
Introduzione
Il caso dei bambini che vivevano nel bosco ha acceso un dibattito acceso e polarizzato. La cronaca giudiziaria ha parlato di isolamento, sottrazione alla scuola e violazione dei diritti fondamentali. Ma fermarsi alla superficie rischia di produrre una riflessione sterile.
Questa vicenda interpella il nostro tempo su un piano più profondo: che idea di infanzia stiamo costruendo?
Oltre la cronaca giudiziaria: cosa dicono davvero i fatti
Negli atti giudiziari emergono elementi chiari: mancanza di istruzione formale, assenza di monitoraggio sanitario, isolamento dal contesto sociale.
Sono dati oggettivi, giuridicamente rilevanti.
Tuttavia, se ci limitiamo al formalismo, perdiamo la domanda centrale: l’educazione coincide davvero con l’inserimento forzato nei modelli dominanti?
Bambini nel bosco o bambini nello schermo?
La reazione collettiva è stata rapida e unanime: scandalo.
Eppure milioni di bambini oggi:
- non vivono nei boschi, ma trascorrono ore davanti a uno smartphone;
- non sono isolati fisicamente, ma spesso lo sono emotivamente.
L’uso precoce e massivo dei dispositivi digitali è ormai socialmente accettato, nonostante le evidenze sui rischi per lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo.
La domanda diventa allora inevitabile: è davvero più sano crescere iperconnessi che crescere fuori dagli schemi?

Educazione digitale o addestramento alla conformità?
La tecnologia non è il problema in sé.
Il problema nasce quando diventa surrogato educativo:
- sostituisce la relazione,
- anestetizza la frustrazione,
- riduce la capacità di attenzione e di pensiero critico.
Il bambino sempre connesso è spesso un bambino più gestibile, più prevedibile, più conforme.
Ma l’educazione autentica non mira alla conformità: mira alla formazione del pensiero, anche quando è scomodo.
Omologazione sociale e paura della differenza
Il bosco inquieta perché sfugge al controllo.
Lo schermo rassicura perché normalizza.
La società contemporanea tollera poco ciò che non è immediatamente classificabile, monitorabile, standardizzabile.
Il caso dei bambini nel bosco diventa così uno specchio: ci indigniamo per l’eccezione, ma ignoriamo la norma quando la norma impoverisce l’umano.
Una responsabilità collettiva
La magistratura ha il dovere di intervenire quando i diritti vengono violati.
Ma la comunità adulta ha un dovere ancora più grande: interrogarsi sui modelli educativi che considera “normali”.
Prima di puntare il dito, dovremmo chiederci:
- quanto spazio diamo alla relazione reale?
- quanto tempo concediamo alla noia creativa?
- quanto stiamo delegando l’educazione agli algoritmi?
Conclusione
I bambini nel bosco non sono solo un fatto di cronaca.
Sono una domanda aperta sul nostro modo di intendere l’infanzia, l’educazione e la libertà di crescita.
Forse il vero scandalo non è chi ha tentato una fuga radicale dal sistema,
ma un sistema che non ammette alternative e chiama integrazione ciò che spesso è solo omologazione.