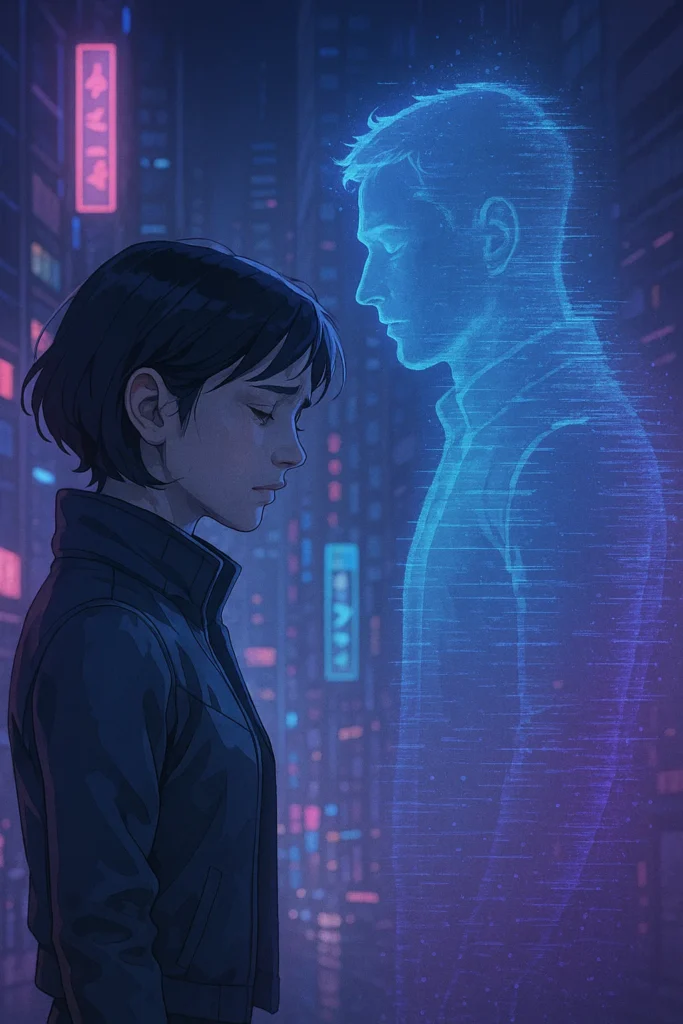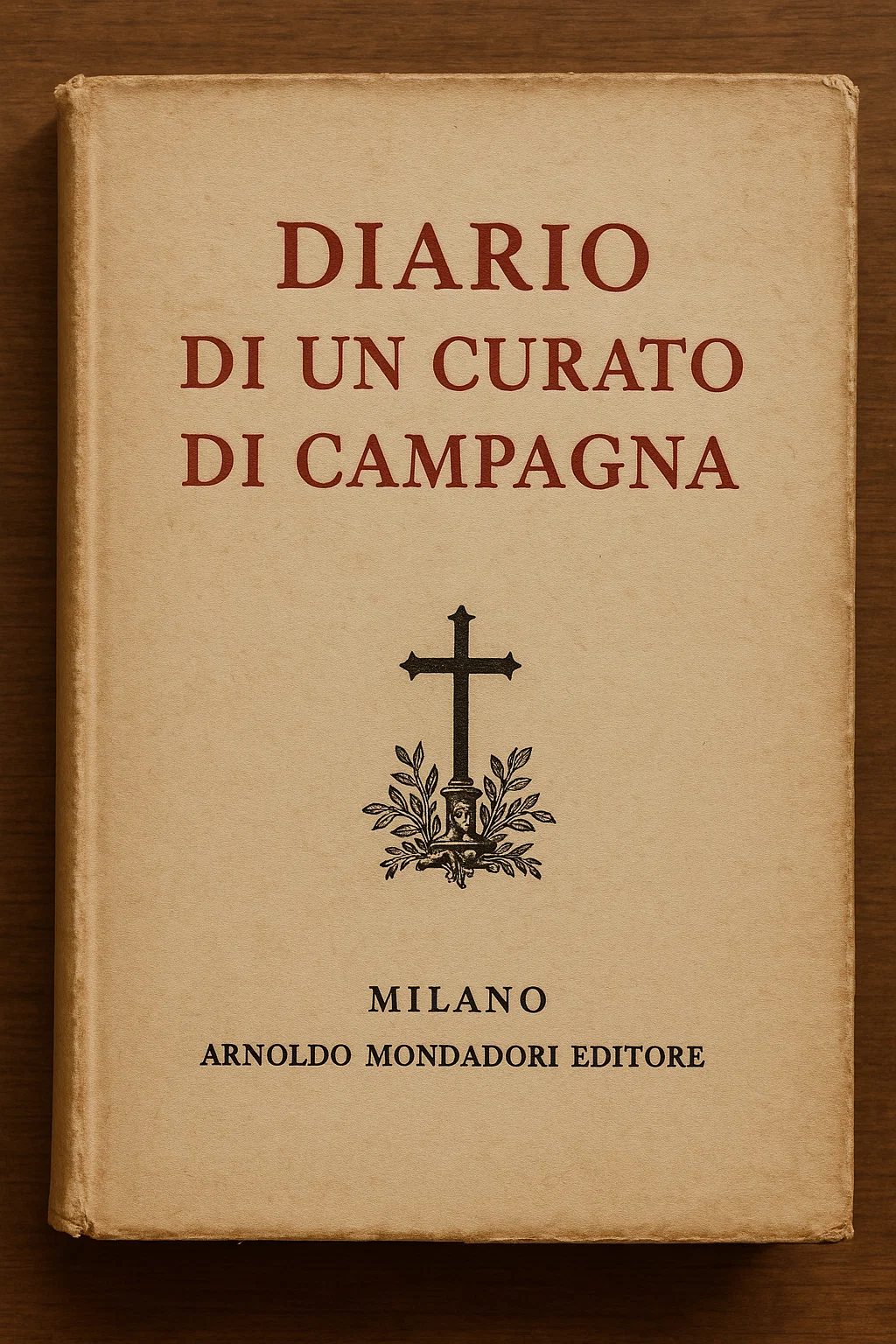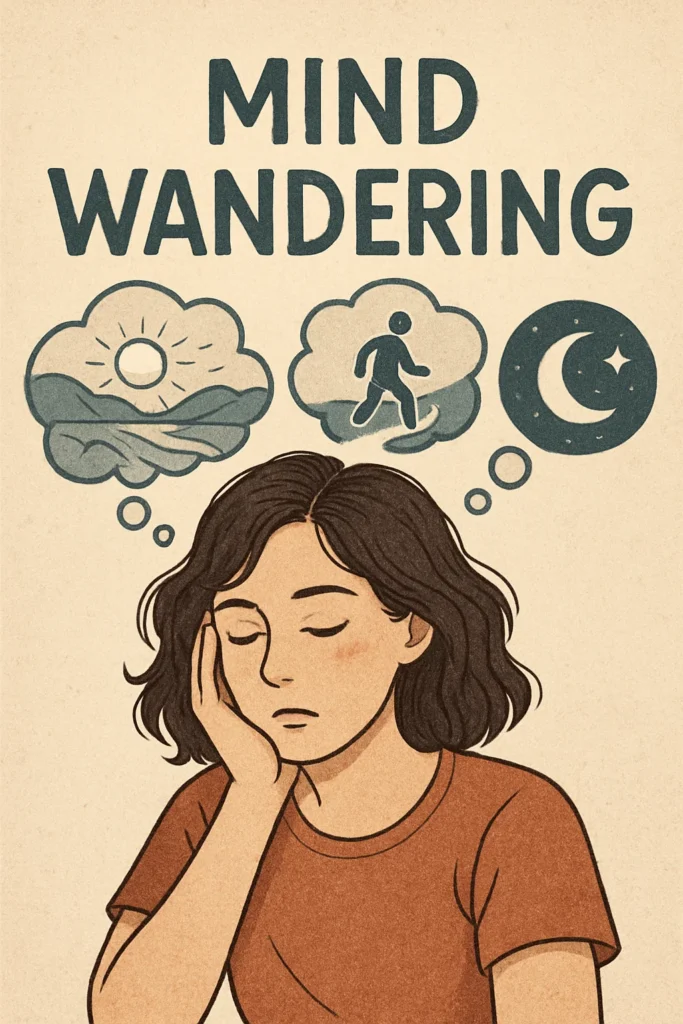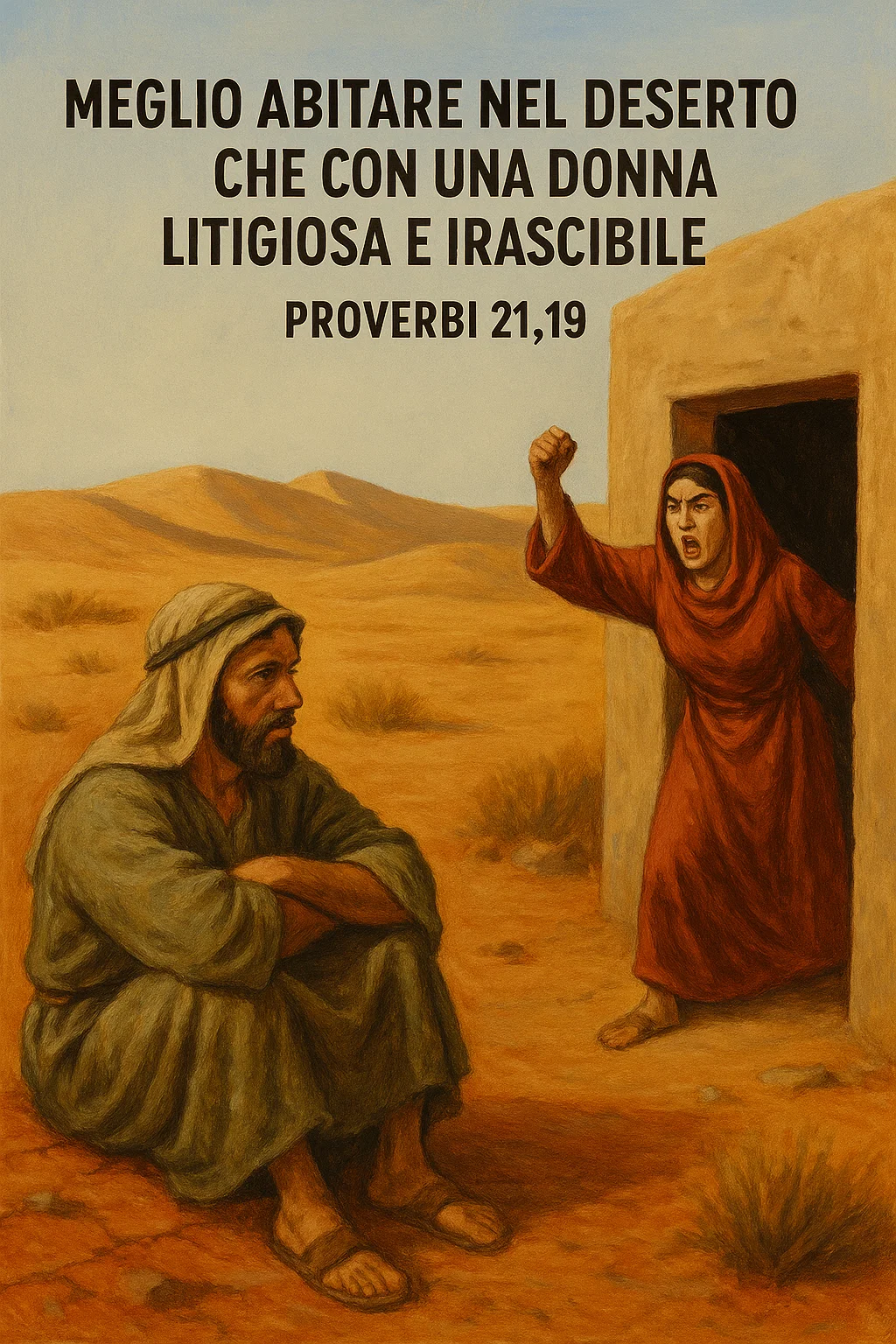La clinica di un’emozione che attraversa i secoli.
Che cos’è la nostalgia?
La nostalgia è un’emozione complessa, un intreccio di dolore e desiderio che accompagna l’essere umano sin dall’antichità. Il termine fu introdotto nel 1688 dal medico alsaziano Johannes Hofer, che la descrisse come una vera e propria malattia dei soldati svizzeri lontani da casa. Deriva dal greco nóstos (ritorno) e álgos (dolore): “dolore per il ritorno”.
All’epoca era considerata una sindrome clinica caratterizzata da malinconia, insonnia e perdita di appetito. Oggi non compare più nei manuali diagnostici come il DSM-5 o l’ICD-11, ma resta un’esperienza psicologica di grande interesse.
Evoluzione clinica e storica
Nel corso dei secoli la nostalgia ha mutato la sua collocazione:
- XVII-XVIII secolo: malattia dei migranti, degli studenti e dei soldati.
- XIX secolo: assimilata alla malinconia e ai disturbi depressivi.
- XX-XXI secolo: considerata emozione universale, non patologica ma ambivalente.
Come ricorda lo psichiatra americano Clay Routledge, “la nostalgia è un ponte che unisce passato, presente e futuro, dando continuità al senso del Sé”.
Cosa significa provare nostalgia
Clinicamente e psicologicamente, la nostalgia comporta:
- Dolore per l’assenza: la mancanza di luoghi, persone o tempi perduti.
- Desiderio di ritorno: il sogno di rivivere un contesto ormai passato.
- Funzione identitaria: il ricordo nostalgico aiuta a sentirsi radicati, rafforza la continuità della propria storia.
Gli studi di Wildschut e Sedikides (2006) hanno evidenziato che la nostalgia può avere anche un ruolo positivo: favorisce la resilienza, incrementa l’autostima e riduce la solitudine.

Nostalgia tra dolore e risorsa
Se nel passato era letta come un limite, oggi la nostalgia viene vista anche come risorsa psicologica. Lungi dall’essere un ostacolo, può trasformarsi in:
- ancoraggio affettivo, quando le relazioni odierne sono fragili;
- stimolo creativo, come mostrano letteratura, arte e musica;
- strumento di resilienza, capace di ridare senso nei momenti di crisi.
Conclusione
Provare nostalgia significa dunque sperimentare la dolceamara tensione tra assenza e memoria. È il dolore del tempo che scorre, ma anche la capacità dell’anima di custodire ciò che ci ha reso vivi.
Come scrive Milan Kundera: “La nostalgia non è il desiderio di ritornare, ma di ritrovare ciò che ha dato senso alla vita.”