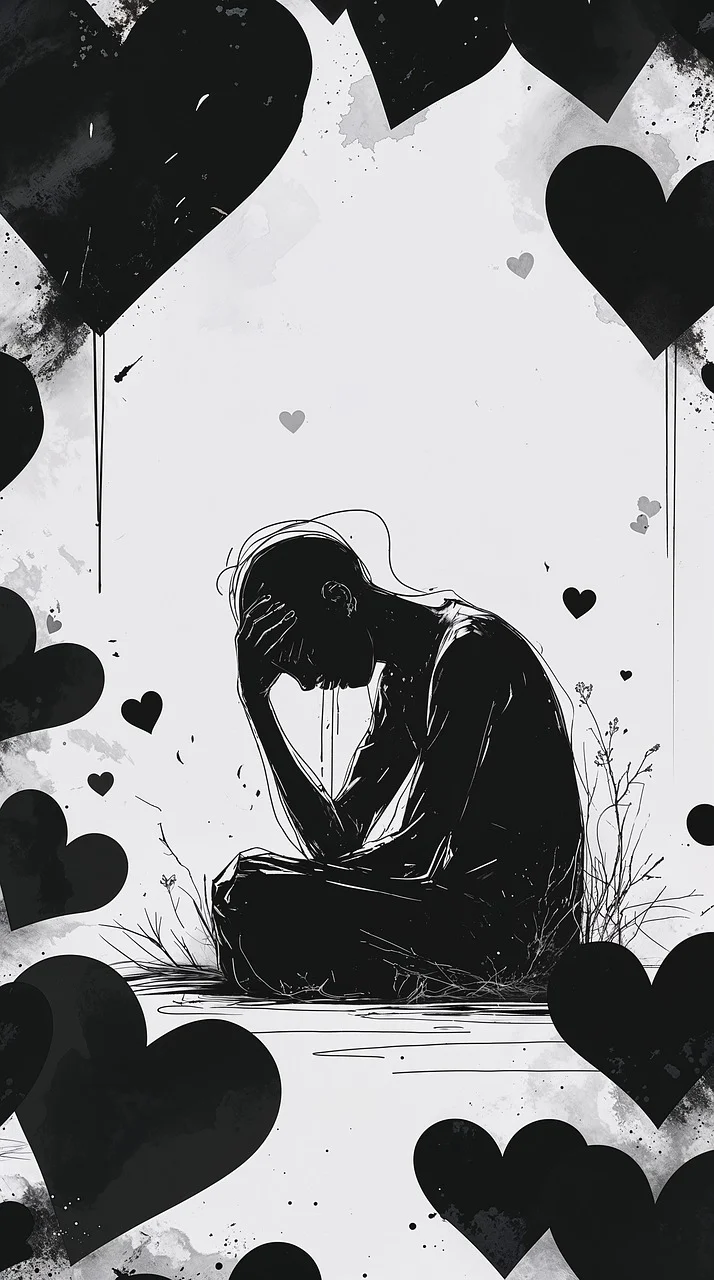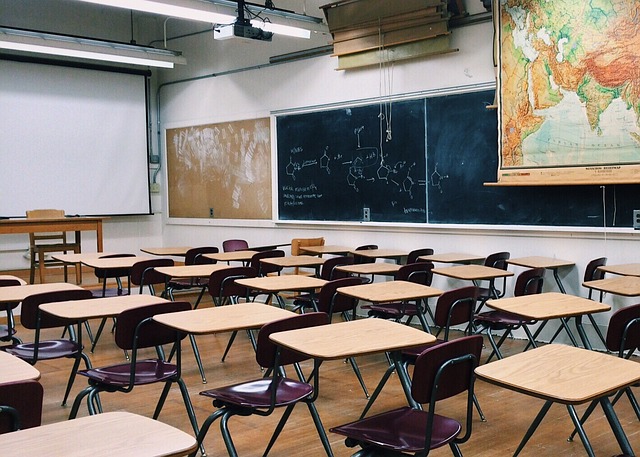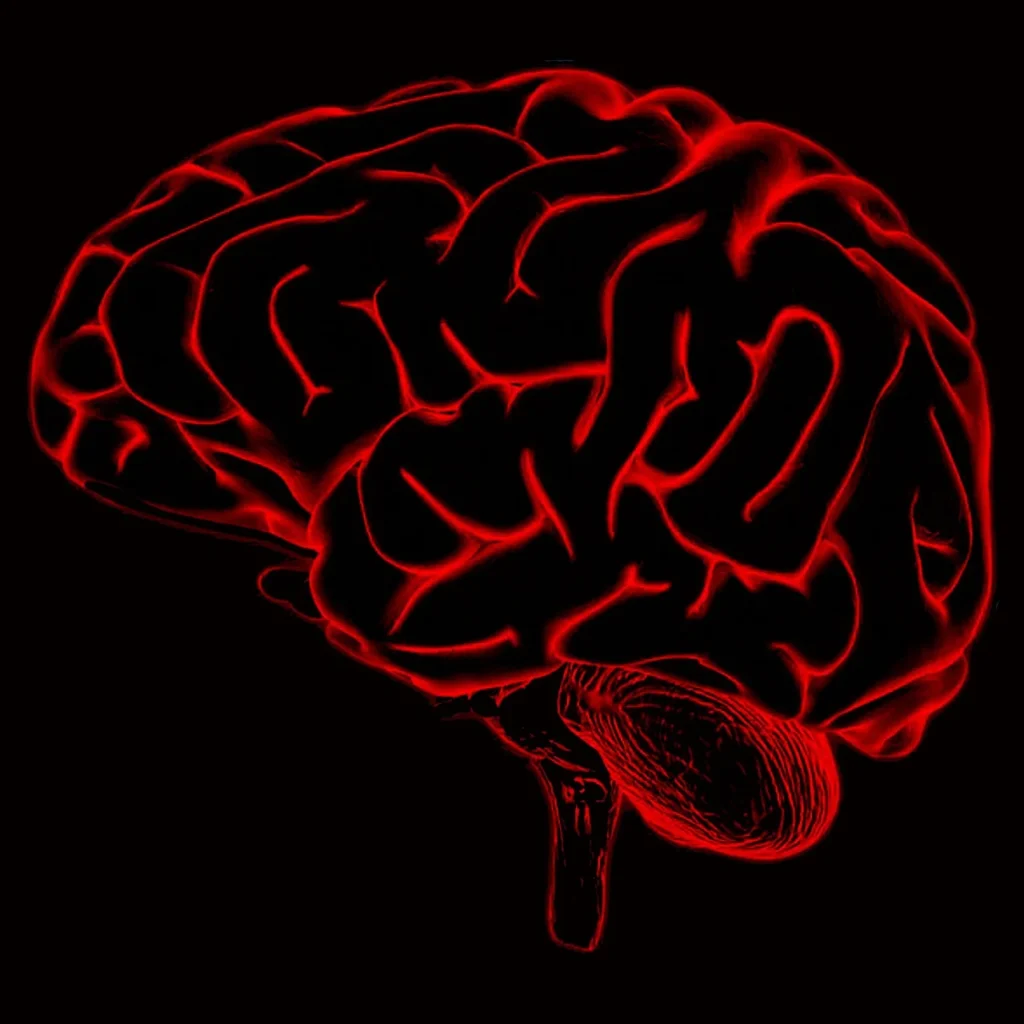Egregio Dottore, sono sposata da decenni e da sempre vivo nel sospetto quotidiano che mio marito mi tradisca nonostante non abbia prove tangibili.Non riesco a controllare la gelosia, è un pensiero costante che mi fa vivere male. Mi aiuti a capire cosa potrei fare. Grazie. P.M.
Ogni volta che mi pongono domande sulla gelosia, mi torna alla mente il meraviglioso libro di Roland Barthes “Frammenti di un discorso amoroso”, che in un passaggio illuminante recita: Come geloso, io soffro quattro volte: perché sono geloso, perché mi rimprovero di esserlo, perché temo che la mia gelosia finisca col ferire l’altro, perché mi lascio soggiogare da una banalità: soffro di essere escluso, di essere aggressivo, di essere pazzo e di essere come tutti gli altri.
Immagino, pertanto, il turbinio di pensieri e di sofferenza che porta dentro, ma con un punto a suo vantaggio: è consapevole dell’irruenza sproporzionata della gelosia nei confronti di suo marito. Il passaggio da un normale sentimento umano che può avere momenti di accentuazione ad uno patologico, che arriva a cambiare gli assetti di coppia e vivere un disagio quotidiano diventa centrale nella comprensione del problema. La psicologia ha speso pagine importanti in merito, facendo ricorsi letterali, storici e religiosi: Otello che uccise l’amata Desdemona convinto che l’avesse tradito con Cassio, la Bibbia racconta la gelosia tra i fratelli Caino e Abele, facendoci riflettere sul fatto che dinanzi alla conquista di un primato, anche un fratello può essere ucciso.
La psicologia della gelosia è poliedrica e contorta, frutto di meccanismi che richiamano le radici della nostra storia personale, in continuum che lega passato e presente, l’oggi con l’ieri, in un fil rouge, fatto di distacchi, delusioni, lacerazioni che ci riporta ai legami e alle relazioni primarie affettive, quando nell’infanzia, in maniera sistemica e duratura, si viene privati di cure e attenzioni e dal fondamentale bisogno d’affetto e consolazione.
Le radici della gelosia, vanno ricercate, pertanto, in quel sentimento arcaico, che ognuno di noi sperimenta fin dalle origini, quando le figure genitoriali, in un atteggiamento ipercritico nei confronti del figlio, lo fanno sentire manchevole, inadeguato, privo di qualità, poco amabile, generando la convinzione che non sarà mai oggetto di attenzione e cura, privandolo di sicurezza e autostima. Il ruvido distacco dalla famiglia e il mancato rafforzamento dell’autostima, avrà ricadute importanti nella vita relazionale e sentimentale adulta. La costante paura di perdere l’altro, ha origine dalla frustrazione di non sentirsi unici ed esclusivi, e in una lettura fuorviante, si vive l’altro come una proprietà di cui si ha il pieno possesso.

Il sentimento “geloso”, si rafforza quando si vive la paura di un cedimento narcisistico che porta a perdere il controllo, perché si sperimenta la fragilità di non sentirsi per l’altro, unico e insostituibile. Lasciarsi in balia di questo pensiero martellante, comporta il rischio di passare sul versante patologico. La gelosia patologica può essere inquadrata in tre grandi gruppi distinti in base alle caratteristiche formali delle idee di gelosia. In scala gerarchica sono: la gelosia ossessiva, la gelosia iperestesia o sindrome di Mairet e la gelosia delirante o sindrome di Otello.
In quest’ultima, le immagini e le idee di infedeltà sono irrefrenabili e il dubbio sull’infedeltà del partner, diventa centrale; un dubbio lacerante che diventa un tarlo silenzioso che agisce nella quotidianità.
Chi ne soffre è continuamente alla ricerca di segnali che possano dimostrarlo o lenirlo. Nella gelosia iperestesia o sindrome di Mairet si delinea un quadro clinico di confine tra normalità e patologia in cui le idee prevalenti hanno una forte componente affettiva, arrivando ad occupare tutto il campo esperienziale del paziente, intaccando perfino la sfera lavorativa e le relazioni sociali. Il fraintendimento che genera la gelosia ha necessità di essere eterodiretto verso tangenti differenti, che sappiano trovare una sintesi equilibrata tra il saper-amare-l’altro e il rispetto della sua persona, senza arrogarsi, indebitamente, il diritto di privarla della sua libertà. L’abbraccio soffocante non premia, l’eccessivo controllo procura una asfissia letale del rapporto sentimentale. Amare non significa fare del rapporto una prigione d’amore.
Un amore non geloso può aprire le porte ad un amore sano. Pensi ad un percorso psicoterapico, che sarà valido aiuto per comprendere i contorni della sua gelosia e al contempo per razionalizzare il suo problema, gestendo al meglio l’ansia nel relazionarsi al partner.