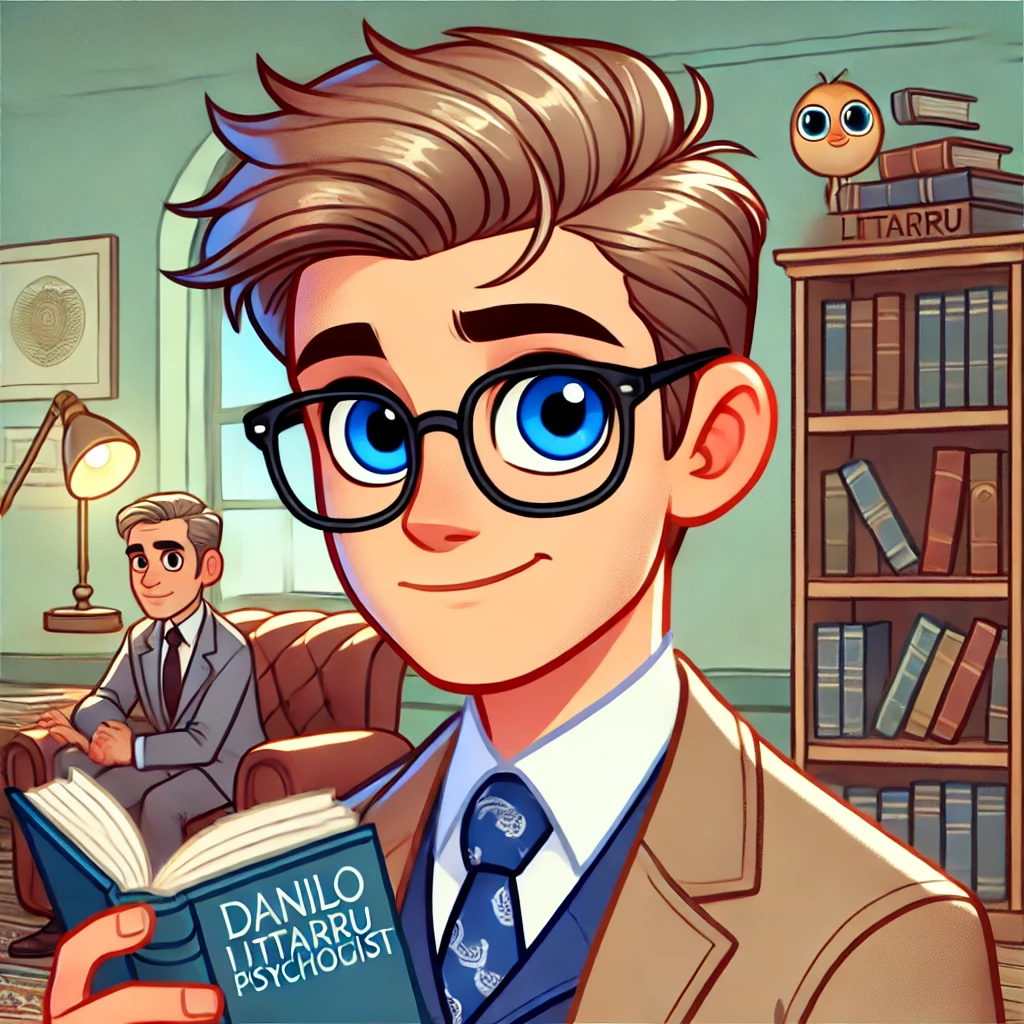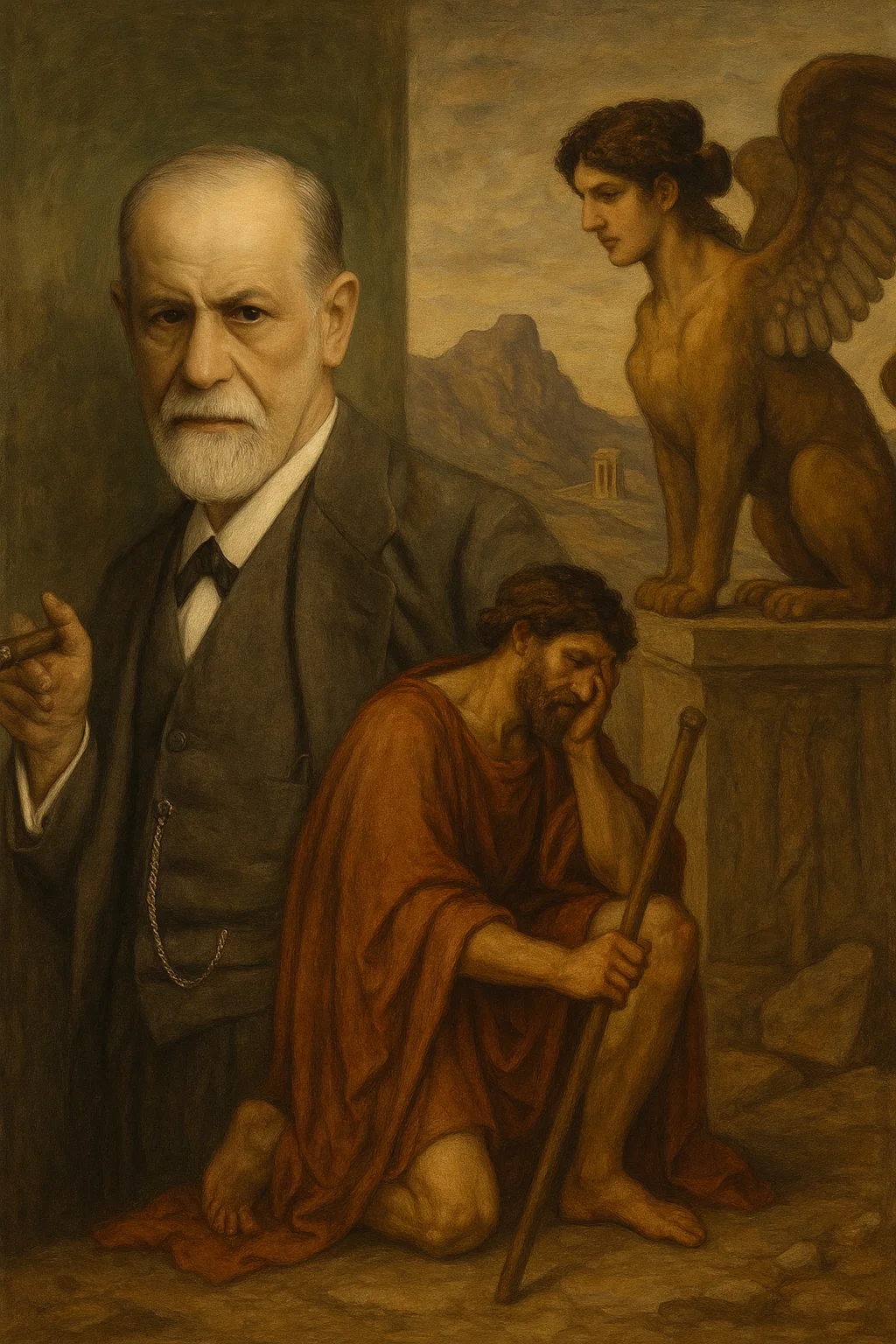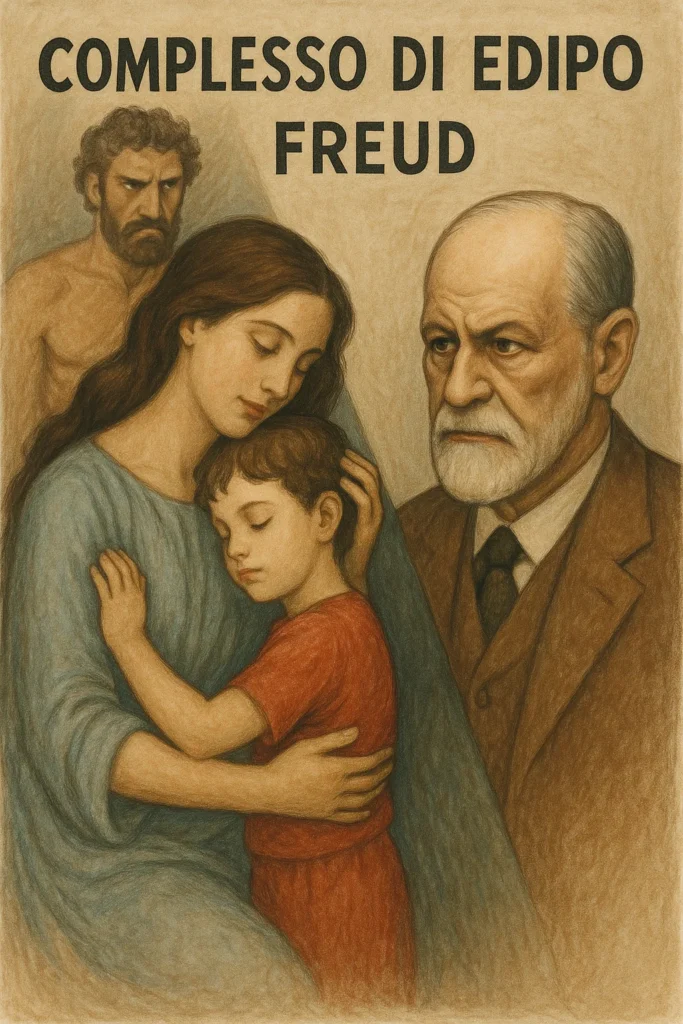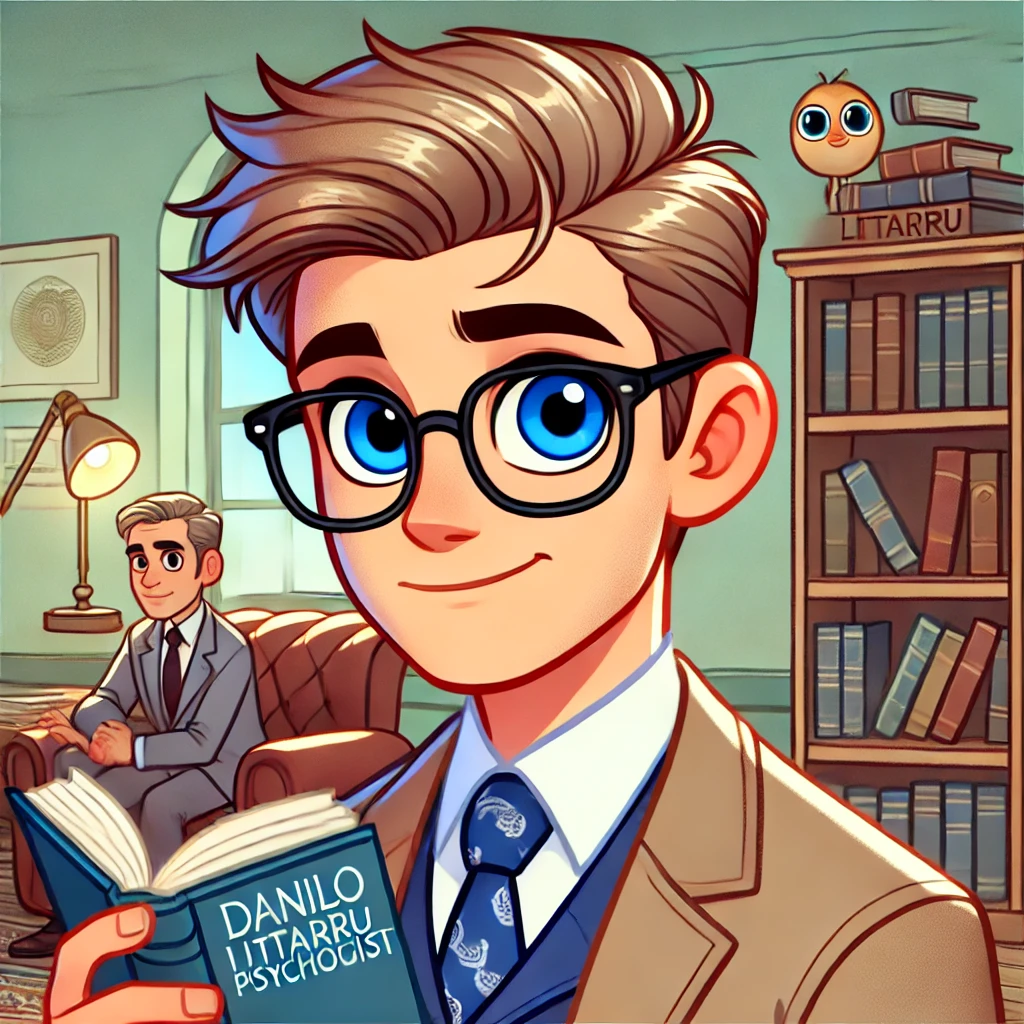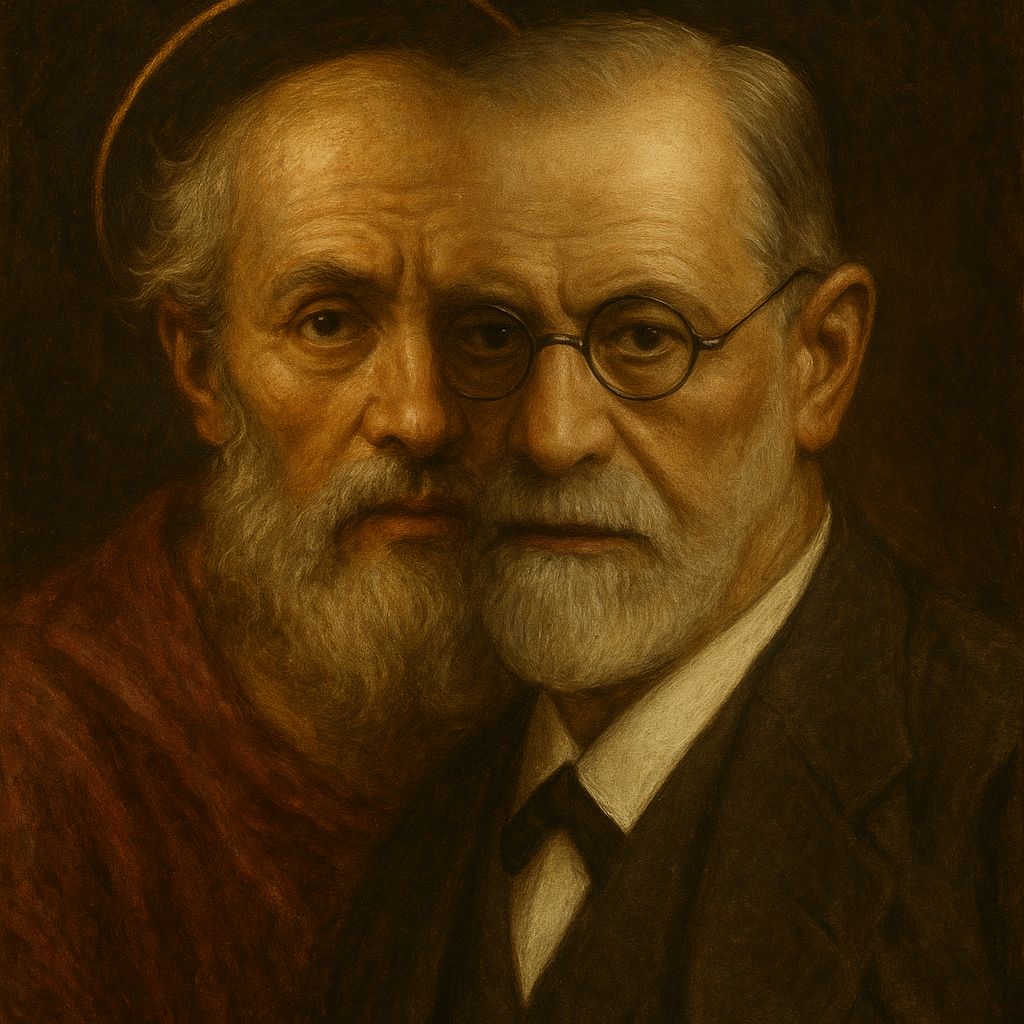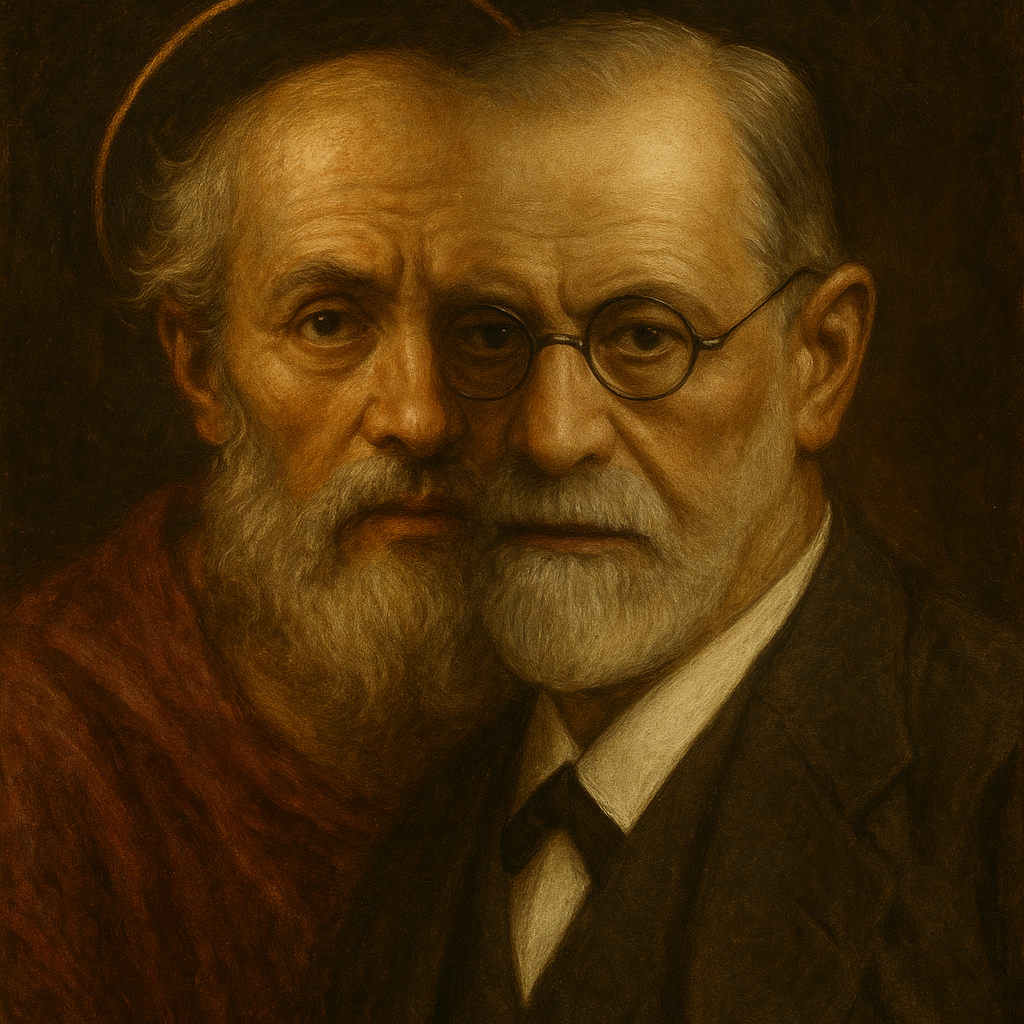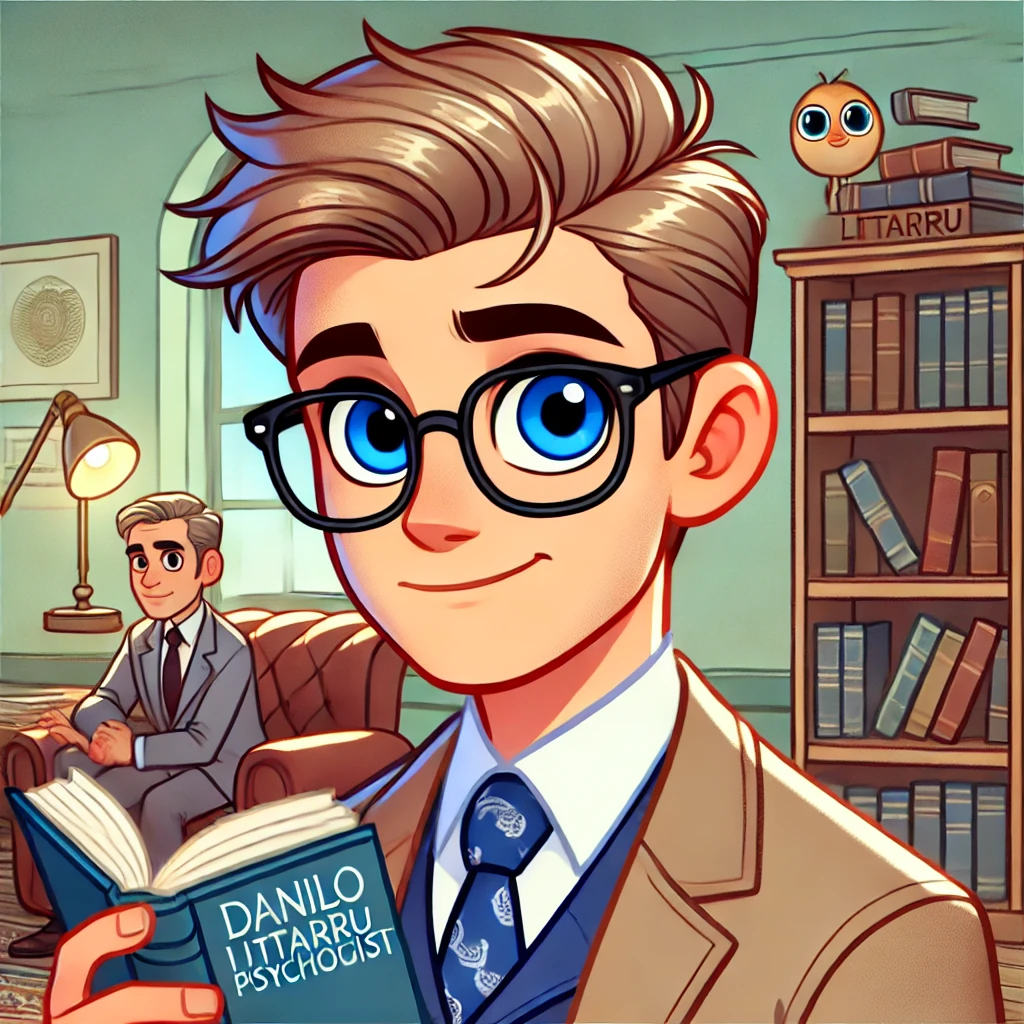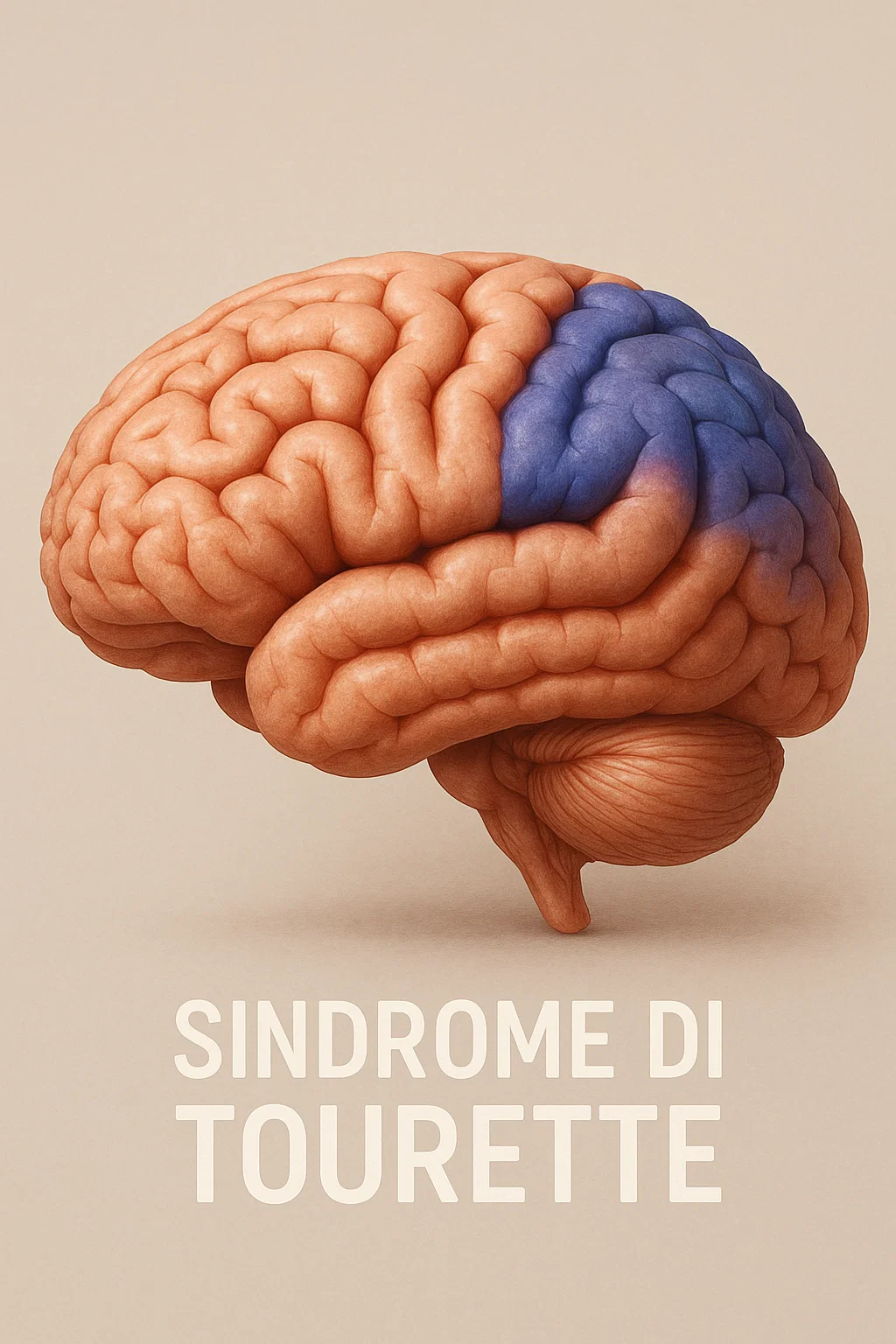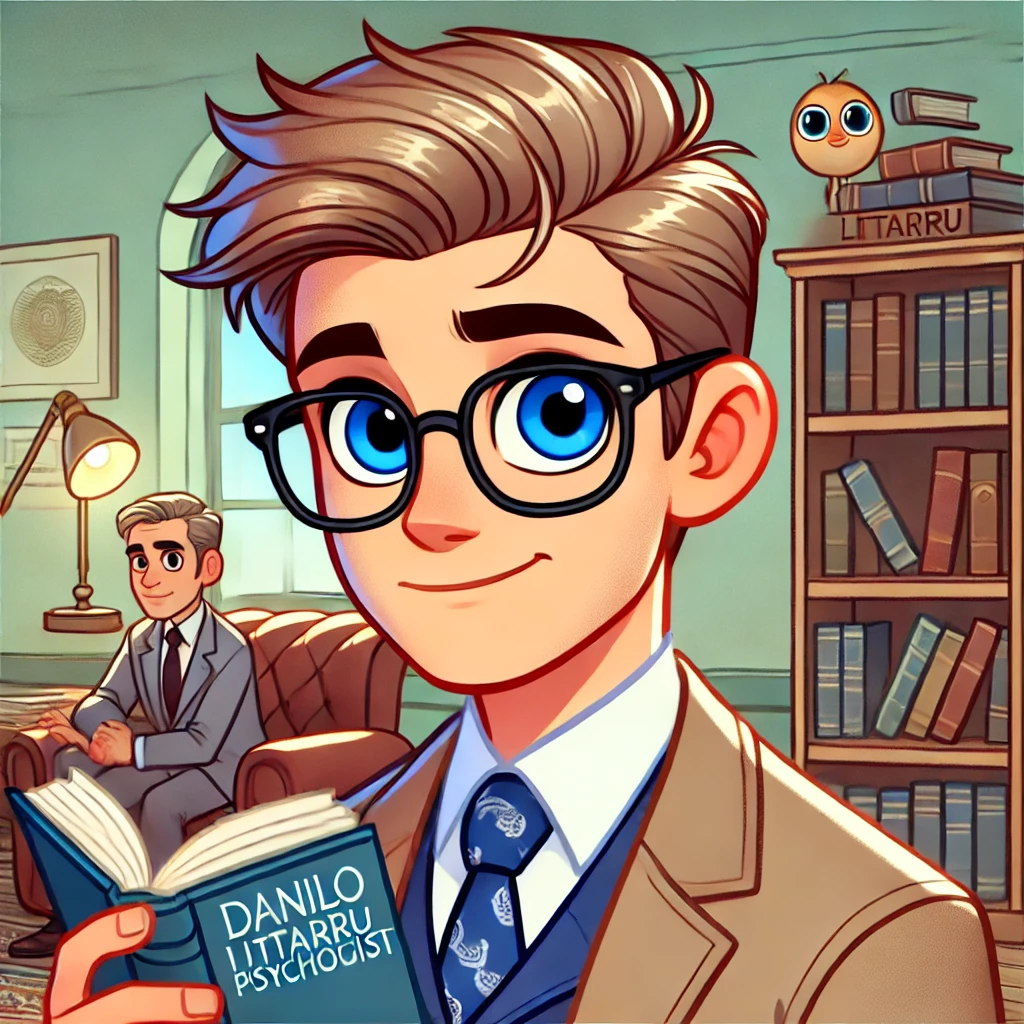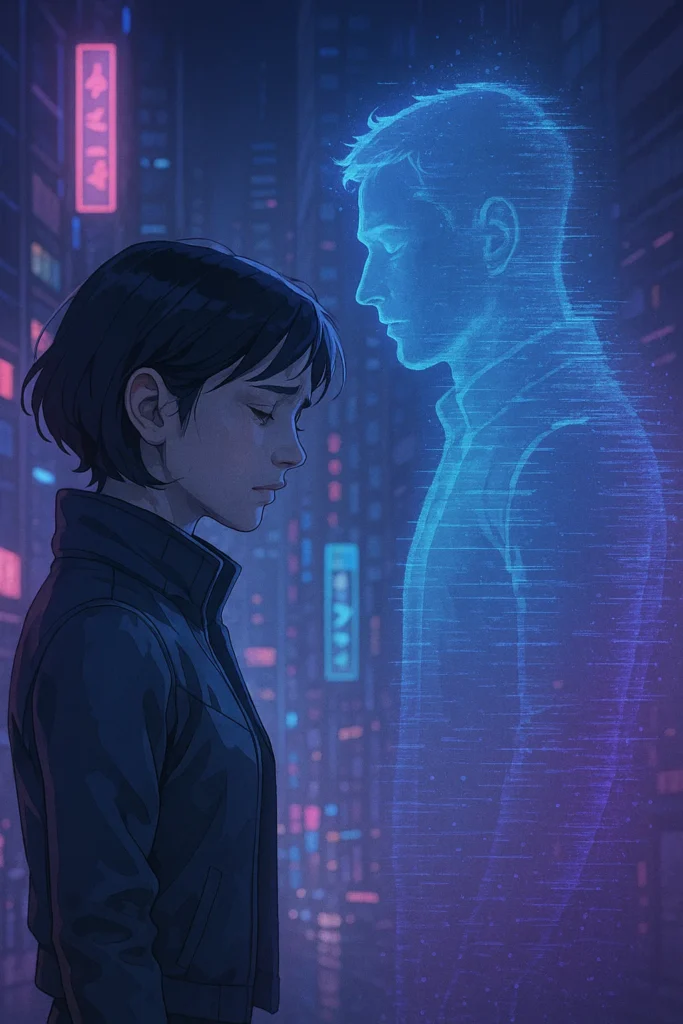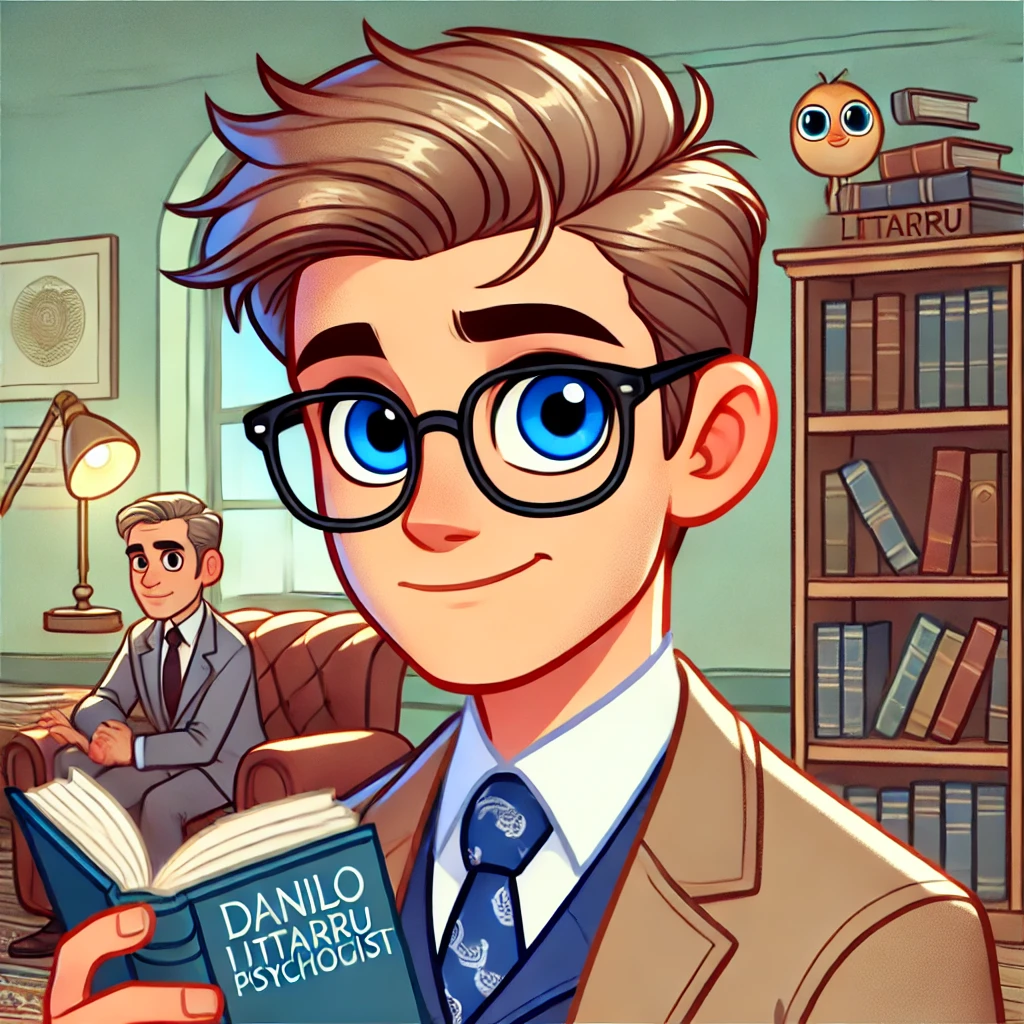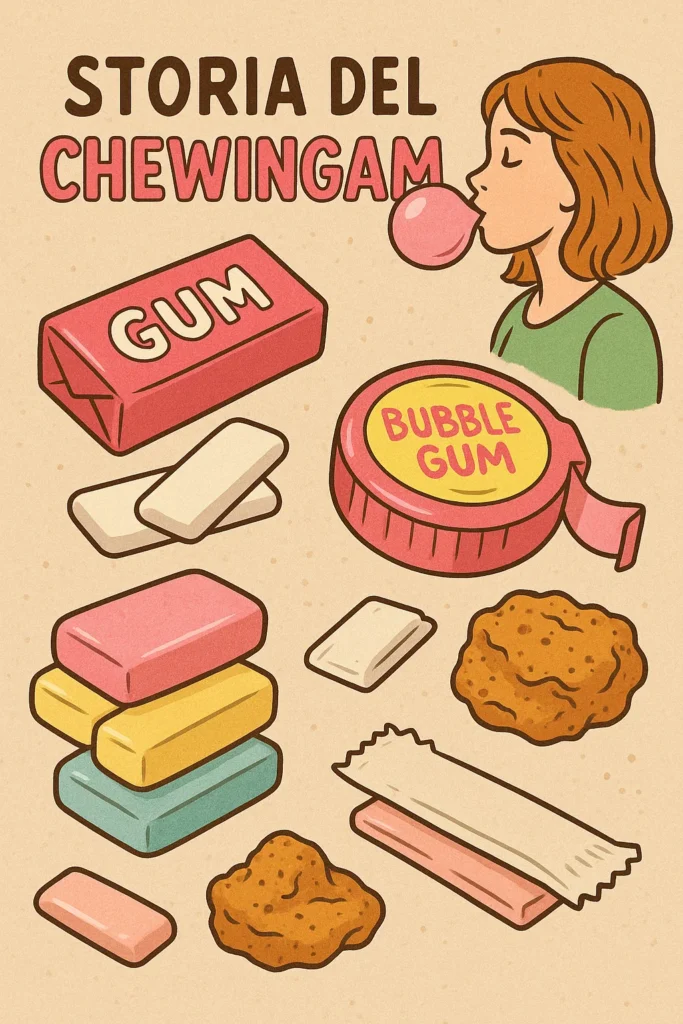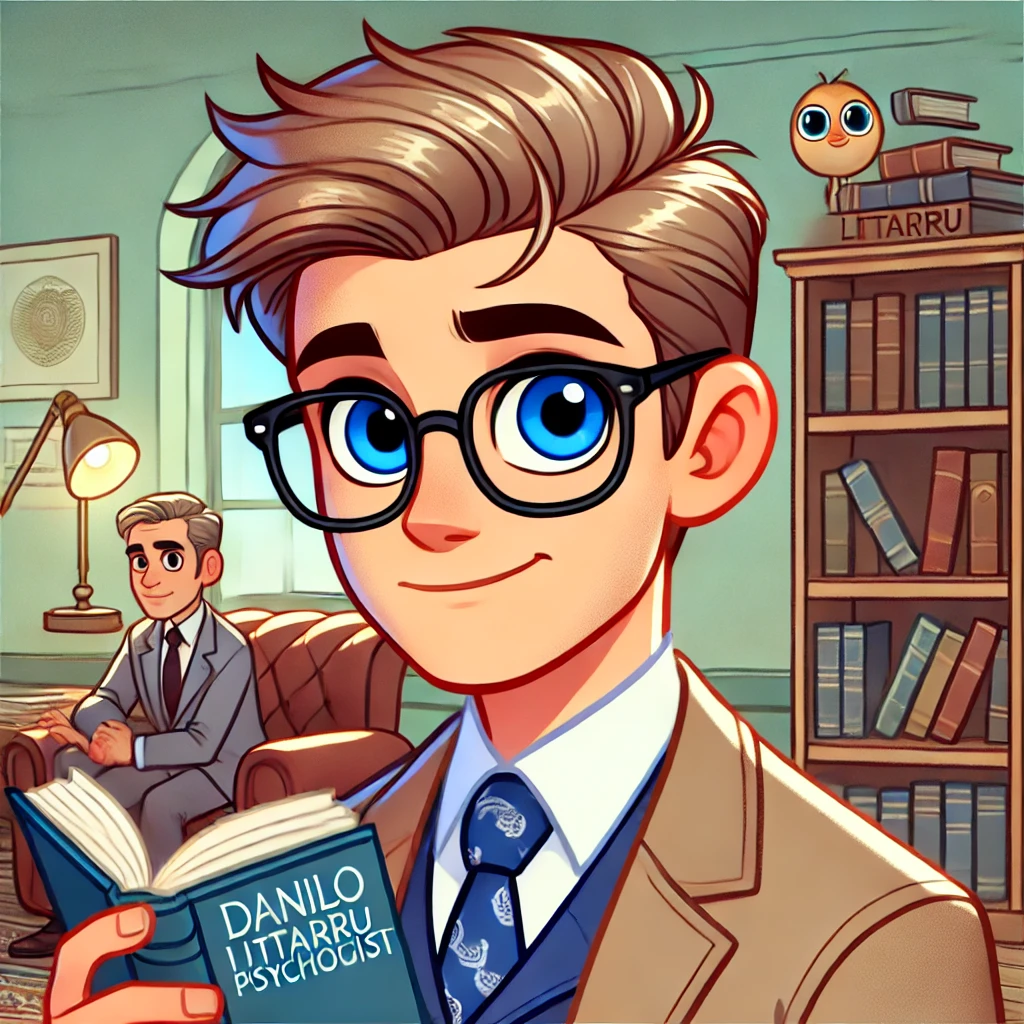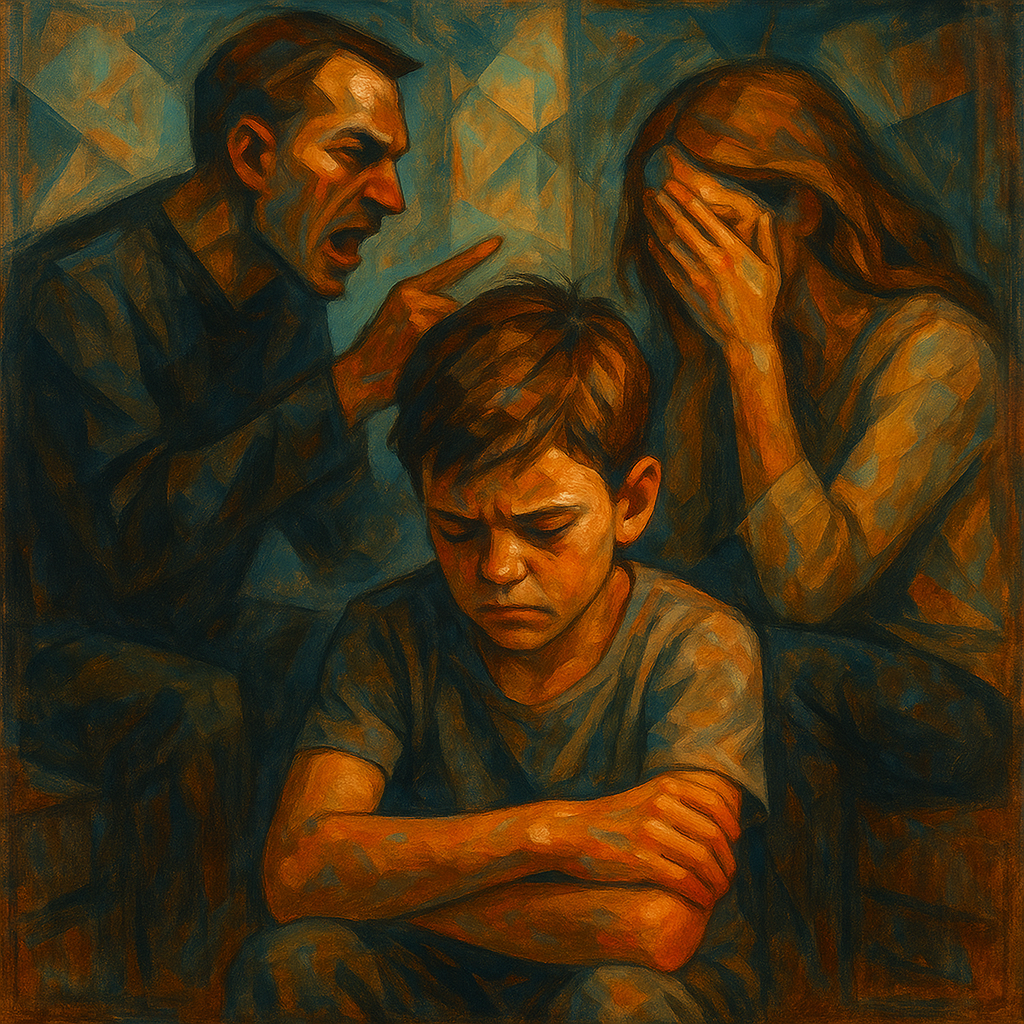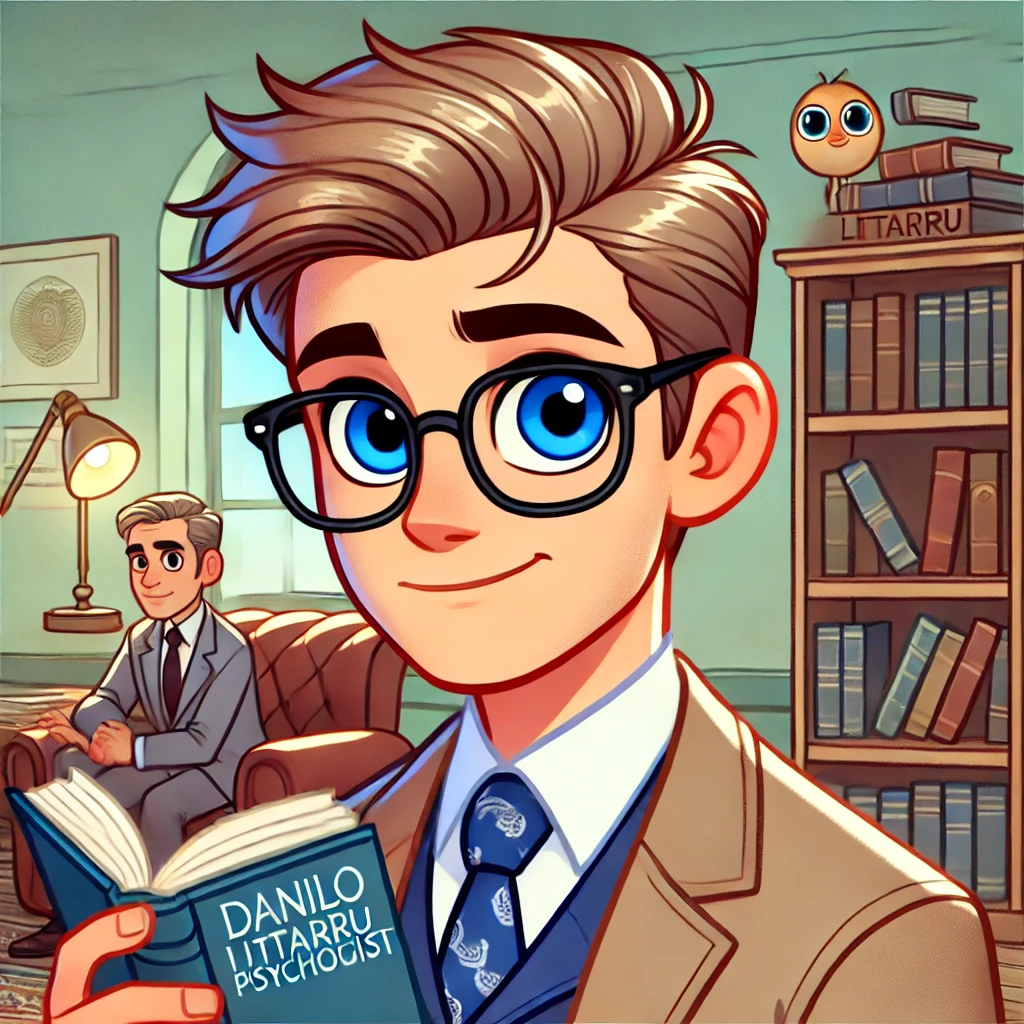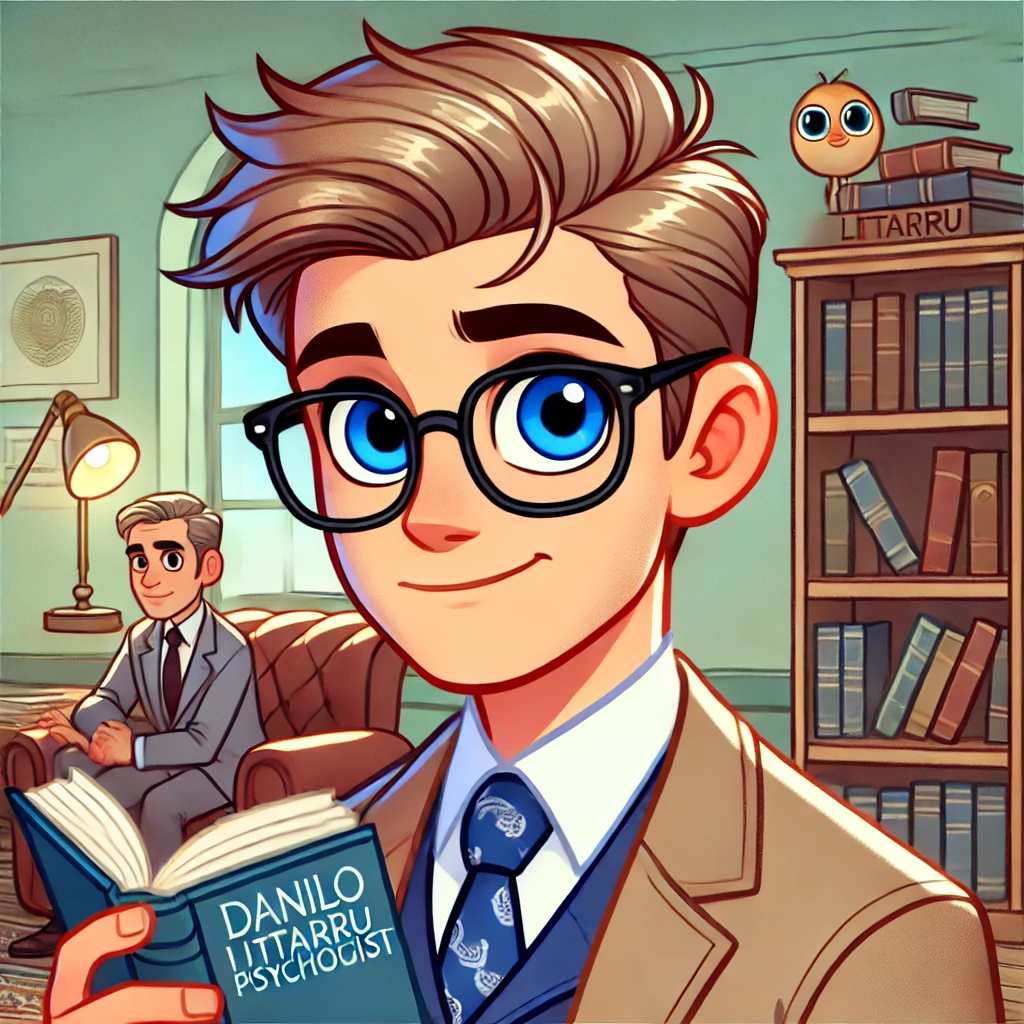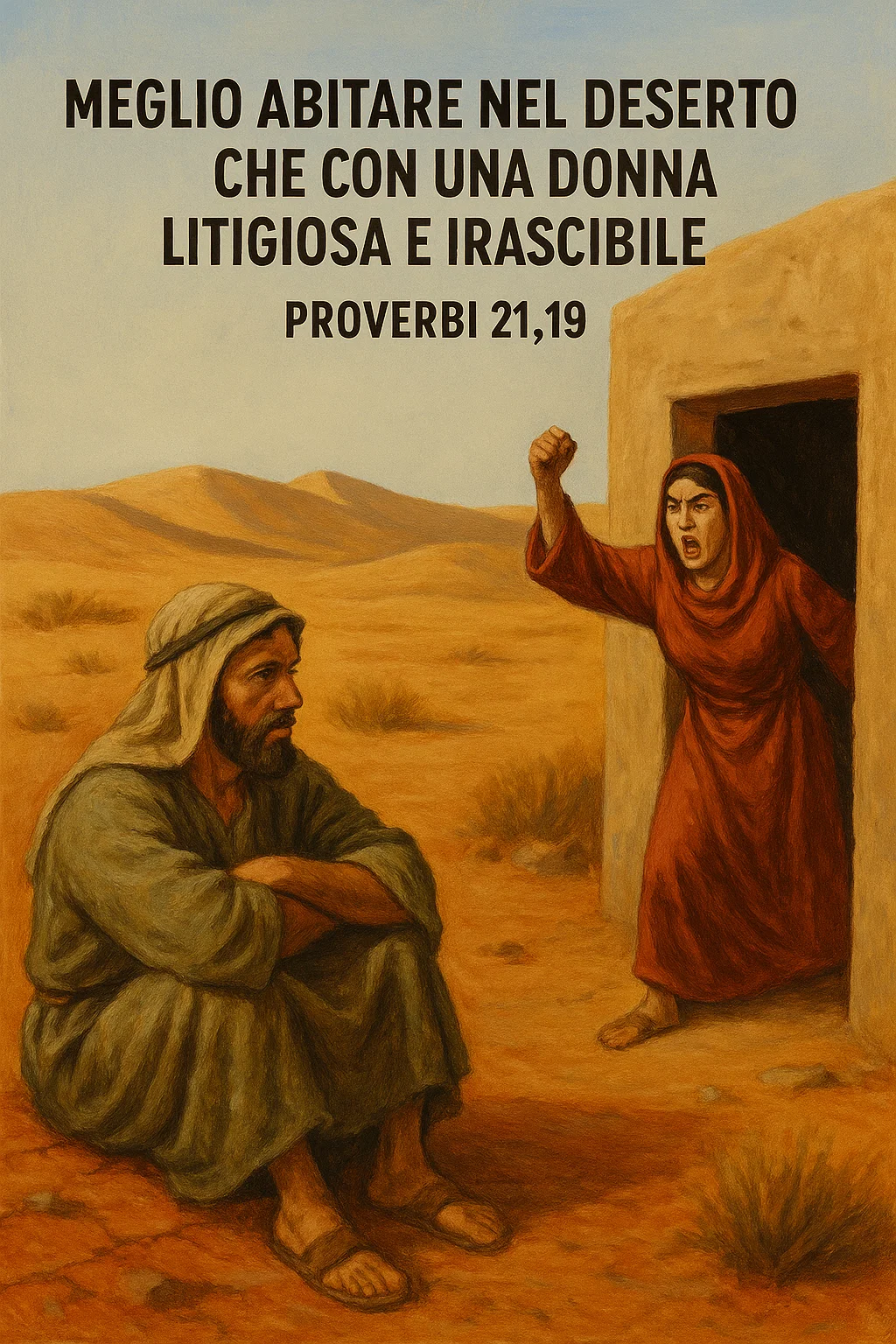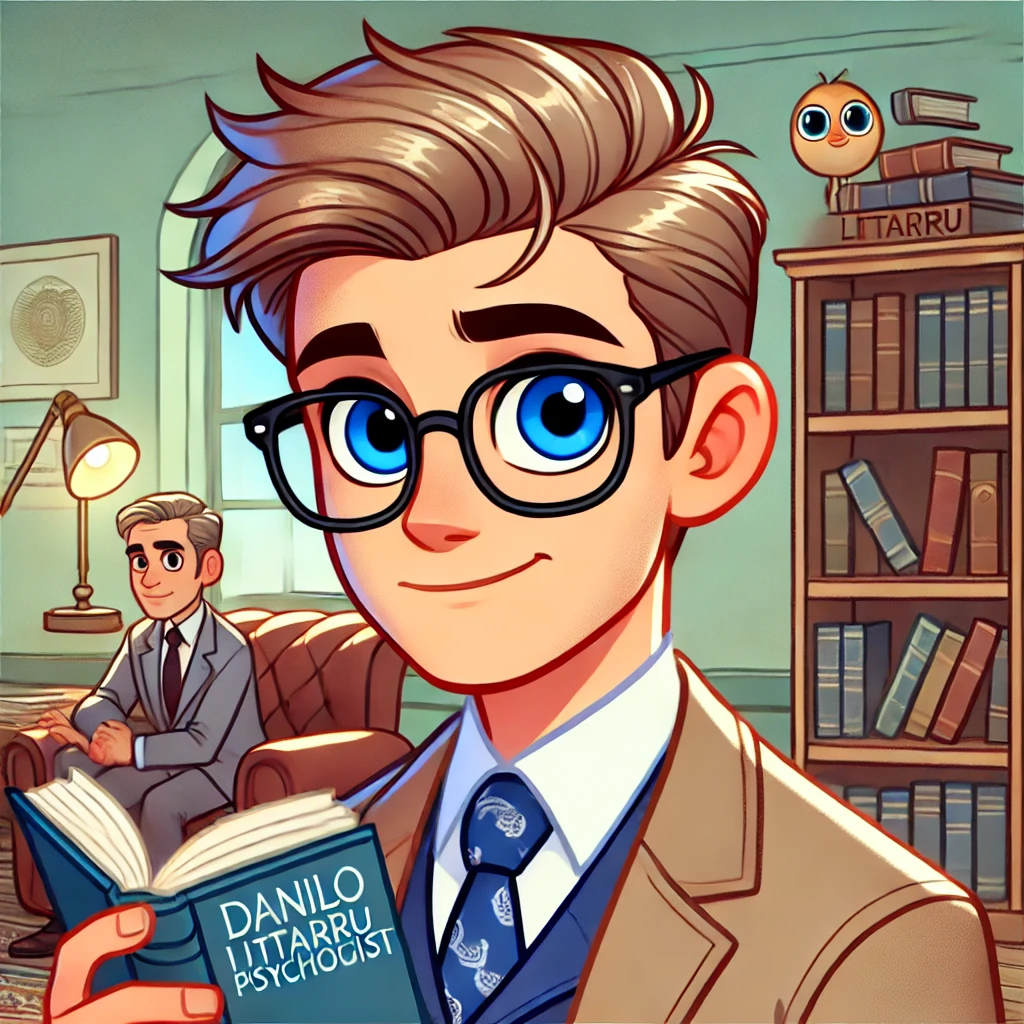Introduzione
L’educazione alla sessualità in adolescenza costituisce una delle sfide più delicate e decisive della scuola e della famiglia contemporanea. Lungi dall’essere mera trasmissione di nozioni biologiche o precauzioni igienico-sanitarie, essa richiede un’antropologia di riferimento capace di orientare la persona verso una maturazione integrale, dove la sessualità non sia ridotta a consumo, ma riconosciuta come linguaggio di relazione, crescita e condivisione.
Antropologia relazionale come fondamento
L’adolescente, posto di fronte alle trasformazioni corporee e identitarie, ricerca significati profondi attraverso la propria esperienza affettiva. È qui che una visione antropologica relazionale diviene imprescindibile: l’essere umano non si definisce solo in termini di istinto, ma come soggetto in relazione, in cui l’incontro con l’altro rappresenta un cammino di crescita reciproca.
La sessualità, in tale prospettiva, non è un atto isolato, ma la conseguenza di dinamiche di fiducia, comunicazione e riconoscimento reciproco.

Il rischio del consumismo sessuale precoce
I dati epidemiologici confermano un abbassamento progressivo dell’età del primo rapporto sessuale (in Italia tra i 15 e i 16 anni, ISTAT 2023). Parallelamente, si registra un aumento di comportamenti a rischio, dal sexting all’esposizione precoce a contenuti pornografici. Questo fenomeno, che potremmo definire consumismo sessuale precoce, veicola un messaggio illusorio: la sessualità come oggetto di mercato e non come incontro esistenziale.
Tale dinamica produce fragilità psichiche, compromettendo lo sviluppo di una sana capacità di scelta e di elaborazione affettiva.
La scuola come spazio educativo privilegiato
La scuola, lungi dall’essere luogo neutro, rappresenta un laboratorio di convivenza e di crescita. L’educazione alla sessualità non può limitarsi a interventi occasionali, ma deve inserirsi in un progetto formativo coerente, capace di integrare dimensioni psicologiche, etiche, corporee e sociali.
Si tratta di promuovere una pedagogia della responsabilità, dove il corpo non sia ridotto a oggetto, ma riconosciuto come dimensione essenziale della persona, dotata di dignità e potenzialità relazionali.
Verso una sessualità come linguaggio di vita
Educare significa restituire ai ragazzi la possibilità di comprendere che la sessualità non è il punto di partenza, bensì l’approdo di una relazione che ha già conosciuto la cura, la fiducia e il rispetto. Solo in questo orizzonte l’atto sessuale perde il carattere consumistico e diviene esperienza di autentica reciprocità.
L’adolescente che impara a leggere la sessualità come narrazione di sé e dell’altro sarà un adulto più capace di vivere la propria intimità con responsabilità e libertà interiore.