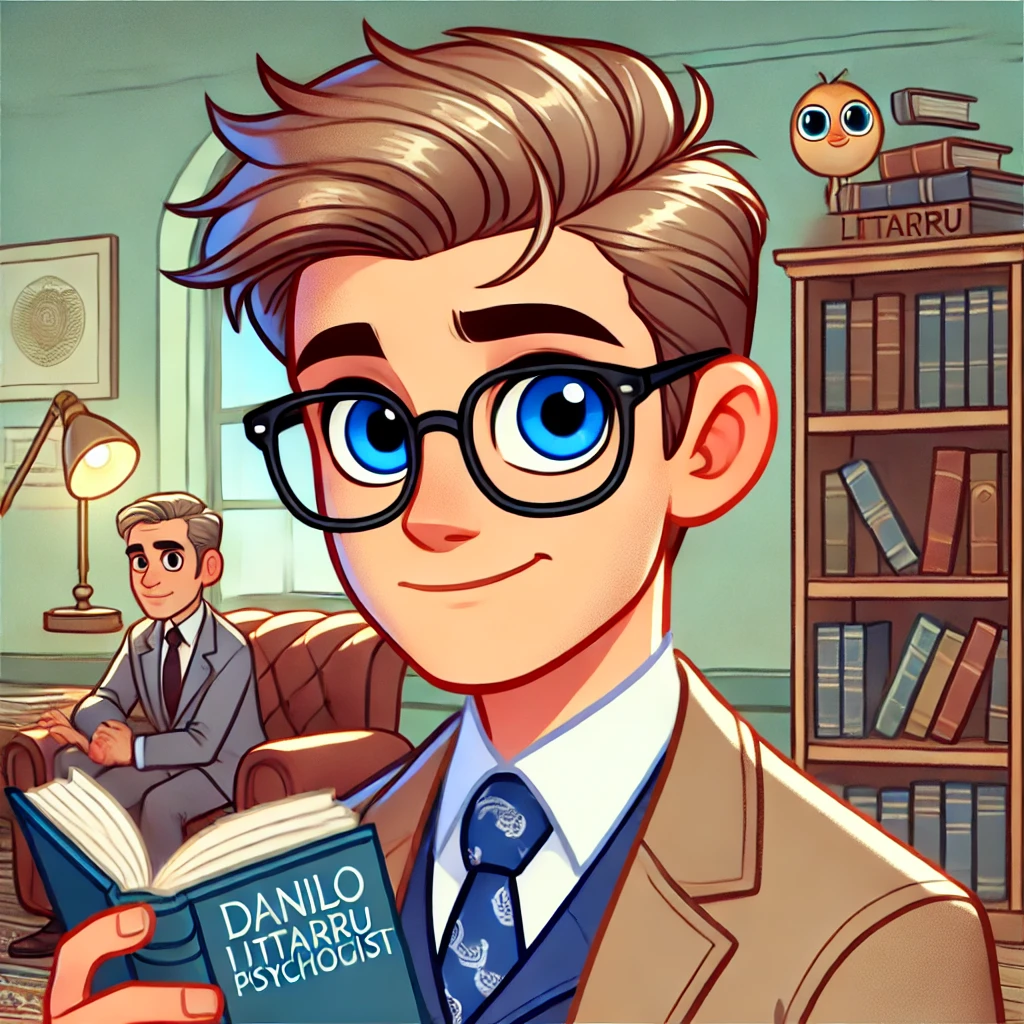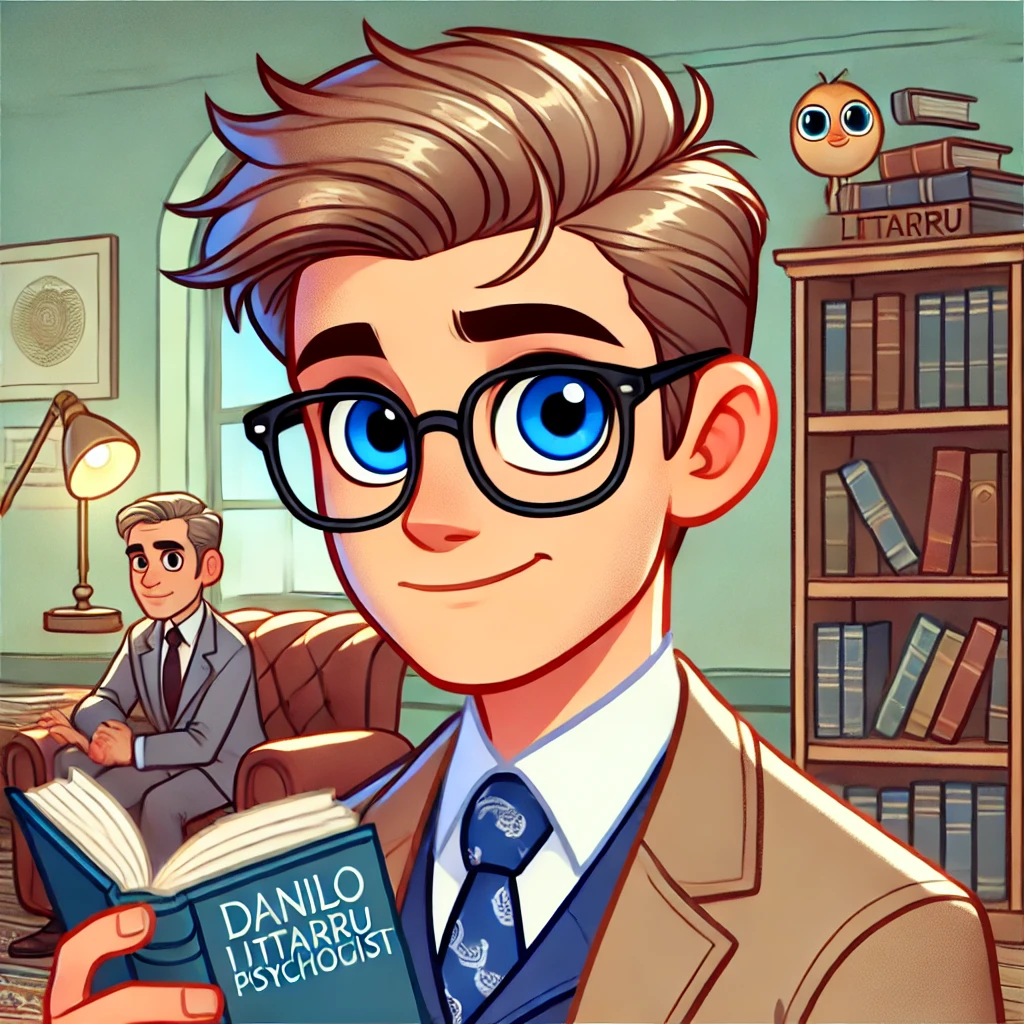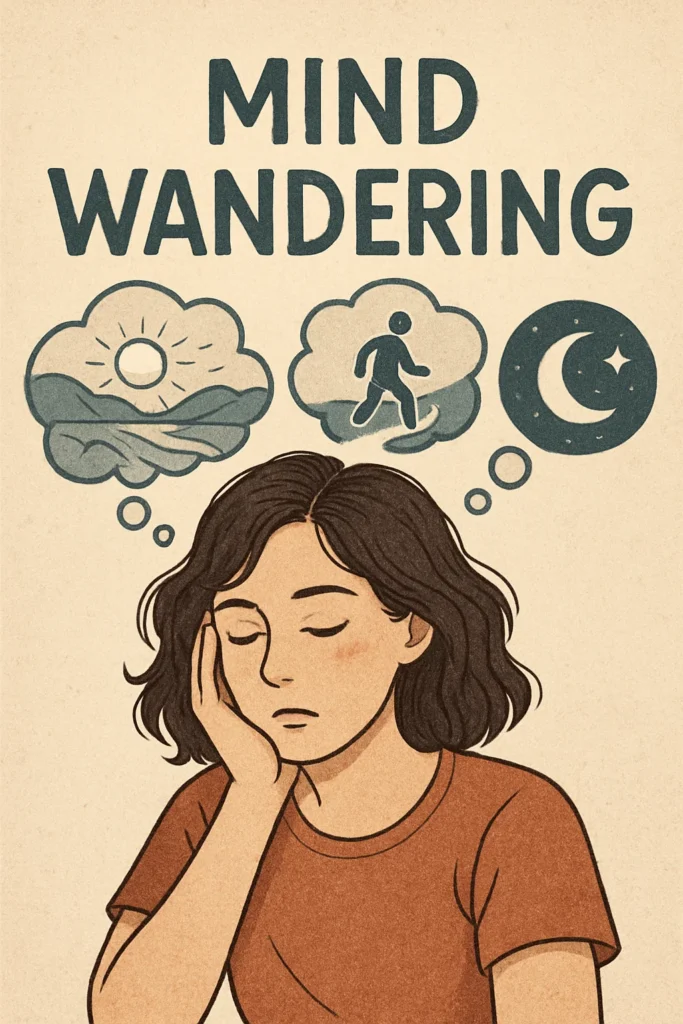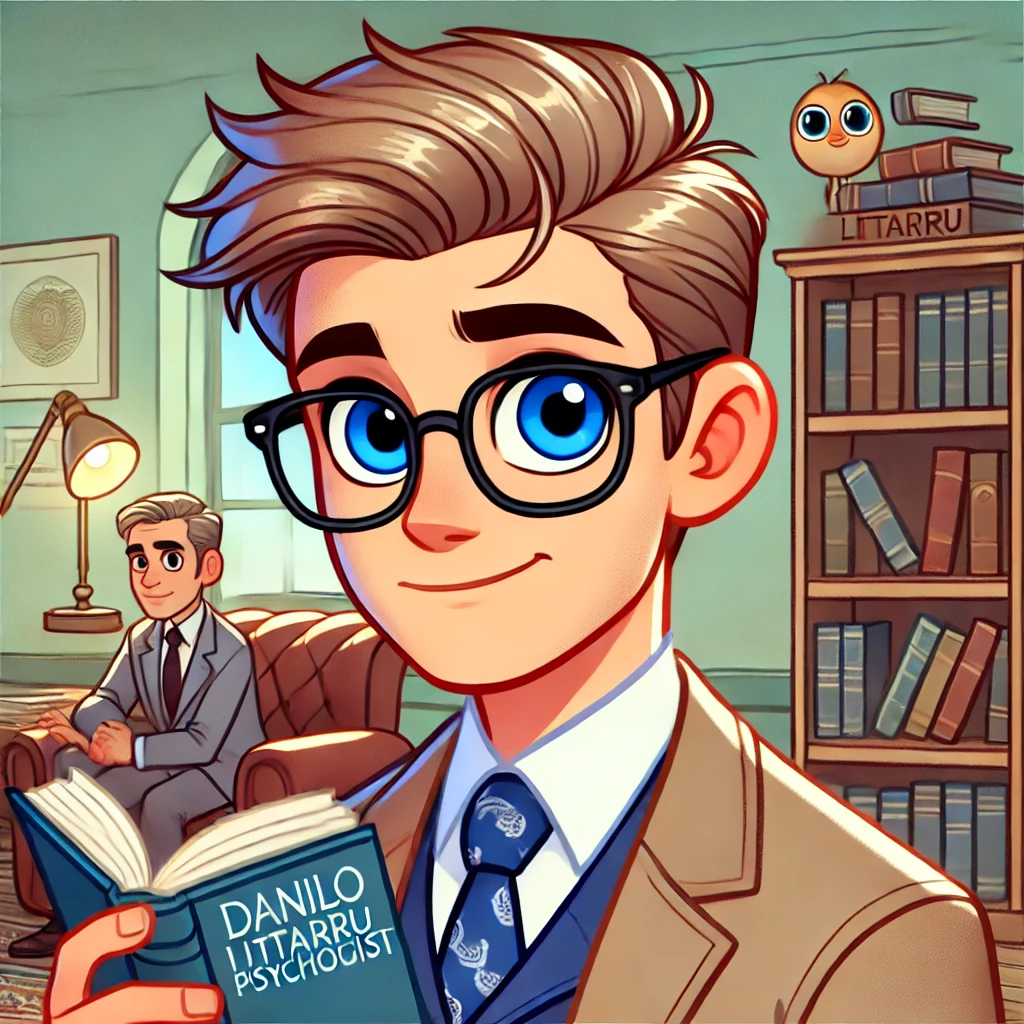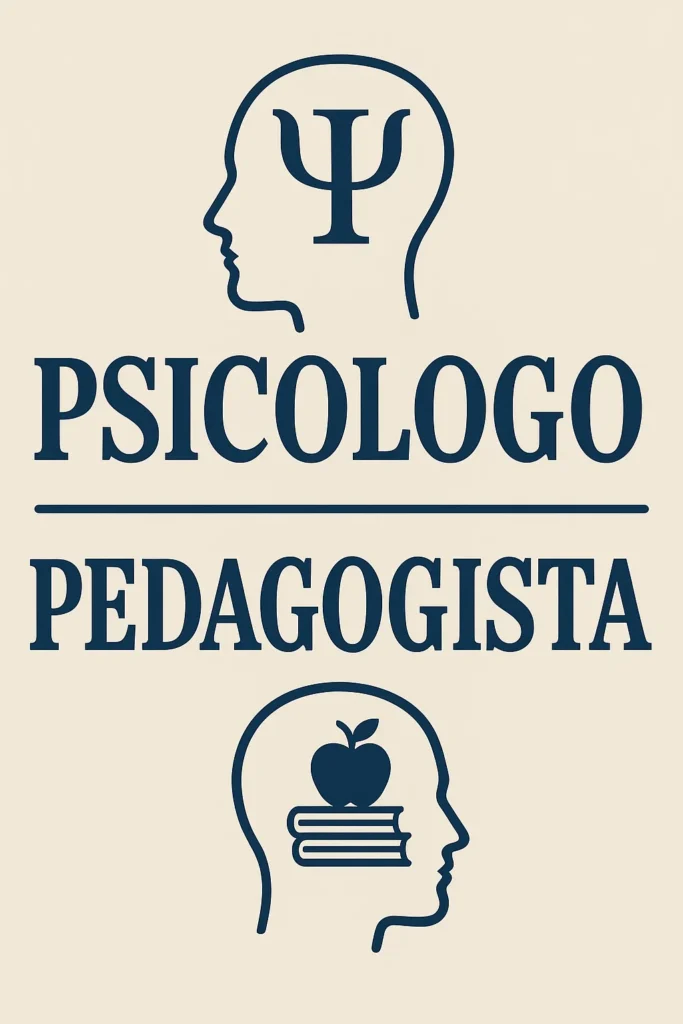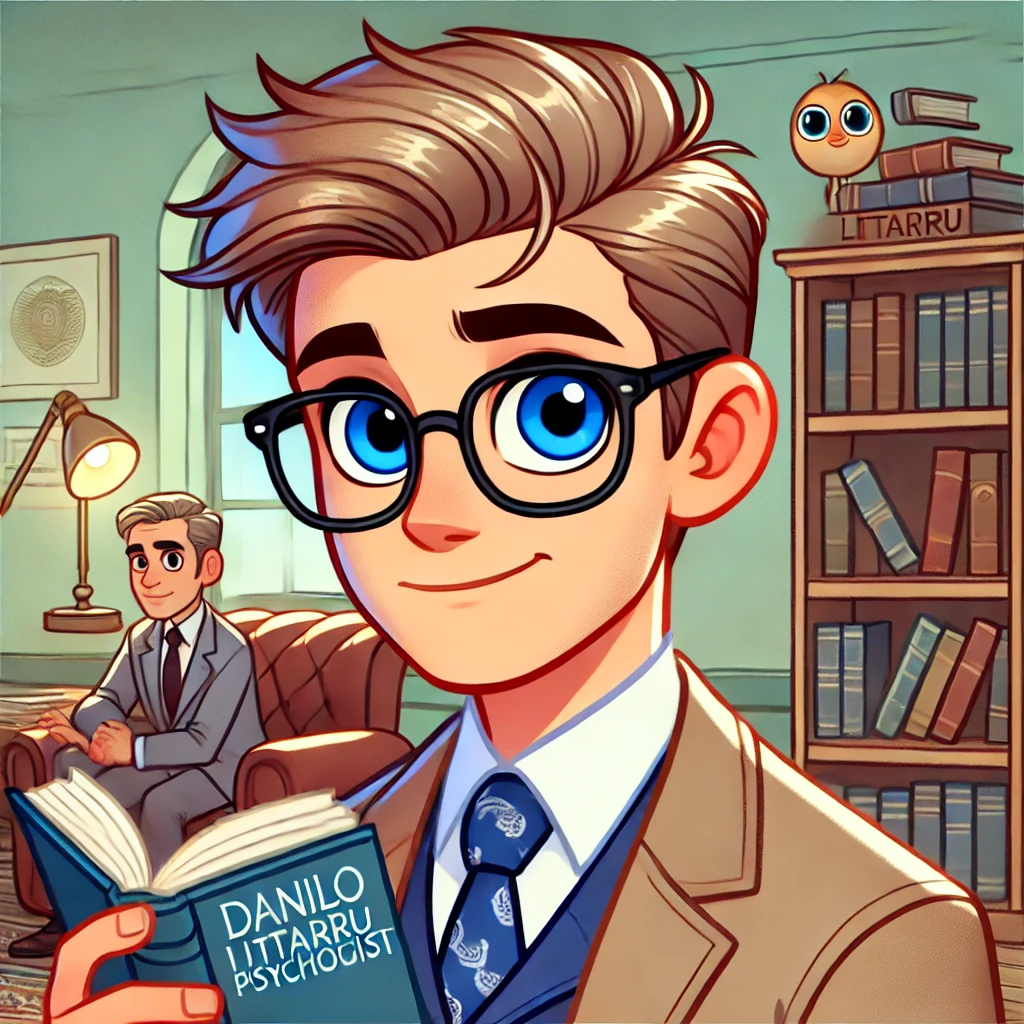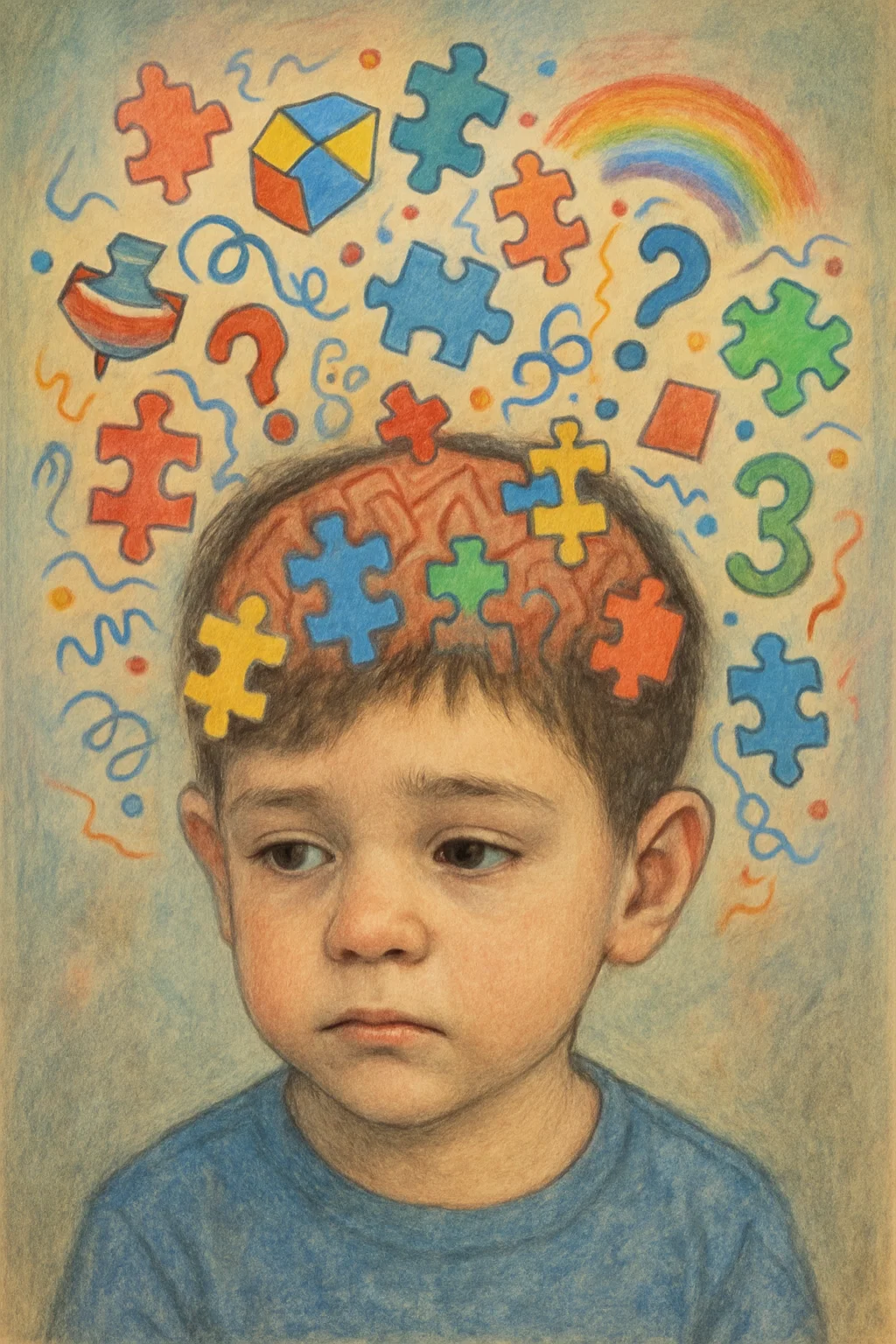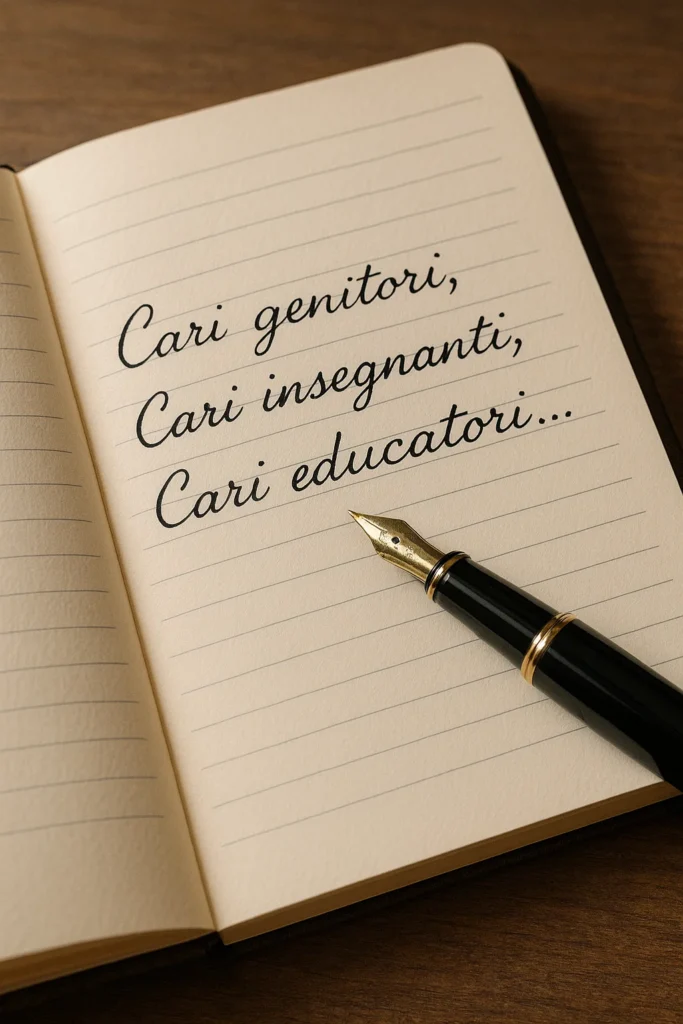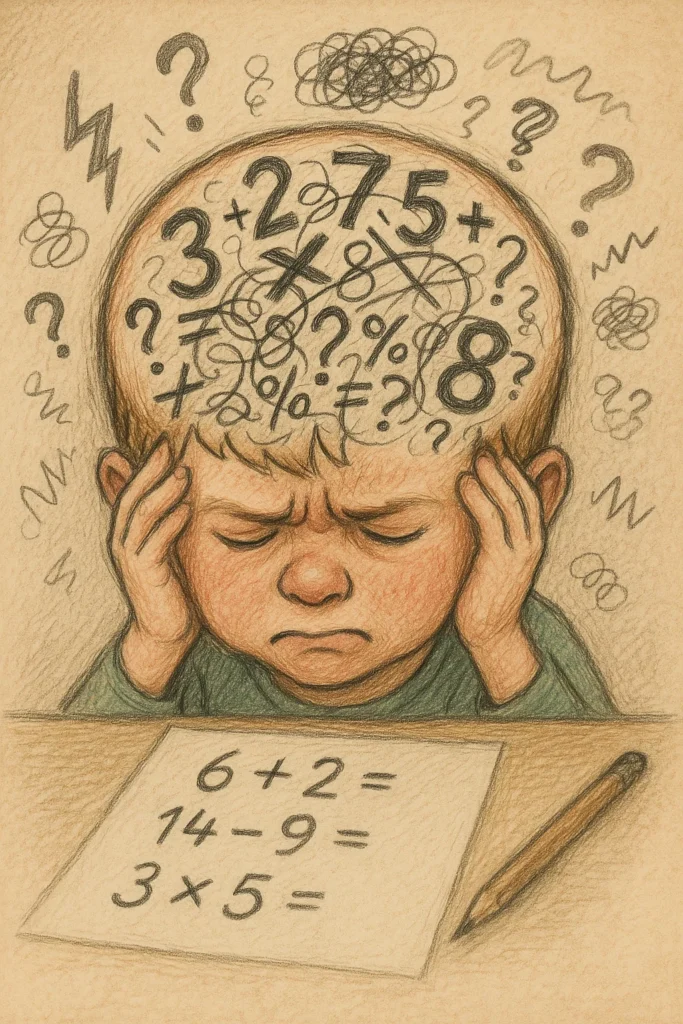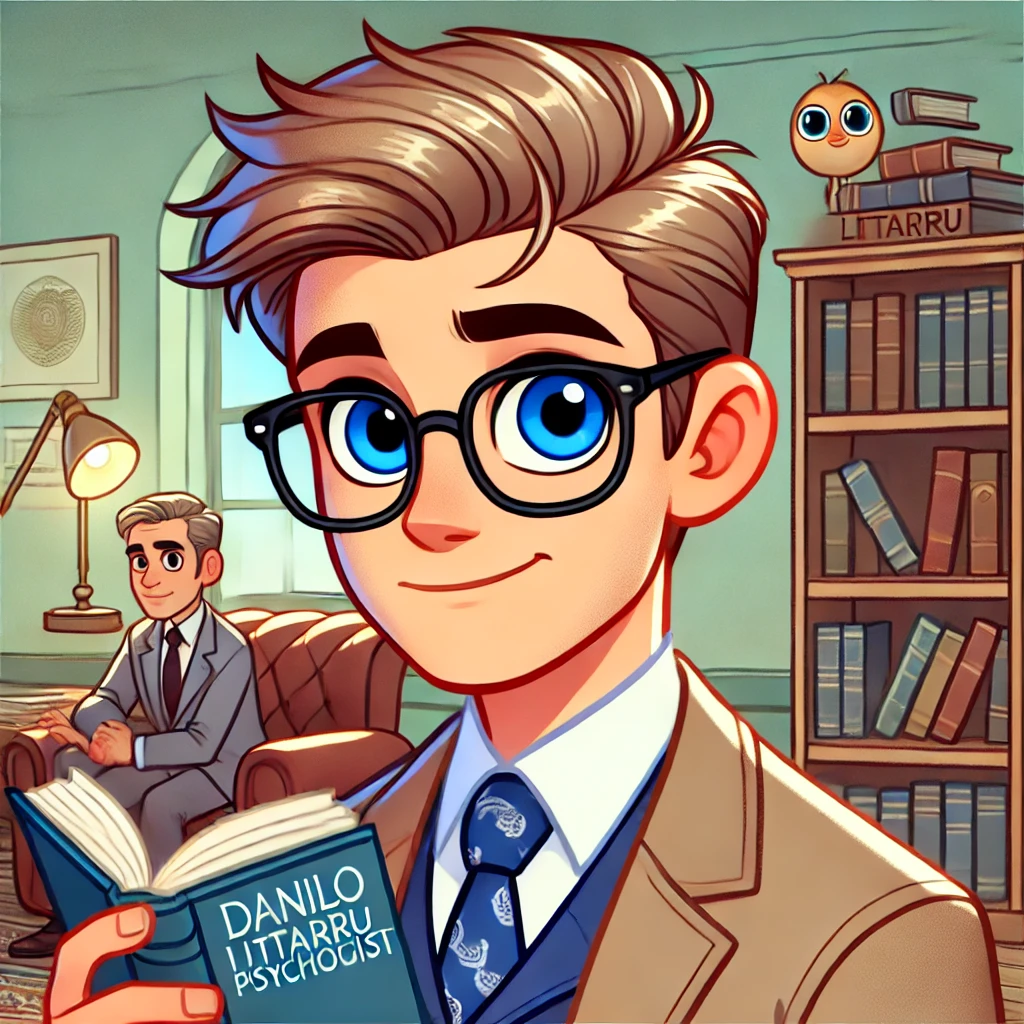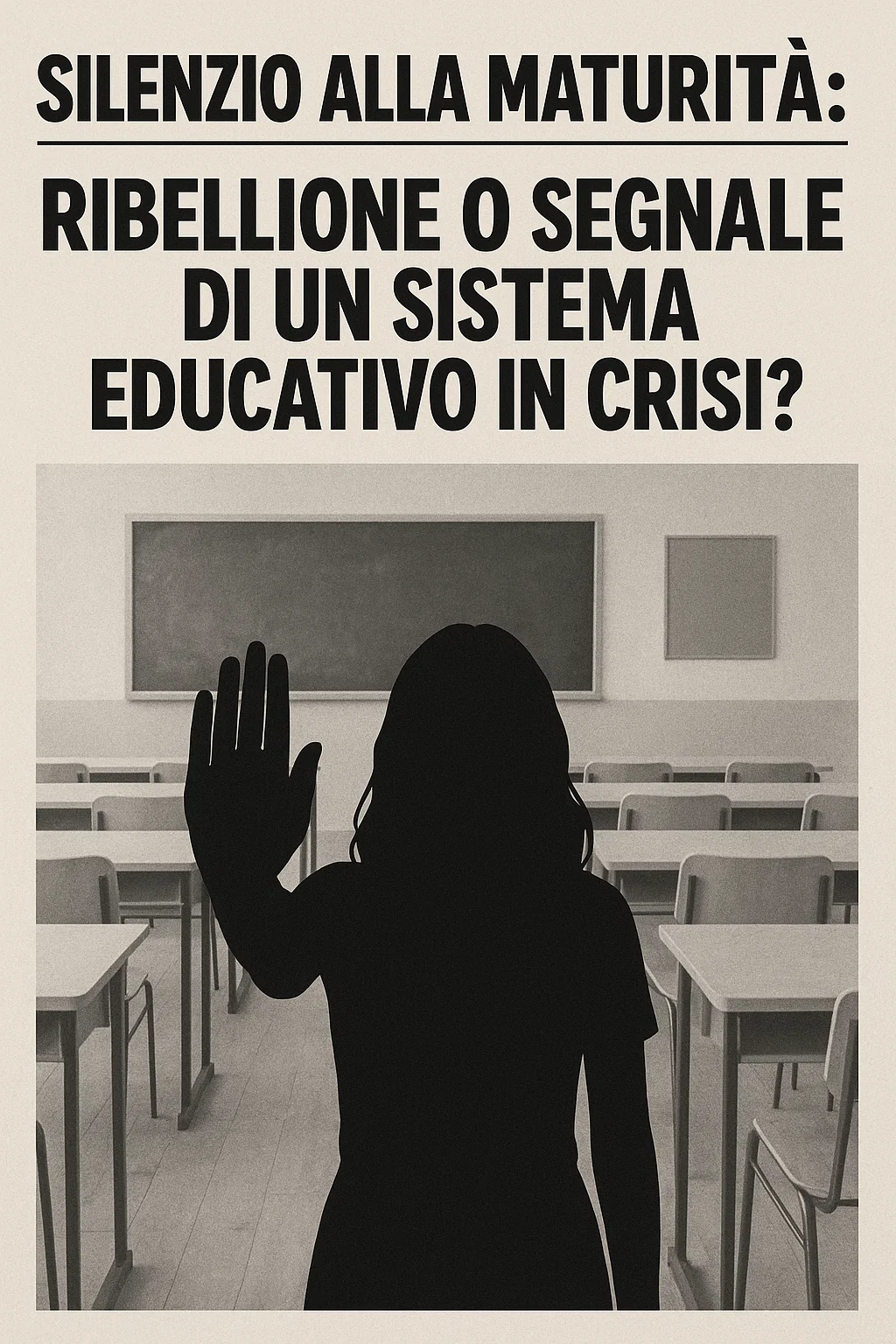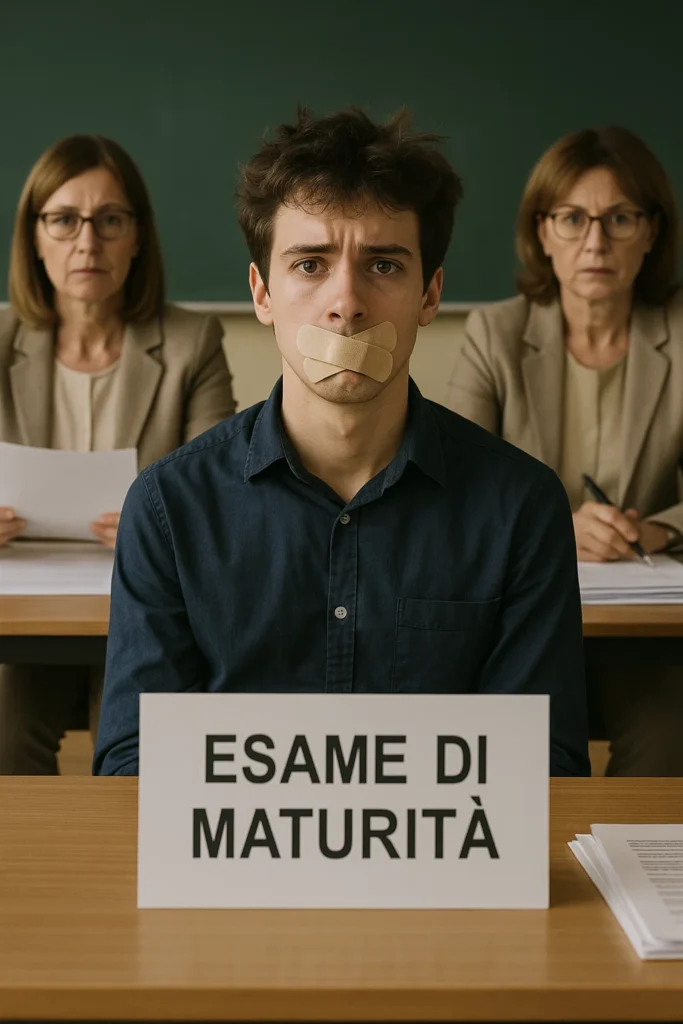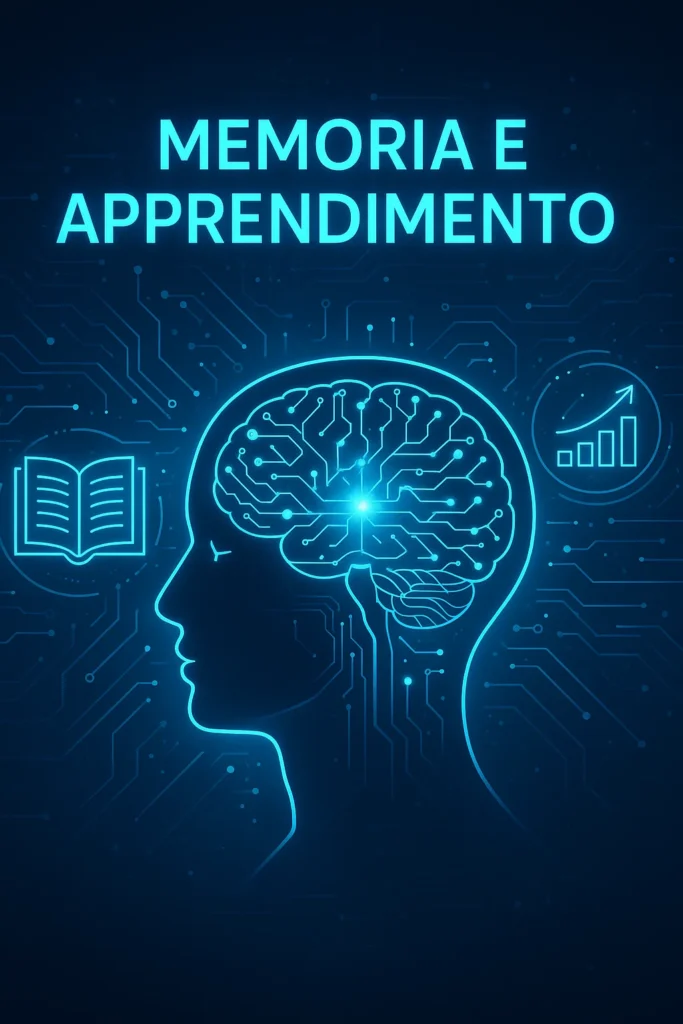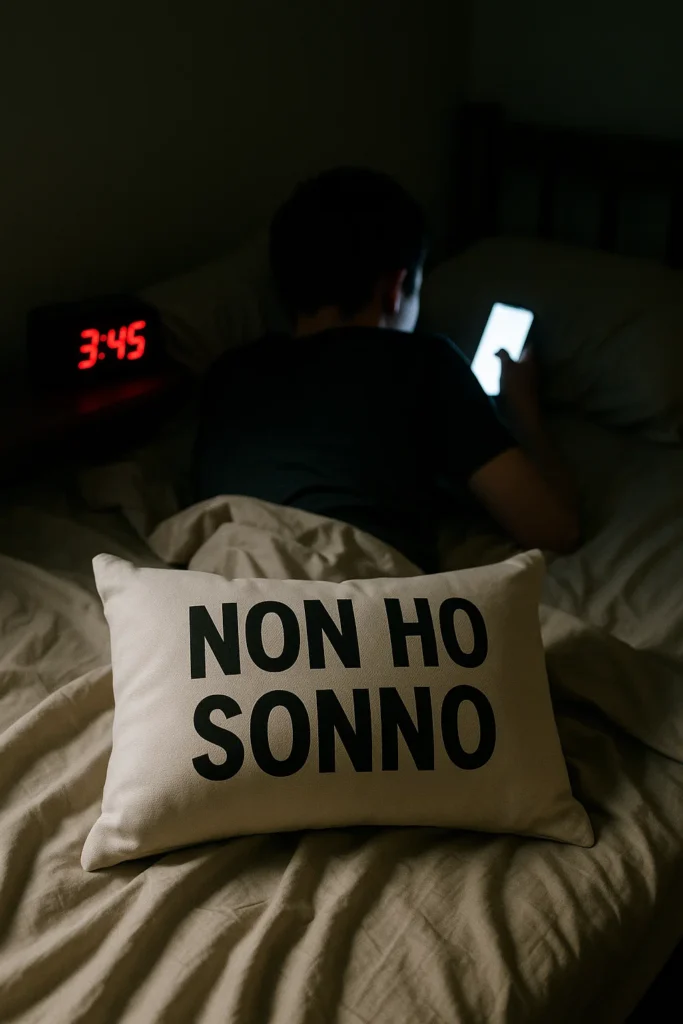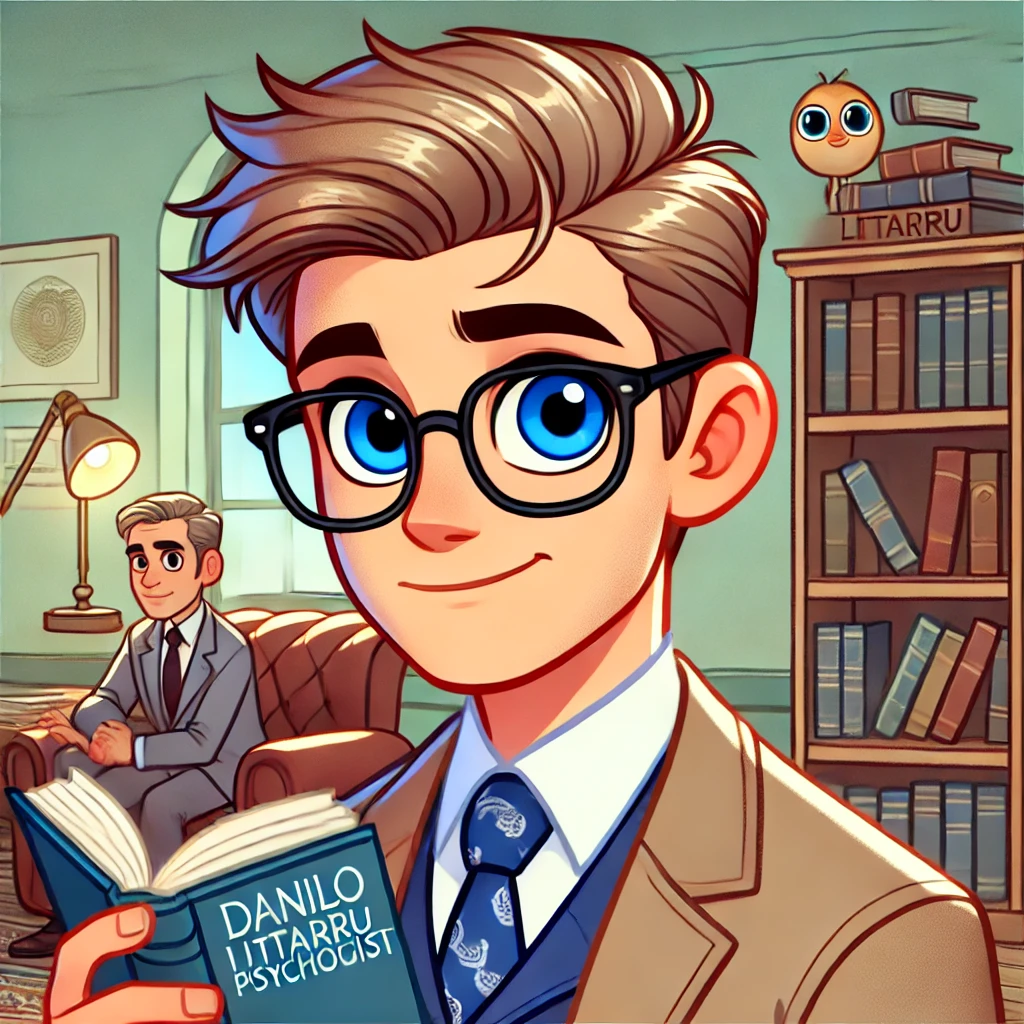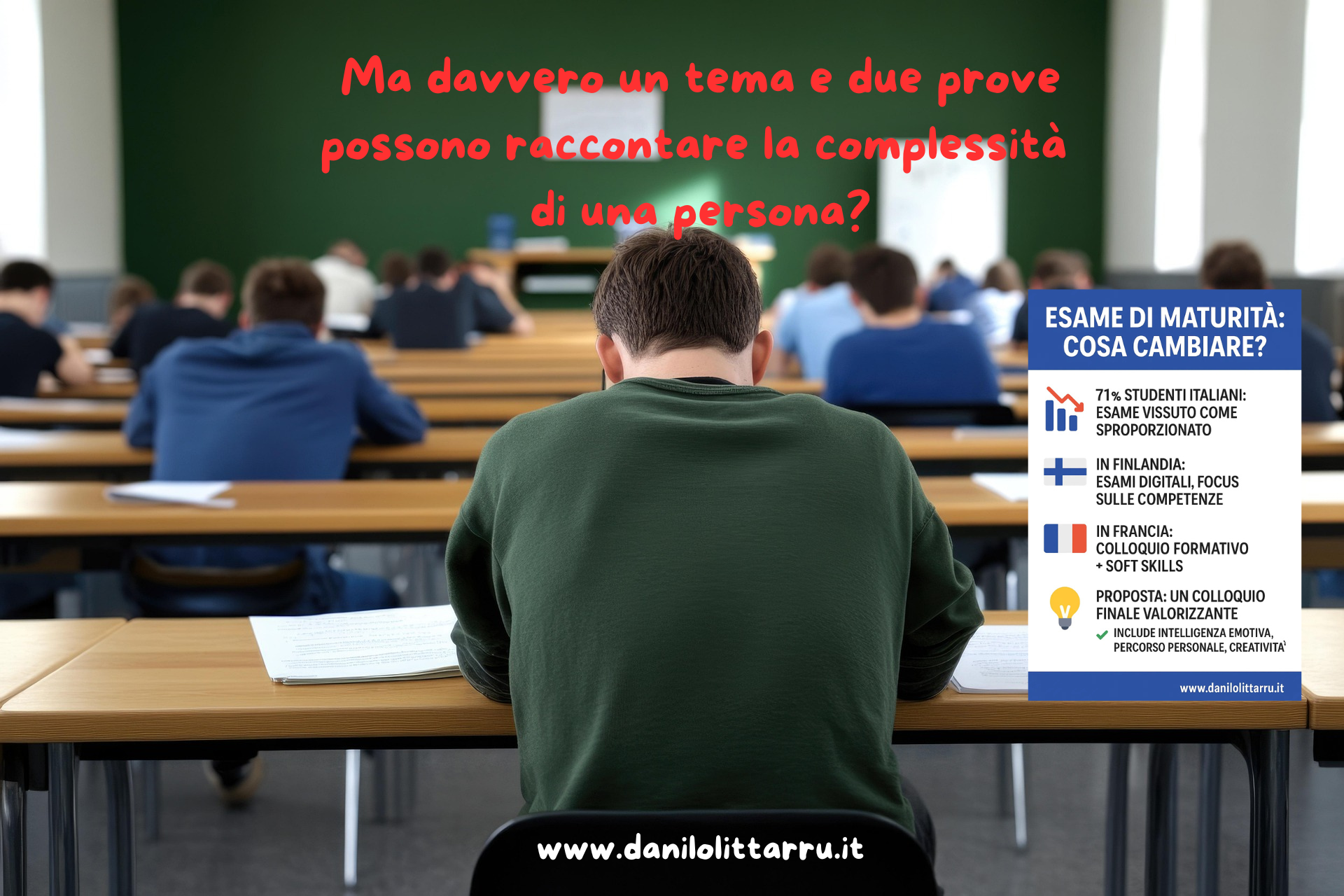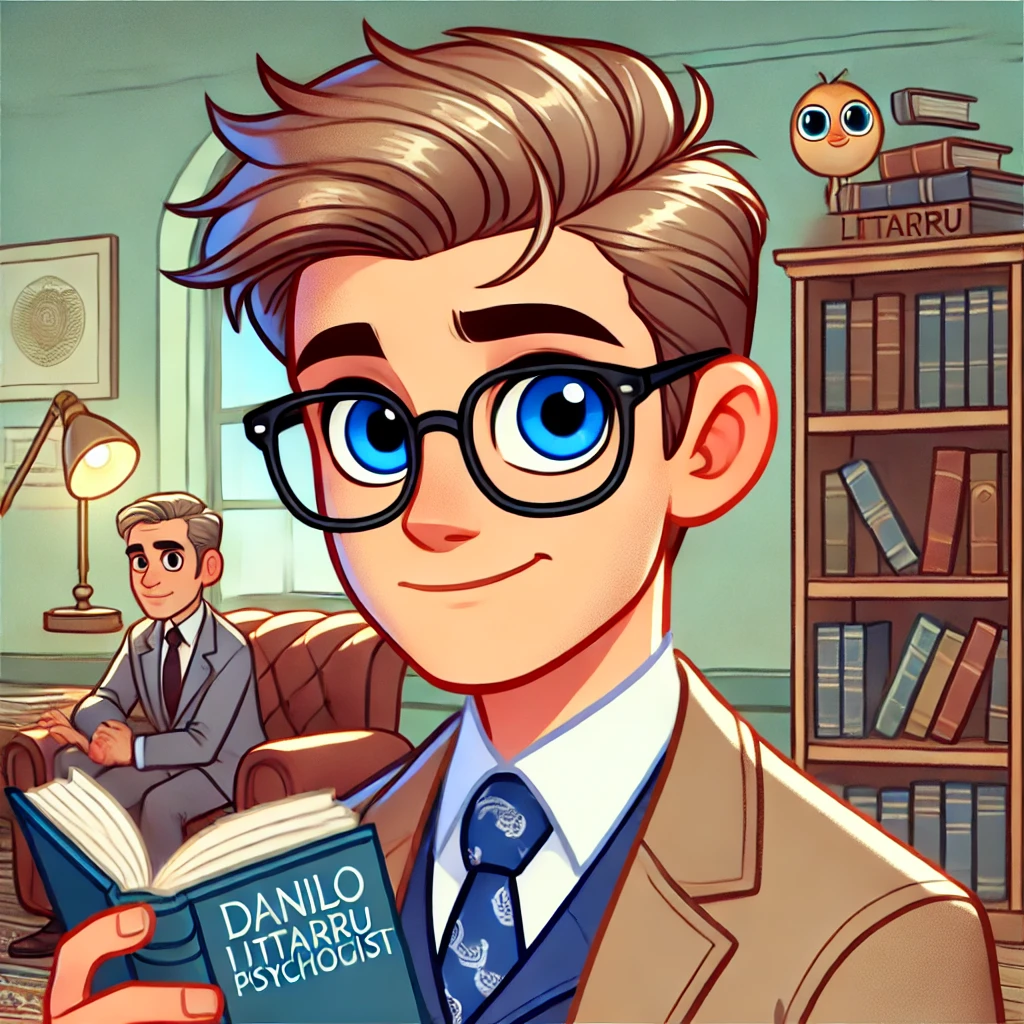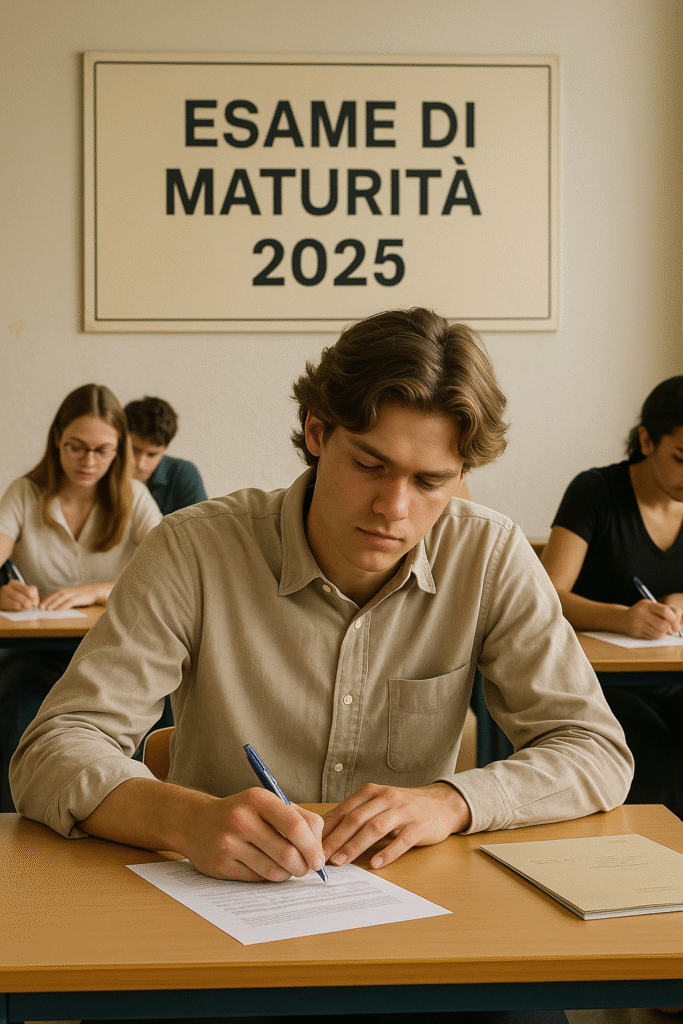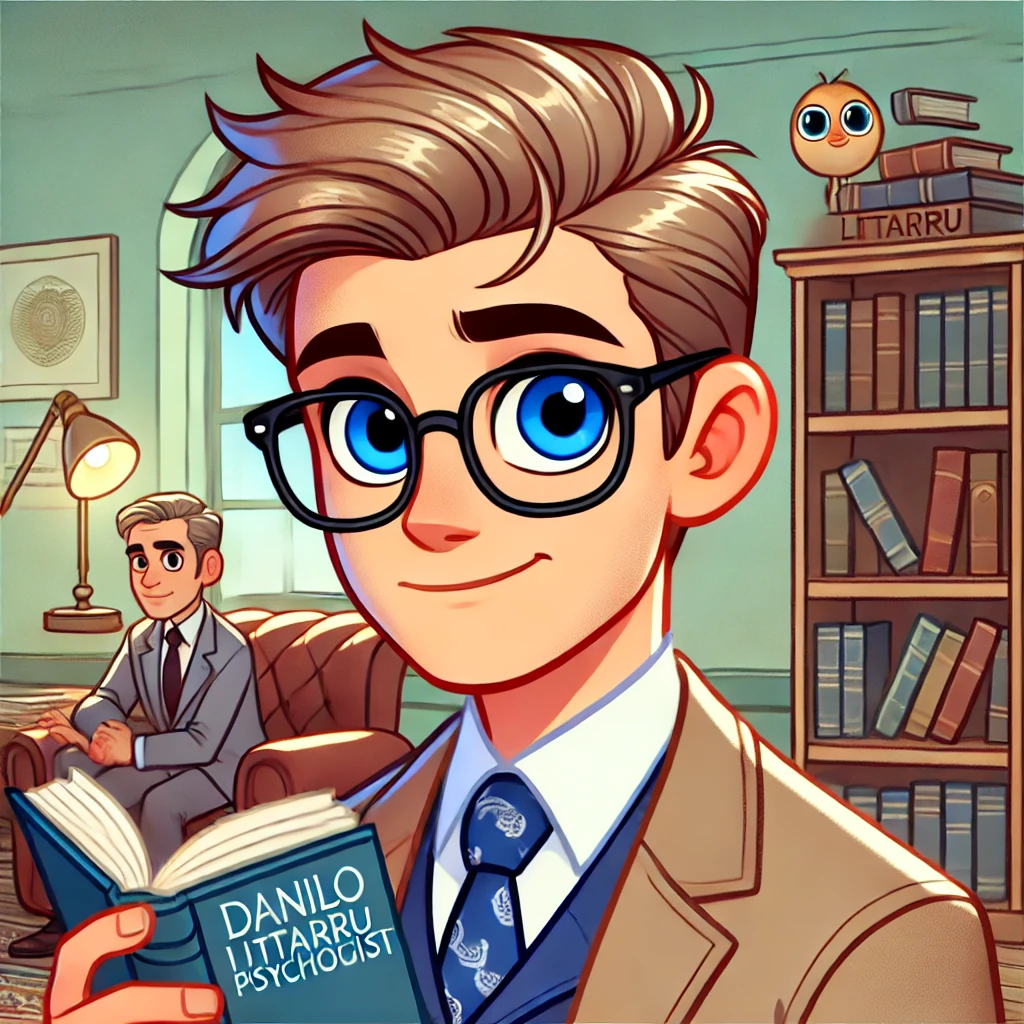La scuola parentale che rivoluziona l’educazione.
Introduzione
Negli ultimi anni la città di Biella è diventata un laboratorio educativo internazionale grazie alla nascita della Open School del Terzo Paradiso, un progetto scolastico parentale complementare alla scuola statale. Nato nel 2021 su iniziativa di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e dell’associazione Associazionedidee, questo modello ha attirato l’attenzione di pedagogisti, famiglie e ricercatori di tutta Italia. La sua originalità risiede nella capacità di coniugare arte, comunità ed educazione, secondo i principi del “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto e del concetto di Learning Arcipelago.
Che cos’è l’Open School del Terzo Paradiso
L’Open School non è una semplice scuola privata o un doposcuola innovativo. È una scuola parentale complementare, riconosciuta come esperienza educativa autonoma ma in dialogo con il sistema scolastico nazionale. Accoglie bambini tra i 6 e gli 11 anni e propone un percorso che integra le discipline tradizionali con laboratori di arte, natura, filosofia, educazione civica, digitale e performativa (si pensi all’uso del circo come strumento didattico).
Al centro vi è la visione che “l’educazione è un ecosistema”, non confinato nelle mura scolastiche ma diffuso nei luoghi di cultura e di comunità: musei, biblioteche, cooperative sociali, spazi urbani, orti condivisi.
Il modello pedagogico: il Learning Arcipelago
La filosofia educativa dell’Open School si ispira al concetto di Learning Arcipelago, ossia un arcipelago di luoghi e saperi collegati da ponti e connessioni. Non una scuola-isola, ma una scuola-rete.
I tratti distintivi:
- Didattica diffusa: la città e il territorio diventano aula estesa.
- Comunità educante: genitori, insegnanti, artisti, operatori sociali partecipano al progetto.
- Interdisciplinarità: arte, scienza e tecnologia dialogano costantemente.
- Governance partecipata: le decisioni educative sono frutto di co-progettazione tra famiglie, docenti e partner istituzionali.
Si tratta, a tutti gli effetti, di una “pedagogia ecologica”, capace di collegare educazione formale, non formale e informale.
La resilienza post-pandemica
Durante la pandemia l’Open School si è distinta per la capacità di reinventarsi:
- con podcast educativi curati da una redazione di bambini (“Comeapprenderemo”),
- con residenze estive di apprendimento esperienziale,
- con l’Academy della Comunità Educante, un percorso di formazione rivolto agli insegnanti e agli educatori, per rigenerare le pratiche scolastiche.
Queste esperienze hanno mostrato come il progetto non sia solo una scuola alternativa, ma un cantiere pedagogico permanente.
Numeri e organizzazione attuale
Per l’anno scolastico 2024/25, la scuola conta 23 alunni regolarmente iscritti. Non si tratta di grandi numeri, ma di una scelta deliberata: la dimensione ridotta garantisce la personalizzazione dei percorsi, l’attenzione al bambino e l’implementazione di metodologie attive come il cooperative learning e la didattica laboratoriale.

Impatto sul territorio e replicabilità
La Open School del Terzo Paradiso non vuole restare un’esperienza isolata. Il suo obiettivo è contaminare il sistema scolastico pubblico, mostrando come sia possibile innovare attraverso:
- alleanze educative territoriali,
- formazione docenti,
- partnership con istituzioni culturali,
- coinvolgimento attivo delle famiglie.
Il progetto appare scalabile e replicabile, configurandosi come un prototipo di scuola del futuro, in linea con le raccomandazioni europee su educazione inclusiva, sostenibilità e cittadinanza attiva (cfr. EU Key Competences for Lifelong Learning, 2018).
Analisi pedagogica
Dal punto di vista scientifico, l’Open School intercetta alcune tendenze cruciali dell’educazione contemporanea:
- Centralità dell’esperienza (Dewey, Montessori): l’apprendimento nasce dall’esperienza diretta.
- Educazione estetica e creativa (Nussbaum, Eisner): l’arte non è solo ornamento, ma motore cognitivo ed etico.
- Comunità educante (Bronfenbrenner): il contesto sociale è parte integrante del processo di crescita.
- Scuola come ecosistema (Morin): complessità e interconnessione sono la vera grammatica del sapere.
Conclusione: un laboratorio per la scuola italiana
L’Open School del Terzo Paradiso è oggi un piccolo ma straordinario esperimento che unisce arte, pedagogia e comunità. Non sostituisce la scuola statale, ma la completa e la sfida a ripensarsi.
Come pedagogista e psicologo, osservo con interesse come questo modello biellese stia dimostrando che un’altra scuola è possibile: una scuola che educa non solo alla conoscenza, ma alla cittadinanza creativa, ecologica e solidale.