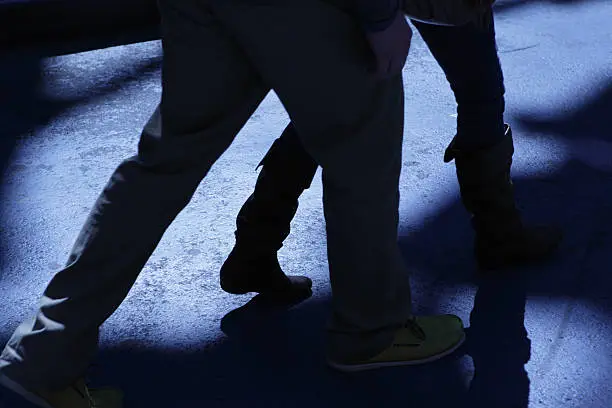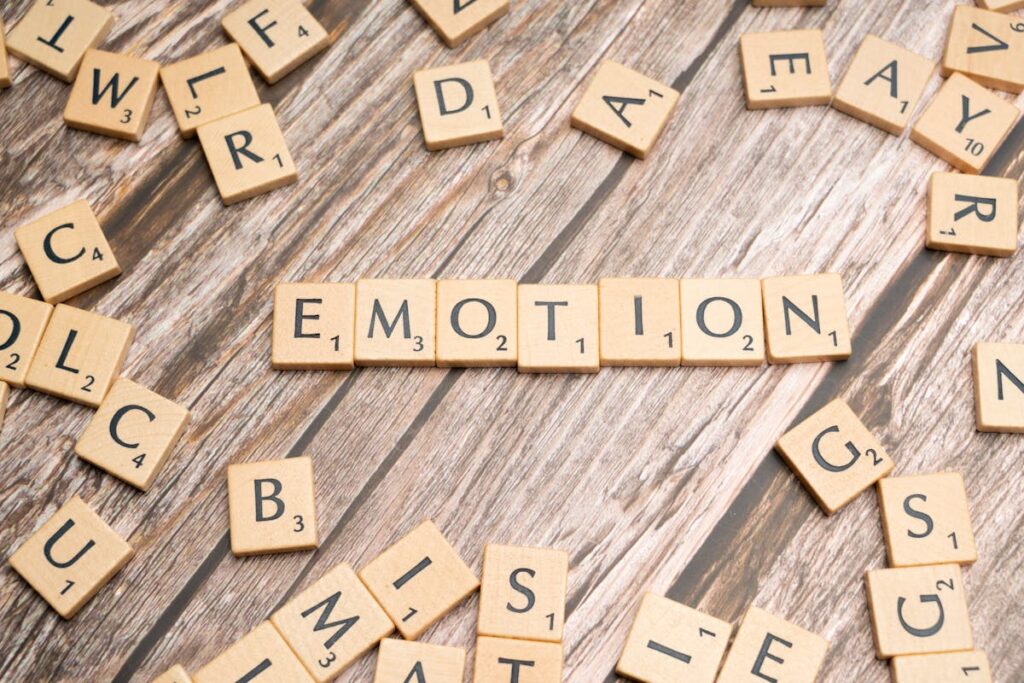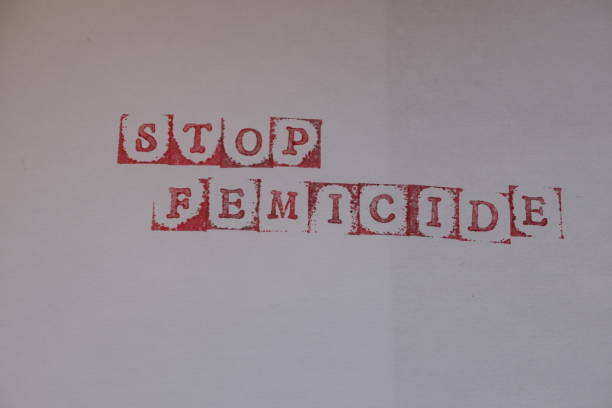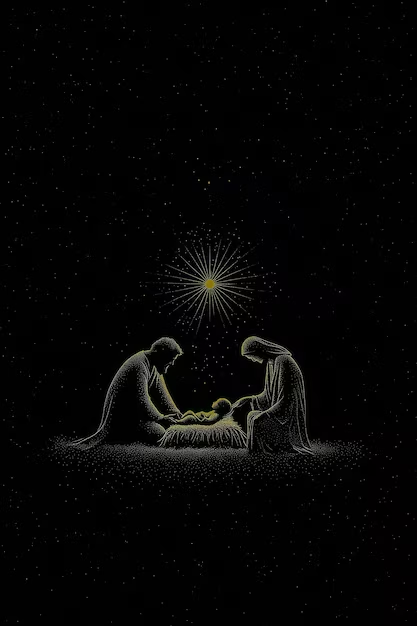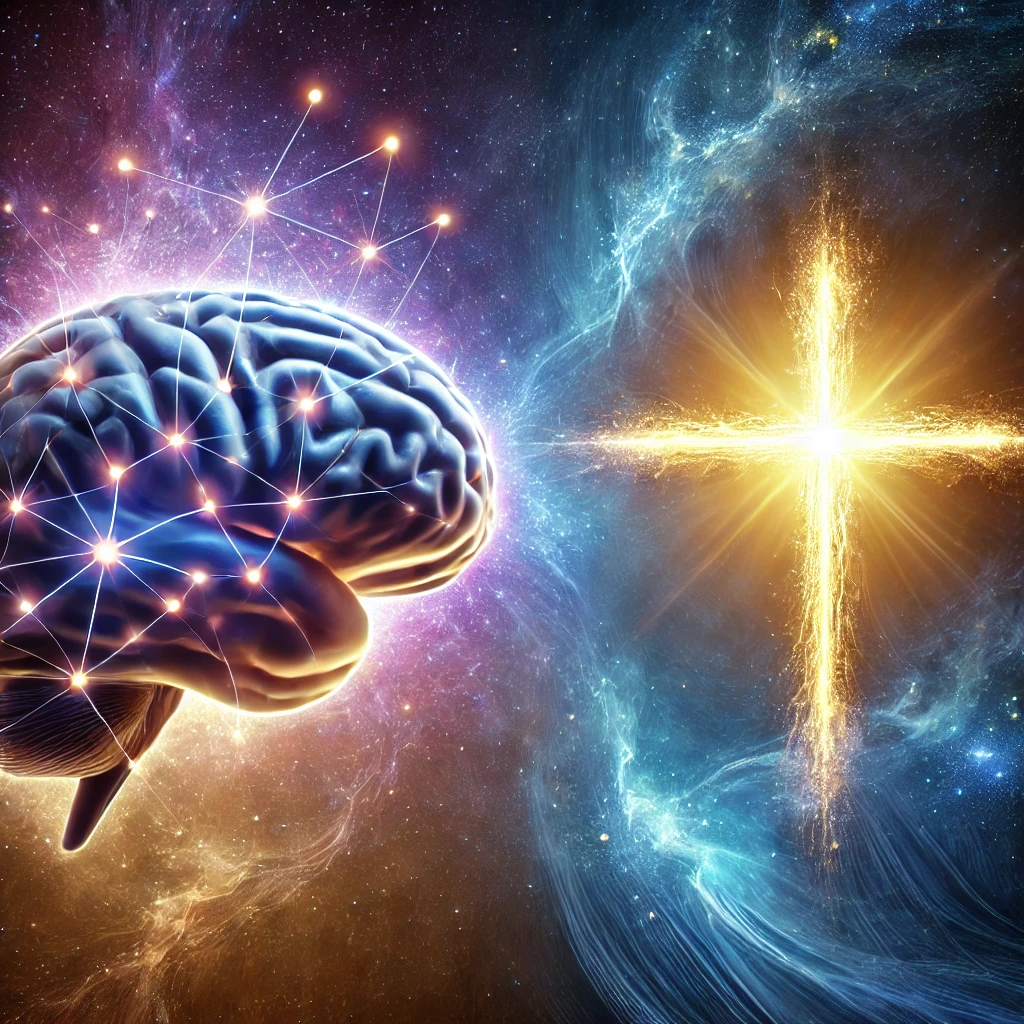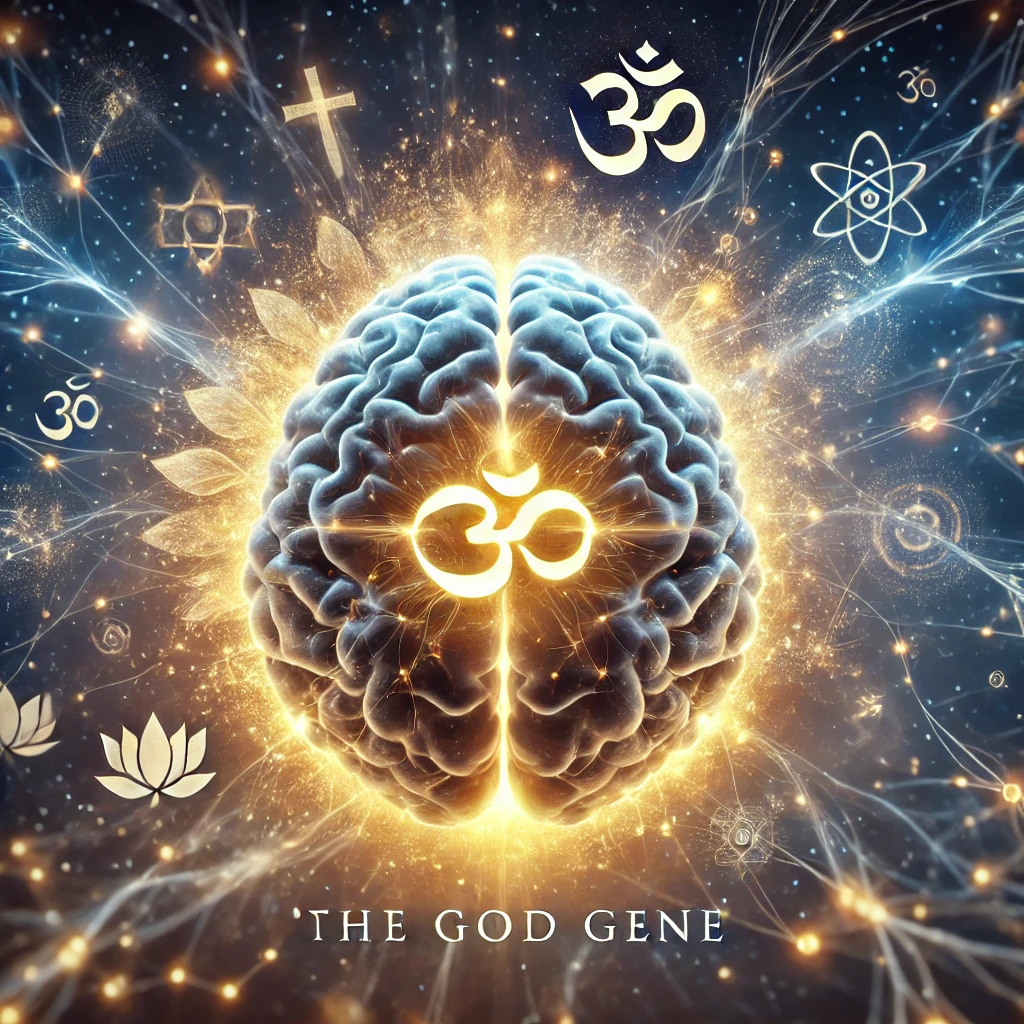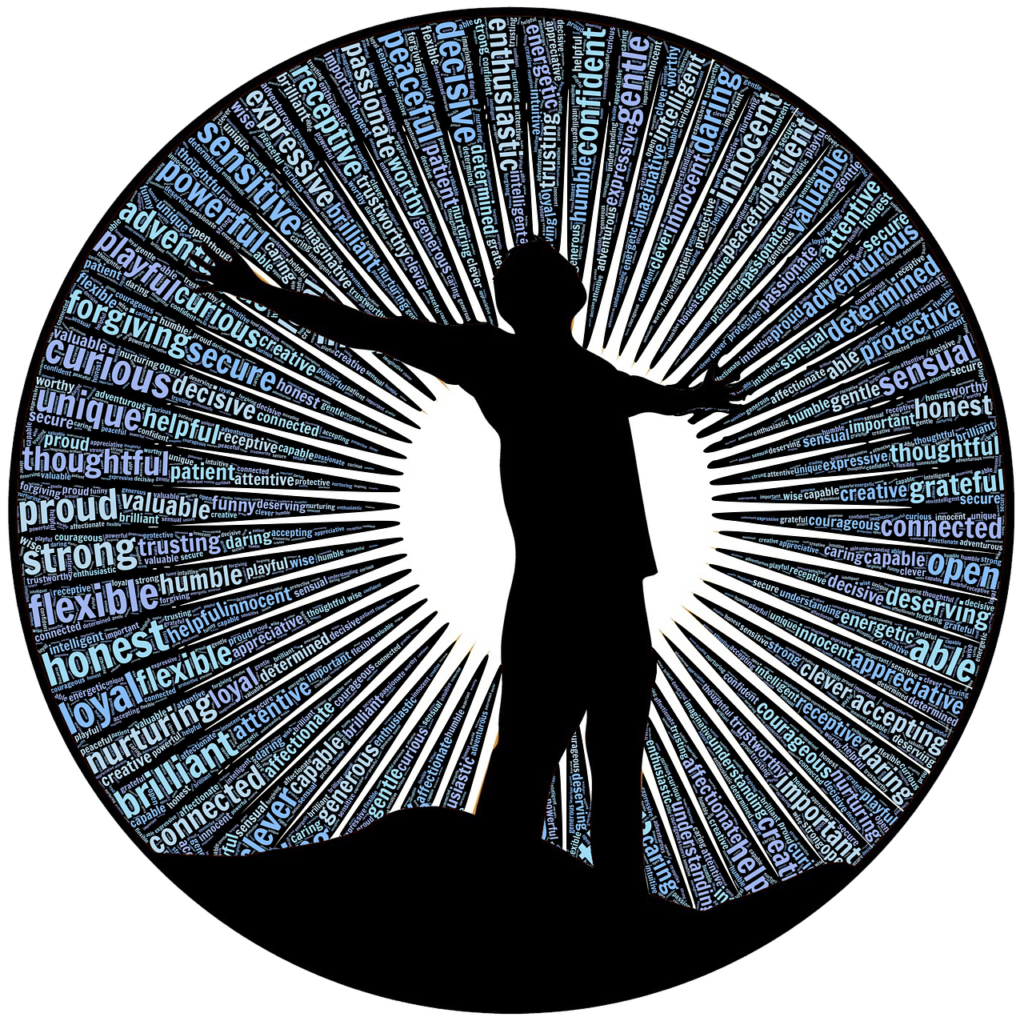L’alone di diffidenza che aleggia sulla scuola è oggi più che mai fitto. Ormai da decenni dibattiti, confronti, manifestazioni di protesta, scioperi, indicano una sofferenza congenita della scuola italiana accusata di non essere più al passo con i tempi, e ritenuta da più parti come un’agenzia incapace di educare, prima ancora di istruire. Non si ricorda un ministro che, subentrato a quello precedente, non abbia portato modifiche o novità, provvedendo ad elaborare e varare la propria ipotesi di “riforma” istituzionale, ad una visione propria, non agevolando un’azione educativa e ristrutturattiva del sistema capace di progettualità rinnovata e condivisa.
Appare indispensabile trovare nuove strategie educative, per far riacquisire quel ruolo fondamentale che la scuola ha da sempre ricoperto, far riscoprire l’importanza dell’insegnante, restituendoli quel ruolo professionale e sociale, offeso da banali e diffusi luoghi comuni, sovente screditanti, che provocano una distorsione delle reali difficoltà. Ammesso che le difficoltà si intersecano su vari fronti, (dall’architettura scolastica che andrebbe rivista, alla messa in sicurezza degli edifici, al curriculo formativo, alle retribuzioni dei docenti) occorre ripartire da una formazione e da una selezione più attenta di chi ha una responsabilità e un ruolo così decisivo nella crescita di bambini e ragazzi.
Forse, parlare di formazione ed educazione dei formatori, può sembrare retrogrado, se ci mettiamo a confronto con realtà diverse dalle nostre. In Nuova Zelanda, da circa un anno, in una scuola elementare, tiene banco il Prof. Will, non un docente in carne ed ossa ma un avatar, un software di Intelligenza Artificiale. (Questa iniziativa fa parte del programma “Be Sustainable with Energy“, promosso dall’azienda energetica Vector in collaborazione con la società di intelligenza artificiale Soul Machines. Gli studenti interagiscono con Will tramite computer, tablet o smartphone, partecipando a lezioni e verifiche interattive).
La sua funzione, è quella di umanizzare l’intelligenza artificiale per migliorare l’umanità. L’apporto di ricercatori, neuroscienziati, psicologi e pensatori innovativi, è finalizzato a ripensare al rapporto-connessione con le macchine, creando umani artificiali incredibilmente realistici, emotivamente sensibili con personalità e carattere che consentono alle macchine di interagire. Secondo lo storico contemporaneo e vice-rettore dell’Università di Buckingham, Sir Anthony Seldon, che si occupa di educazione, gli avatar saranno destinati a breve a scalzare i docenti umani tra meno di 10 anni. Anche la scuola, verrebbe dunque macinata dal fenomeno della robotizzazione del lavoro, aprendo scenari nuovi e fino a qualche decennio fà impensabili e a mio parere inquietanti.
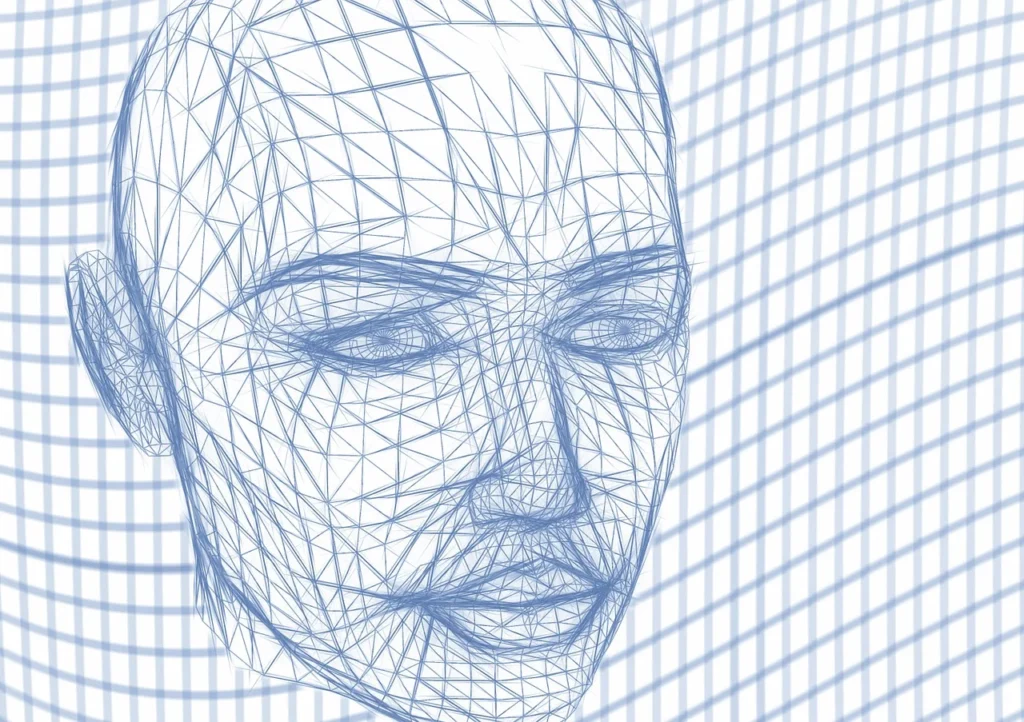
Al di là dei punti di forza dell’informatizzazione dei sistemi lavorativi, la domanda che dobbiamo porci è relativa a quale uomo del futuro stiamo costruendo o vogliamo costruire. È bene rimarcare che non esiste tecnologia che possa dotare una macchina “intelligente” di autocoscienza e di emozioni, in grado di superare e schiacciare l’uomo. Nel futuro prossimo si investiranno ingenti risorse per migliorare e perfezionare l’intelligenza artificiale e robotica ma è necessario e doveroso, circoscrivere un quadro etico-antropologico e giuridico che tuteli fortemente l’uomo, e nella fattispecie, non ci si dimentichi, in nome di un progresso arrogante, dell’apporto dato dal sapere umanistico e da quel linguaggio sequenziale e analitico, che è stato alla base del pensiero occidentale per circa duemila centocinquanta anni di storia.
La virtute e canoscenza, che Dante cita nel XXVI canto dell’inferno, richiama all’essere virtuosi nelle totalità delle dimensioni della personalità per riappropriarsi dell’incalcolabile sapere accumulato dagli uomini nel corso dei millenni. Forse la scuola del futuro dovrebbe ripartire da qui, ri-attivando e rafforzando quel dinamismo dell’ex-ducere che richiede di tirar fuori il meglio dai ragazzi con la testimonianza e l’esempio di insegnanti-educatori equilibrati e consapevoli, per favorire la ricerca, il discernimento, la scoperta finalizzata a tessere e costruire virtù e saperi. La missione della scuola, non è allora giudicare, scrutinare, ma istituire processi di formazione “sartoriali”, dare forma generativa all’esistenza giovane, oggi appiattita da modelli stereotipati ed uniformanti dove le specificità tendono ad appiattirsi. Ripartendo dalla condivisione di obiettivi, di metodi, di strategie, forse si può intavolare un discorso che sappia ribaltare le logiche puntiformi del qui e ora e possa aprirsi ad orizzonti ricchi di valore e di senso. I giovani, come amava ricordare Joseph Joubert hanno più bisogno di esempi che di critiche.