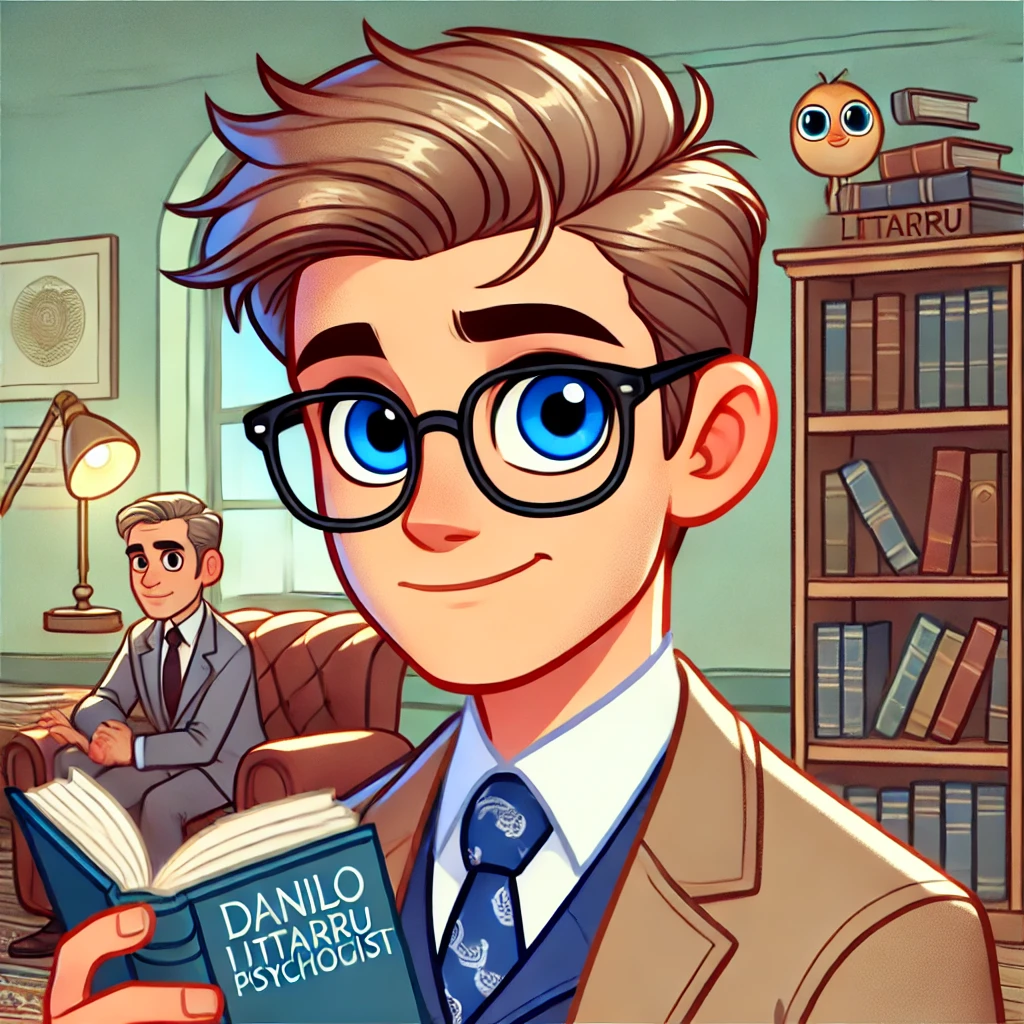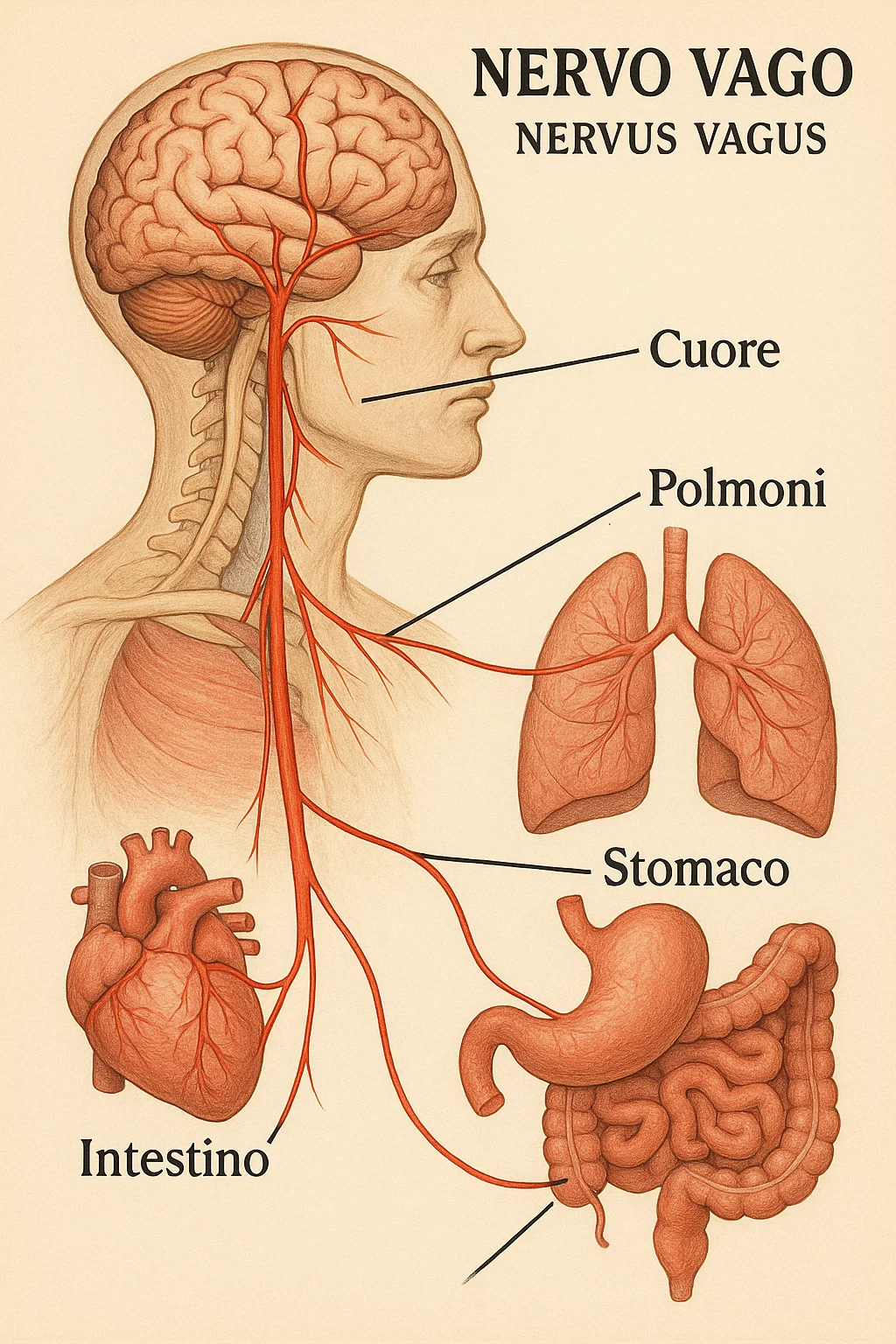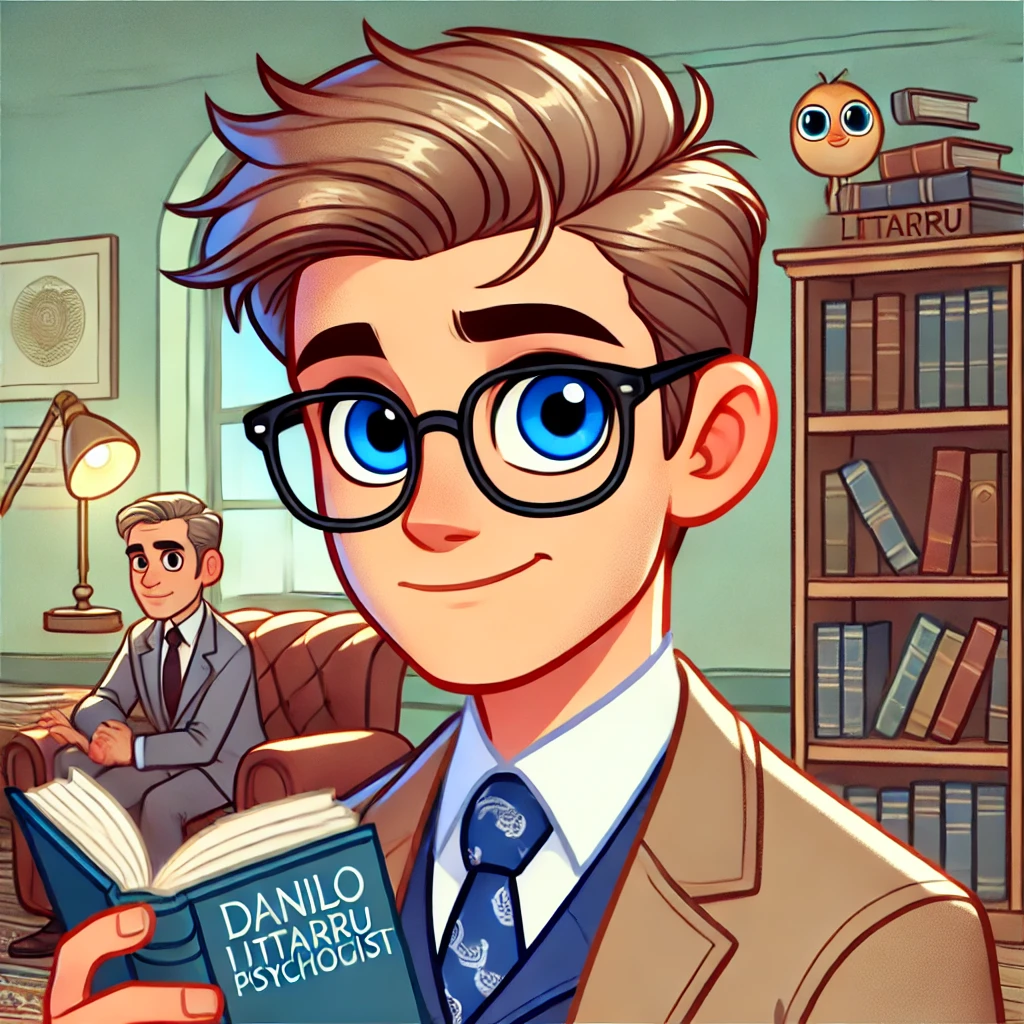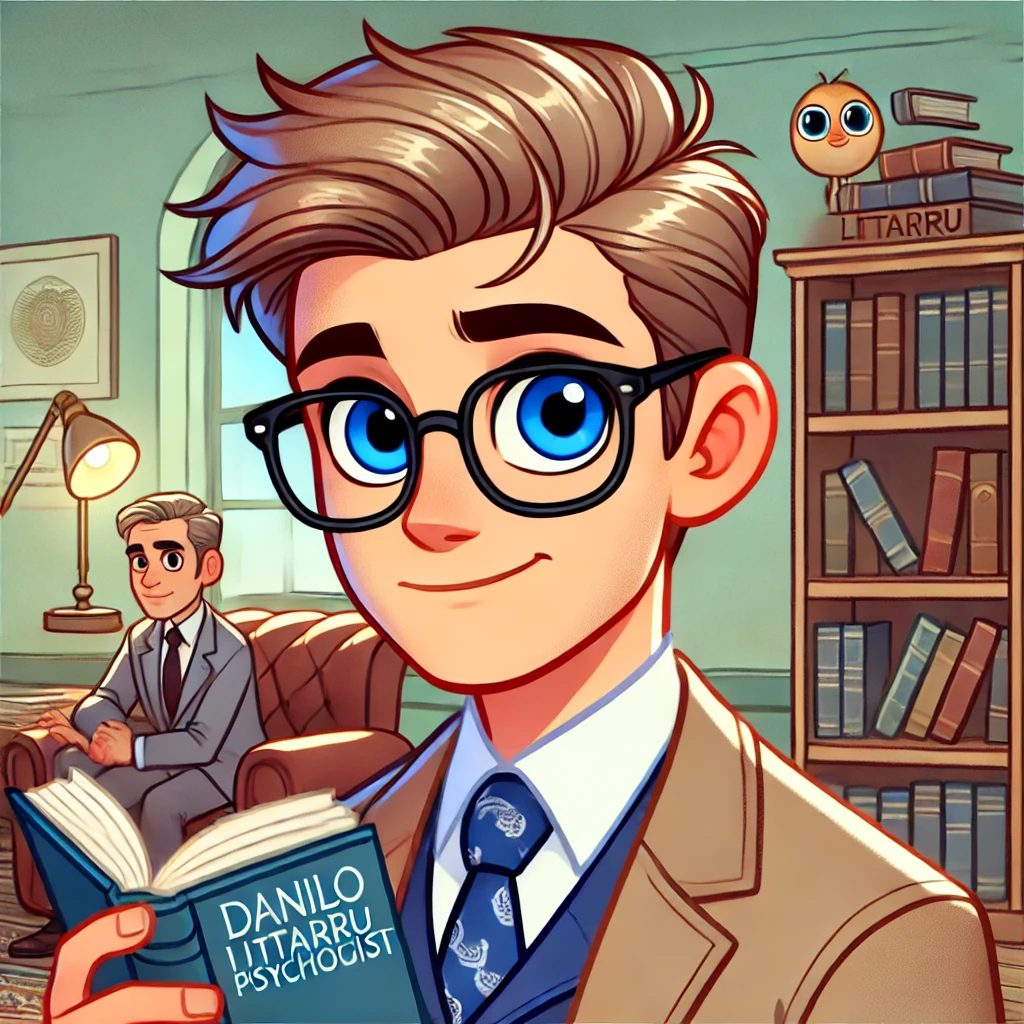Il nervo vago, spesso chiamato “il grande sconosciuto”, è in realtà uno degli attori principali del nostro equilibrio psico-fisico. È il decimo nervo cranico e corre come un’autostrada invisibile dal cervello fino agli organi più vitali: cuore, polmoni, stomaco, intestino.
Un regista silenzioso del corpo
Il nervo vago è la colonna portante del sistema nervoso parasimpatico, quello che contrasta lo stress e favorisce il recupero.
- Rallenta il battito cardiaco quando l’ansia accelera il cuore.
- Regola la respirazione, favorendo profondità e calma.
- Influenza la digestione, coordinando i movimenti intestinali.
- Partecipa all’equilibrio emotivo, perché in dialogo costante con l’amigdala e la corteccia prefrontale.
Quando il vago funziona bene, ci sentiamo centrati; quando è ipofunzionante, possono emergere tachicardia, disturbi gastrointestinali, insonnia, ansia.
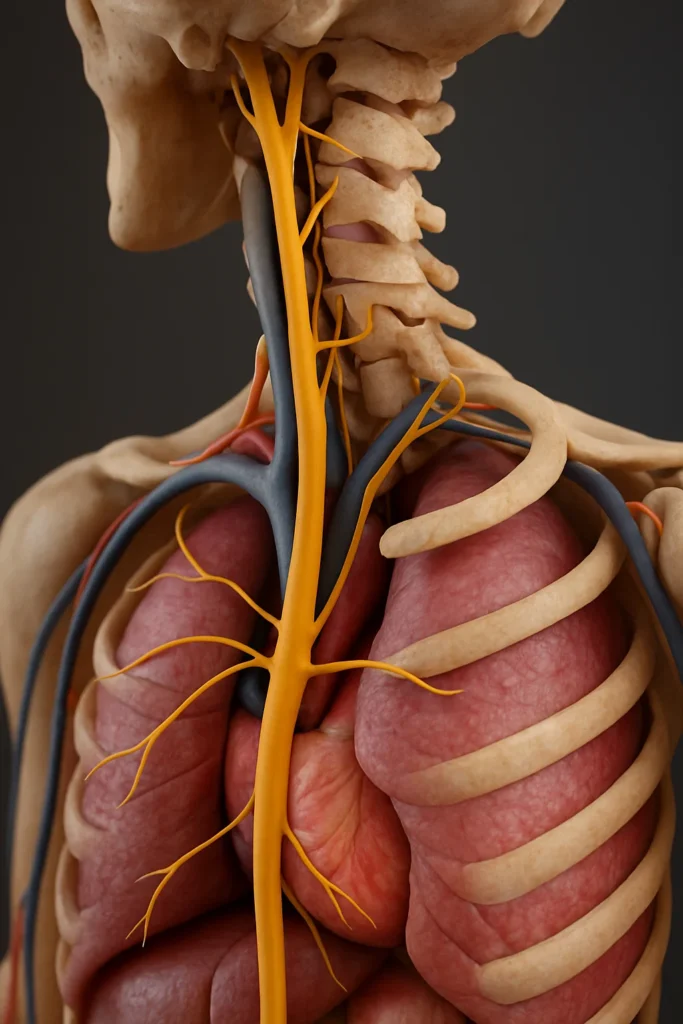
Il nervo vago e la mente
Le neuroscienze hanno mostrato che il vago è fondamentale anche per la regolazione emotiva. La teoria polivagale di Stephen Porges spiega come questo nervo agisca da “radar sociale”: ci aiuta a sentirci sicuri, a connetterci con gli altri, a modulare le risposte allo stress.
Un vago “allenato” favorisce resilienza, calma interiore e maggiore capacità di concentrazione. Non è un caso che molte pratiche educative e terapeutiche oggi inseriscano tecniche di respirazione diaframmatica, mindfulness e biofeedback vagale.
Esempi pratici in ambito didattico
Nelle scuole, attivare il nervo vago può diventare una strategia semplice ma potente:
- Respiri lenti collettivi all’inizio della lezione → abbassano la tensione e favoriscono l’attenzione.
- Pausa attiva con stretching e vocalizzi → stimolano il vago e rimettono in moto le energie cognitive.
- Spazi di silenzio guidato → aiutano studenti ansiosi a recuperare controllo.
In alcuni progetti pilota, brevi sessioni di esercizi di coerenza cardiaca hanno ridotto i livelli di ansia e migliorato le prestazioni mnemoniche degli studenti.
Conclusione
Il nervo vago non è solo un dettaglio anatomico: è una vera cerniera tra corpo, emozioni e mente. Conoscerlo e stimolarlo significa imparare a regolare se stessi, a scuola come nella vita quotidiana.