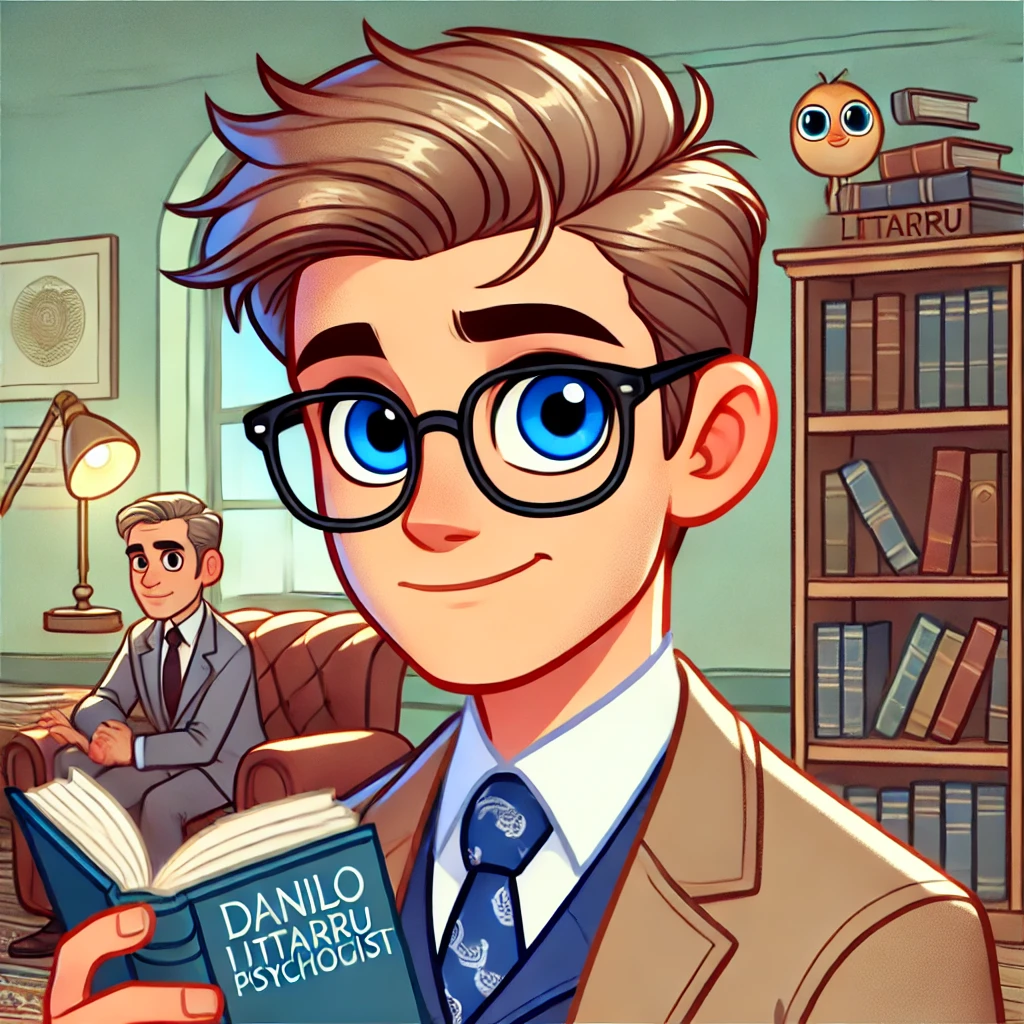ARFID: La nuova frontiera dei disturbi alimentari nell’infanzia e adolescenza
Nell’orizzonte clinico dei disturbi dell’alimentazione, l’ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) rappresenta una nuova e insidiosa declinazione, distinta dall’anoressia nervosa e dalla bulimia per l’assenza di preoccupazioni circa il peso corporeo o l’immagine di sé. L’ARFID è caratterizzato da un’evidente restrizione alimentare che conduce a deficit nutrizionali significativi, compromissione della crescita e disfunzioni psicosociali. Il disturbo si manifesta prevalentemente in età evolutiva e presenta una complessità diagnostica che richiede un approccio multidisciplinare.
Recenti ricerche condotte in Europa, tra cui lo studio multicentrico “Pica, ARFID, and Rumination Disorder” (Koomar et al., 2021), stimano una prevalenza di ARFID tra l’1,5% e il 5% della popolazione pediatrica. Un’indagine condotta nel 2023 su scala europea dalla European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) evidenzia come il 3,2% dei bambini tra i 7 e i 14 anni manifesti sintomi compatibili con una diagnosi di ARFID.

La diagnosi di ARFID richiede un’attenta anamnesi alimentare, la valutazione nutrizionale e l’esclusione di condizioni mediche sottostanti. Strumenti come l’”Nine Item ARFID Screen” (NIAS) si sono rivelati utili nel supportare la pratica clinica, offrendo una prima identificazione di soggetti a rischio.
Fondamentale è la distinzione tra neofobia alimentare fisiologica, tipica dell’età prescolare, e restrizione patologica che persiste oltre le fasi evolutive normali.
I dati suggeriscono un incremento delle diagnosi, complice una maggiore sensibilità clinica e l’ampliamento dei criteri diagnostici rispetto ai tradizionali disturbi alimentari. Particolarmente colpiti risultano i soggetti con preesistenti disturbi d’ansia o dello spettro autistico, nei quali la selettività alimentare assume connotazioni patologiche.
Il trattamento dell’ARFID si configura come un percorso complesso e altamente personalizzato. Secondo le linee guida europee recenti, le strategie terapeutiche più efficaci comprendono la Terapia cognitivo-comportamentale adattata per ARFID con interventi focalizzati sulla progressiva esposizione ai cibi evitati, connesso a un supporto nutrizionale specialistico con piani alimentari calibrati sulle necessità del bambino/adolescente. Resta fondamentale il coinvolgimento familiare, strumento fondamentale per sostenere il cambiamento comportamentale e migliorare l’aderenza al trattamento. In casi particolarmente complessi, si rende necessaria l’integrazione con terapie farmacologiche, mirate alla gestione dell’ansia associata alla fobia alimentare.

L’ARFID si impone come un disturbo in forte ascesa nella psicopatologia evolutiva, richiedendo un riconoscimento precoce e un intervento specialistico tempestivo. La crescente mole di dati epidemiologici e clinici a livello europeo impone alla comunità scientifica un impegno costante nell’affinare strumenti diagnostici e strategie terapeutiche, al fine di garantire a bambini e adolescenti un percorso di cura efficace e rispettoso delle loro peculiari esigenze di crescita.