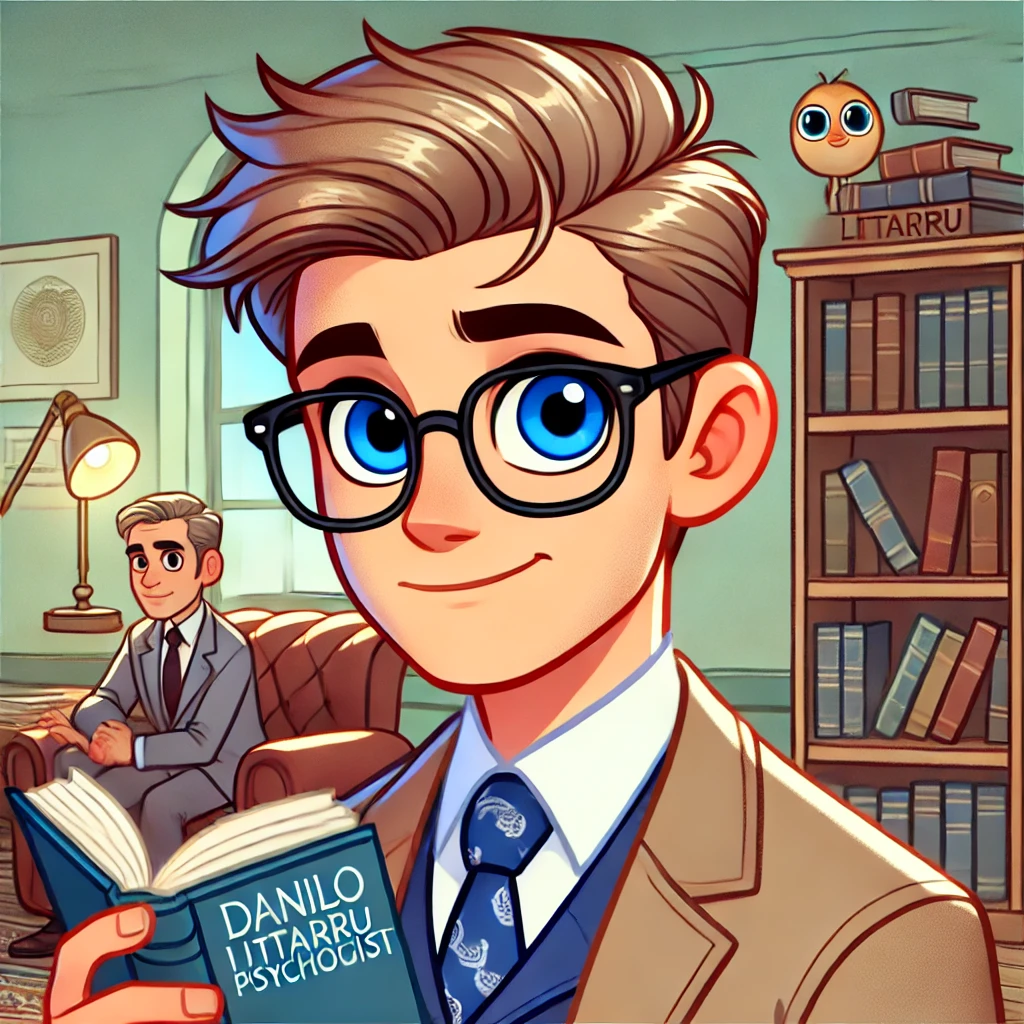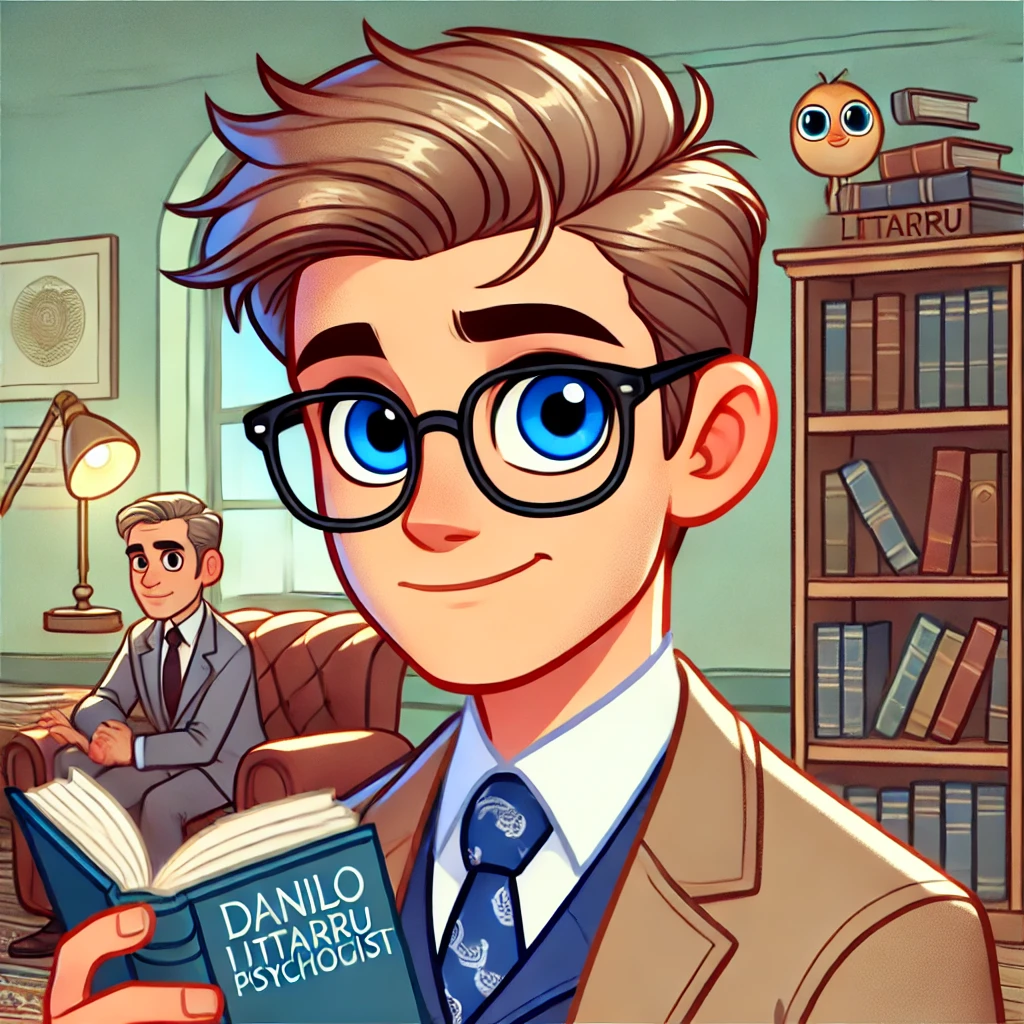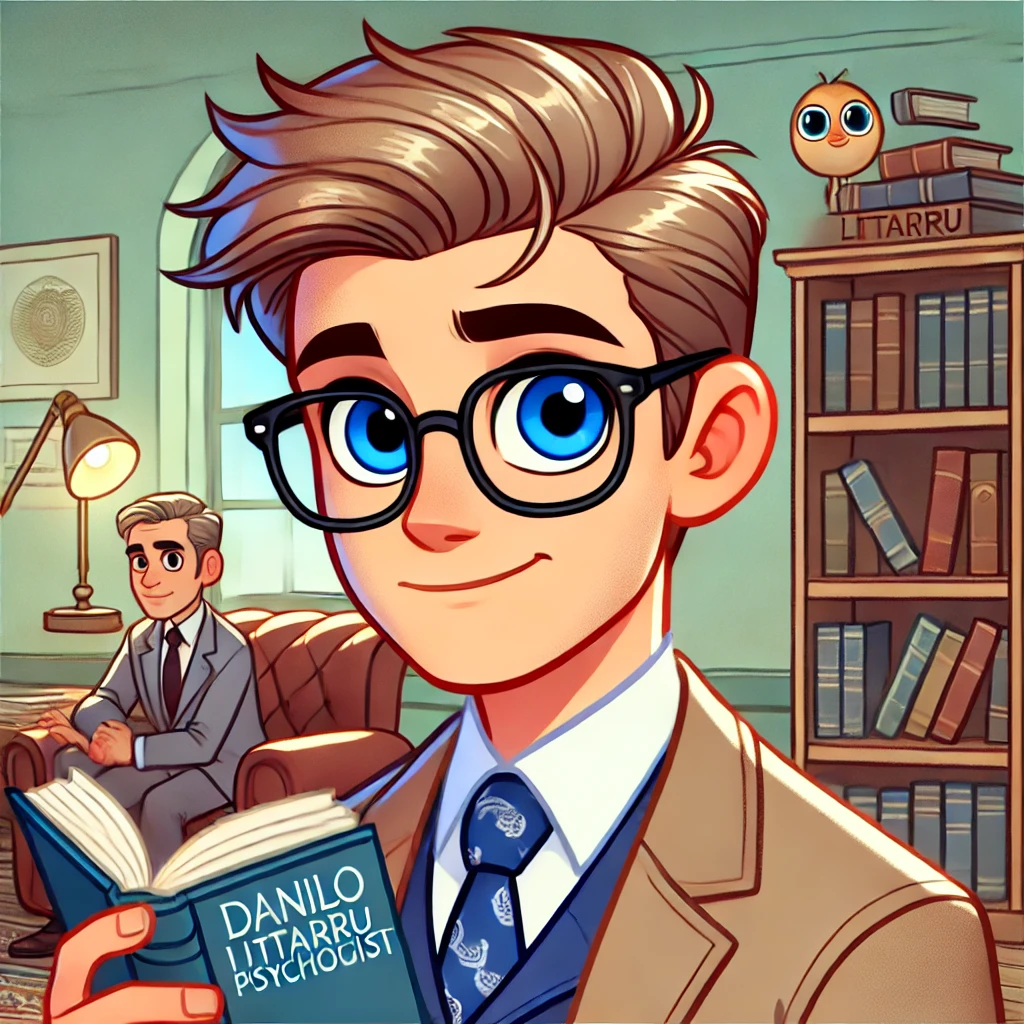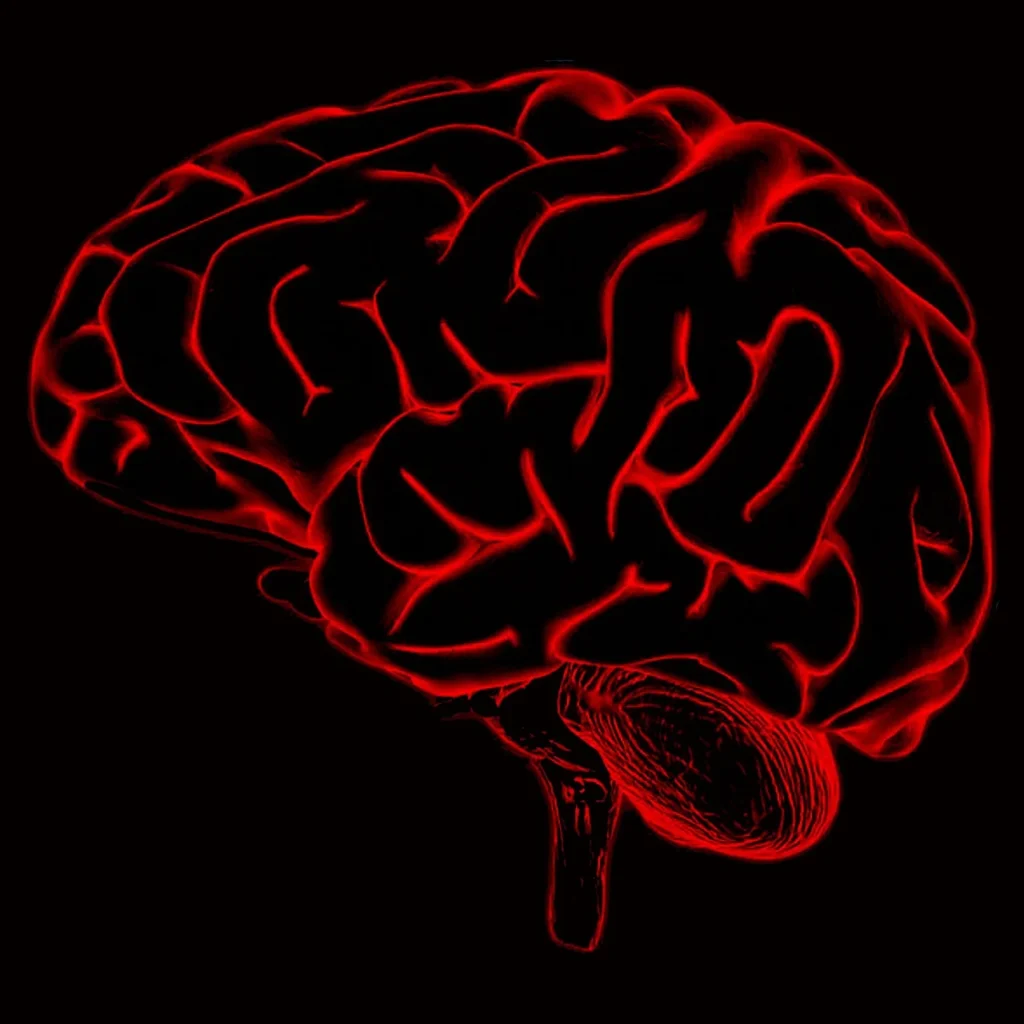Non è solo violenza. Non è solo cronaca.
Dietro il richiamo delle lame e dell’esibizione muscolare si muove un bisogno più profondo: essere visti, temuti, riconosciuti.
Introduzione
Negli ultimi anni, l’aumento di episodi che coinvolgono coltelli, lame e armi improprie, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti, viene spesso letto come un segnale di degrado, devianza o criminalità precoce.
Ma questa lettura rischia di essere riduttiva.
La domanda più scomoda — e forse più necessaria — è un’altra:
cosa ci sta sfuggendo sul piano simbolico, psicologico e relazionale?
Perché oggi la lama non è solo uno strumento: diventa segno di potere, estensione del corpo, risposta a una fragilità che non trova parole.
La lama come protesi identitaria
In molte dinamiche adolescenziali e giovanili, il coltello non rappresenta tanto l’intenzione di ferire, quanto il bisogno di sentirsi forti in un mondo percepito come ostile.
Quando:
- l’identità è fragile
- l’autostima è costruita sullo sguardo altrui
- il riconoscimento passa dalla paura che si incute
la forza fisica diventa linguaggio.
La lama, allora, non è aggressione pura, ma tentativo disperato di controllo.
Il ritorno del corpo come risposta al vuoto
Viviamo in una società iper-digitale, in cui il corpo è spesso:
- esibito
- filtrato
- performativo
Eppure, paradossalmente, mai davvero abitato.
Il culto della forza muscolare, del corpo potente, della postura dominante, nasce spesso come reazione a:
- impotenza emotiva
- assenza di confini interiori
- mancanza di modelli autorevoli
Il muscolo diventa corazza.
La lama diventa garanzia.
Mascolinità ferita e narrazioni tossiche
In particolare nei maschi adolescenti, la fascinazione per la forza e per l’arma è spesso legata a una mascolinità non accompagnata, lasciata sola a costruirsi tra:
- modelli iperviolenti
- estetica della sopraffazione
- mito della virilità invincibile
Quando non si insegna a reggere la frustrazione, il corpo prende il posto della parola.
E la lama prende il posto del limite.
Non è solo devianza: è una domanda educativa
Ridurre il fenomeno a “ragazzi violenti” o “baby gang” è rassicurante, ma inefficace.
Perché ciò che emerge è spesso una domanda muta:
“Come posso sentirmi qualcuno?”
“Come posso non essere invisibile?”
La risposta non può essere solo repressiva.
Serve un lavoro profondo su:
- educazione emotiva
- gestione della rabbia
- costruzione dell’identità
- presenza adulta significativa
La vera prevenzione passa dalle relazioni
Dove esistono:
- adulti che ascoltano
- spazi di parola
- riconoscimento autentico
la lama perde fascino.
Perché la forza più grande non è quella che incute paura, ma quella che regge il conflitto senza distruggere.
Conclusione
Maneggiare lame e coltelli “con cura” non è solo un avvertimento fisico.
È un monito culturale.
Ciò che davvero dobbiamo maneggiare con attenzione è:
- la fragilità non vista
- la rabbia non nominata
- il bisogno di riconoscimento
Perché quando la parola manca, il corpo urla.
E a volte lo fa con una lama in mano.