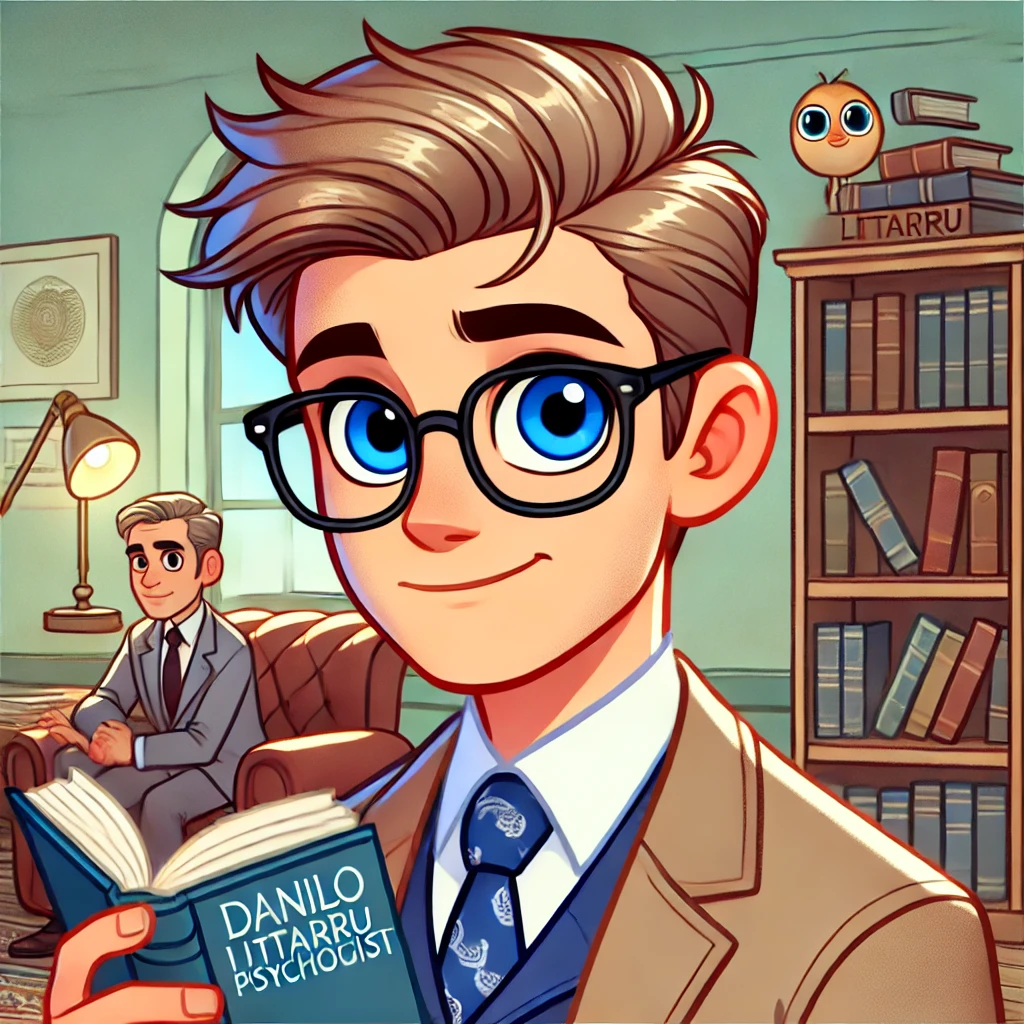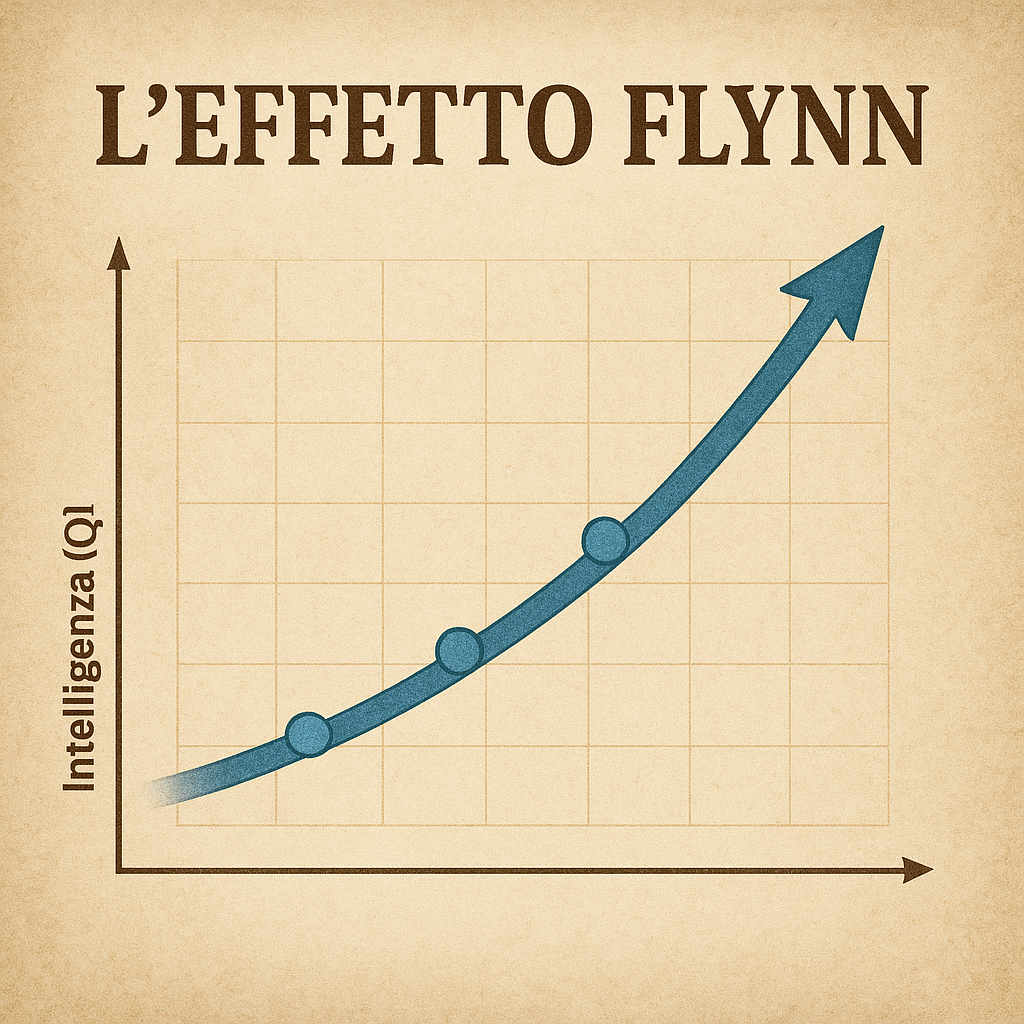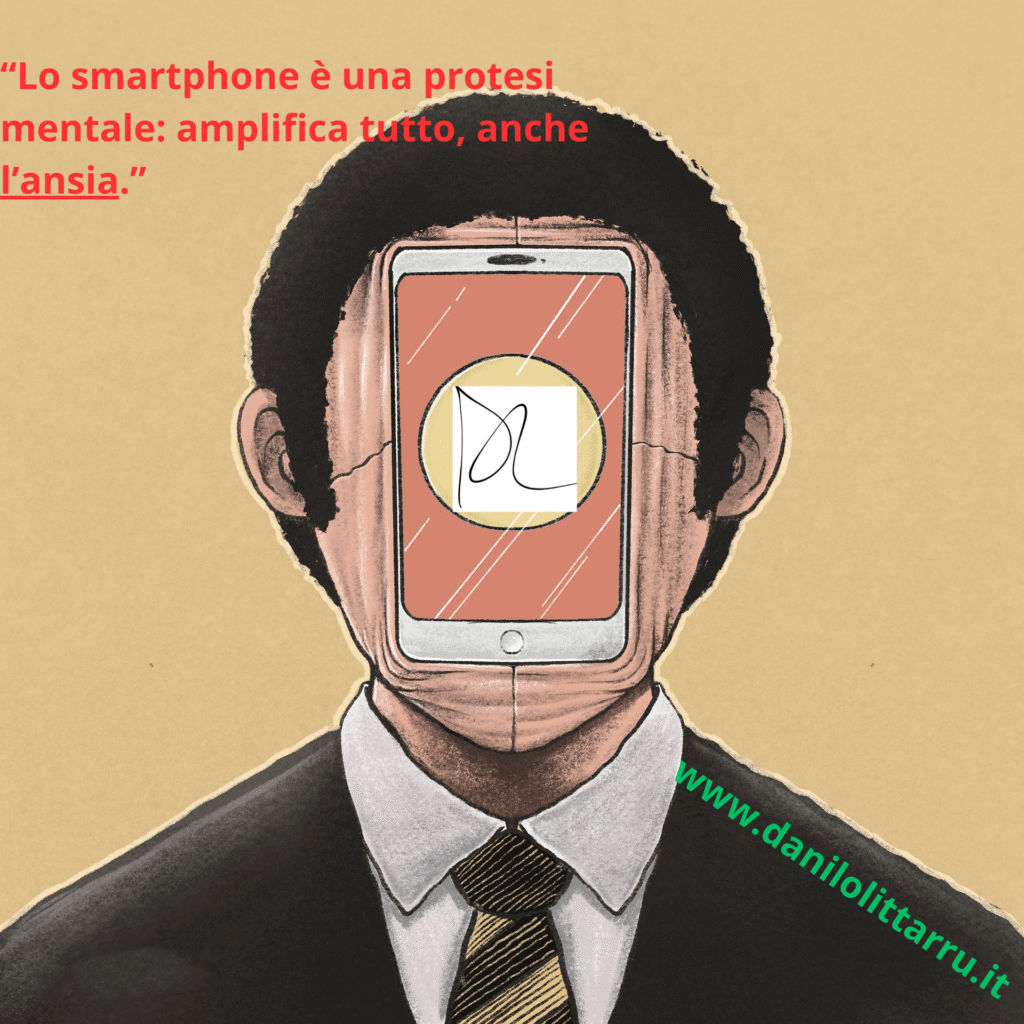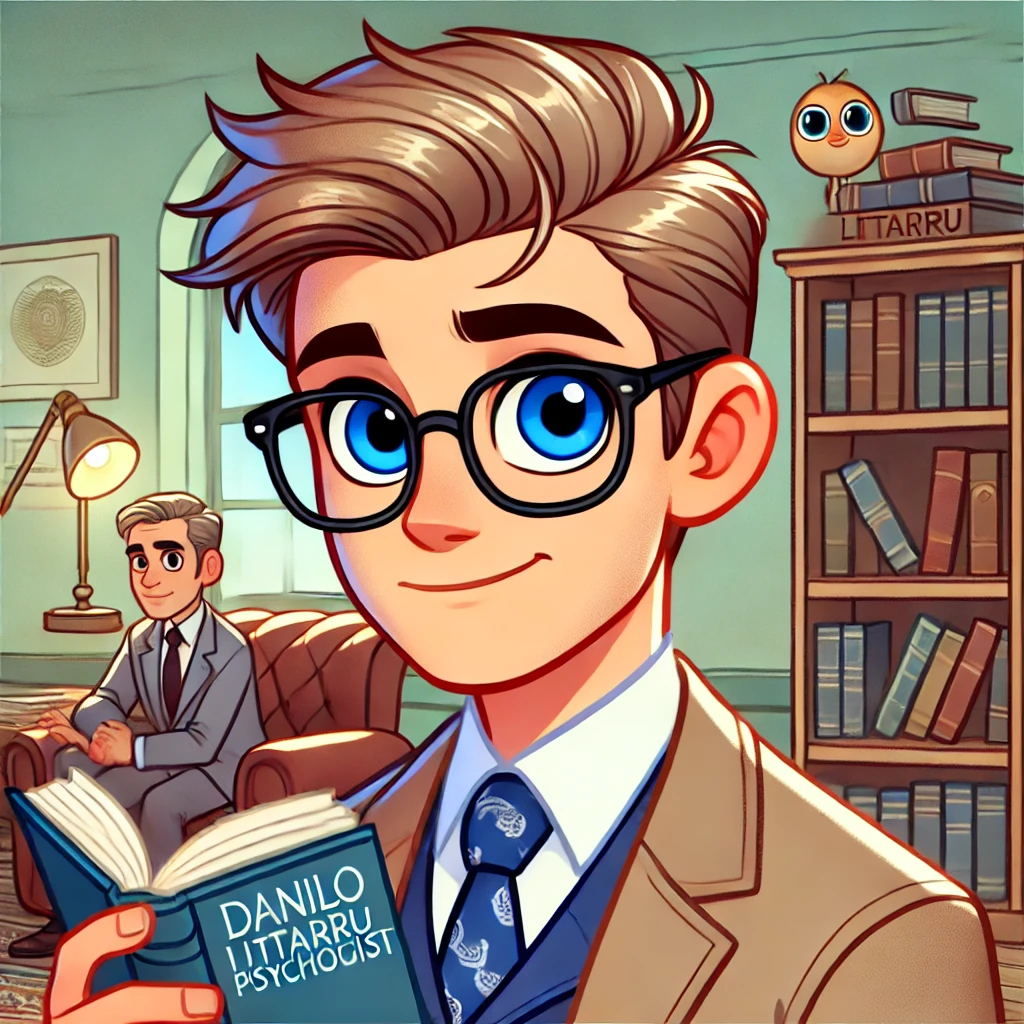“Ogni volta che togliamo una piazza al gioco dei bambini, non perdiamo solo uno spazio: perdiamo un pezzo di futuro, di libertà e di comunità.”
Introduzione
Le piazze, i parchi e i cortili un tempo erano il cuore pulsante del gioco infantile. Oggi, invece, quegli stessi spazi vengono progressivamente colonizzati da tavolini, dehors e attività commerciali. Il risultato è un impoverimento silenzioso, ma drammatico, per le nuove generazioni: la perdita del gioco libero, spontaneo, non mediato dagli adulti.
Il valore del gioco libero
Il gioco libero rappresenta una dimensione pedagogica irrinunciabile:
- permette di sperimentare regole e conflitti, senza un adulto a fare da giudice;
- stimola la creatività e la capacità di adattamento;
- favorisce l’aggregazione sociale spontanea, creando comunità tra pari;
- sviluppa resilienza, perché il rischio – cadere, litigare, sbagliare – diventa palestra di crescita.
Non si tratta soltanto di divertimento: è una palestra educativa naturale che plasma il carattere e le competenze sociali di bambini e adolescenti.

La paura che soffoca la libertà
Negli ultimi decenni la società occidentale ha sviluppato una forma di paura diffusa: si vedono pericoli ovunque, si immaginano minacce dietro ogni angolo. Per rispondere a questa ansia collettiva, gli adulti hanno ipercontrollato i luoghi e i tempi del gioco.
Così, il bambino non gioca più nella piazza, ma nel campo sportivo organizzato. Non inventa regole, ma segue quelle codificate da un istruttore. Non costruisce avventure, ma partecipa ad attività strutturate e a pagamento.
Questa trasformazione ha un costo: il prezzo della sicurezza assoluta è la perdita dell’autonomia, della creatività, della capacità di affrontare l’imprevisto.
Le conseguenze psicologiche e sociali
Oggi ne vediamo già le conseguenze:
- adolescenti chiusi in casa, rifugiati nel digitale;
- giovani meno capaci di gestire conflitti reali;
- una crescita di fragilità psicologica, ansia e insicurezza;
- una perdita di radicamento comunitario: la città non è più un luogo da abitare, ma da consumare.
Restituire spazi al gioco libero
Restituire ai bambini le piazze e i parchi non è un vezzo nostalgico, ma una necessità pedagogica e psicologica.
Serve una politica urbanistica e sociale che ridia fiato all’infanzia, che liberi spazi dai tavolini del business e li restituisca al gioco, all’aggregazione, alla vita.
Un bambino che gioca liberamente costruisce cittadinanza, fiducia e comunità. E una società che glielo permette, investe nel suo futuro.