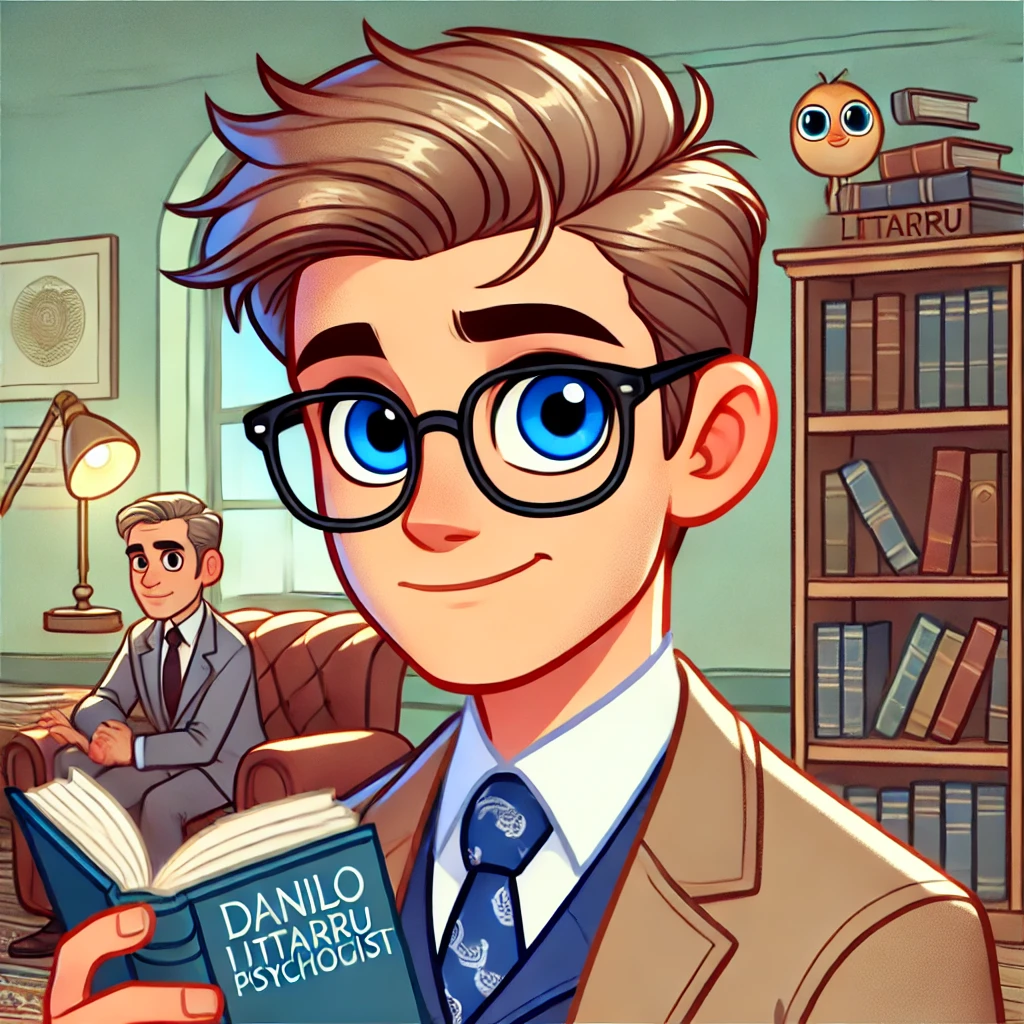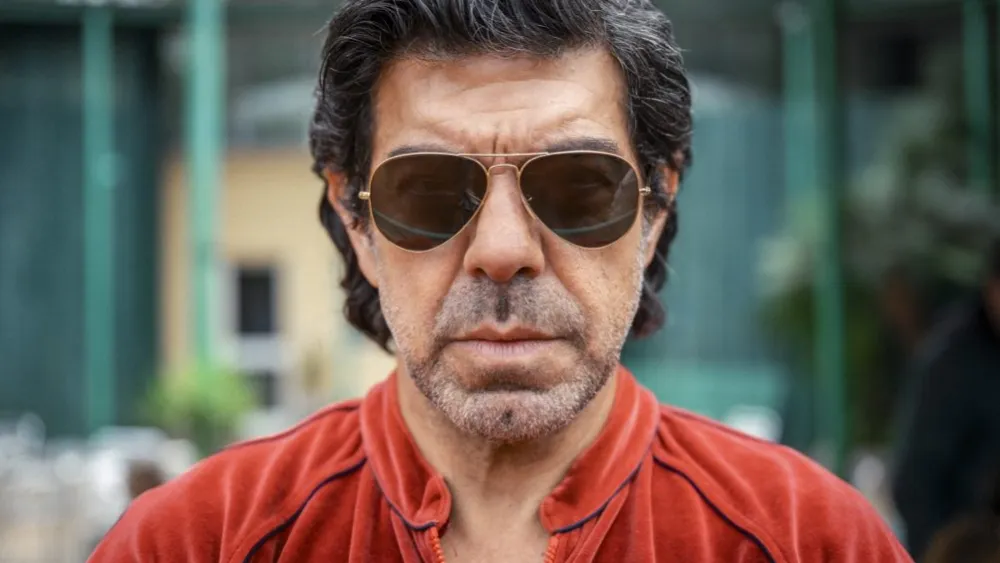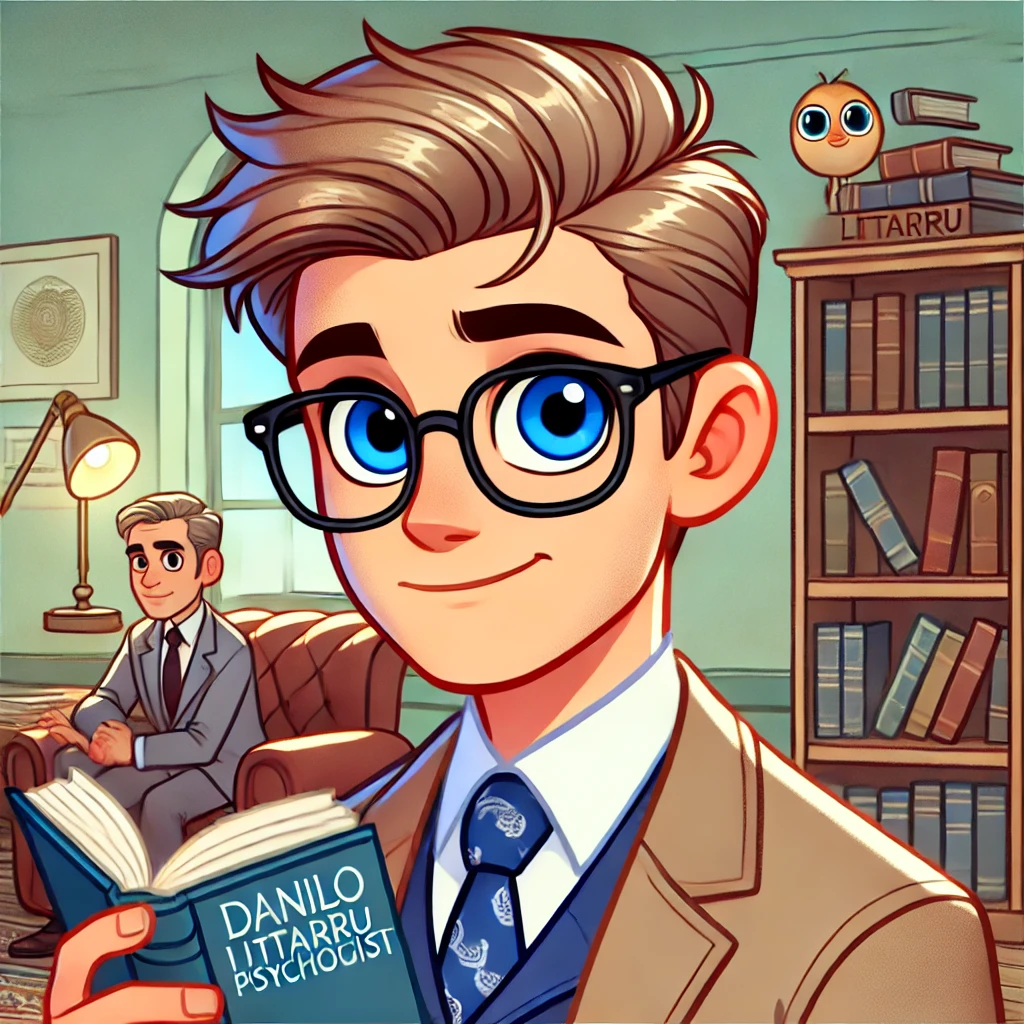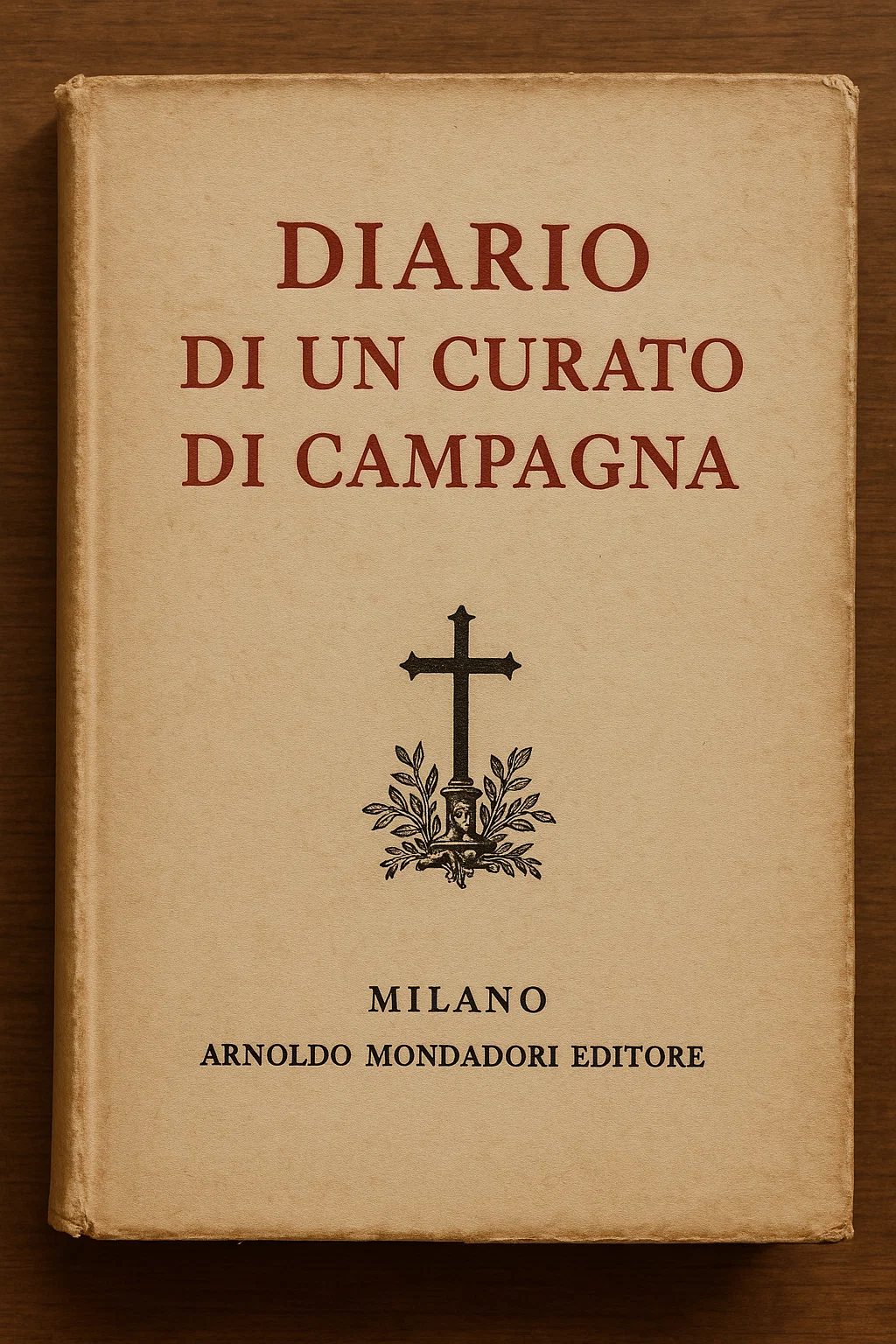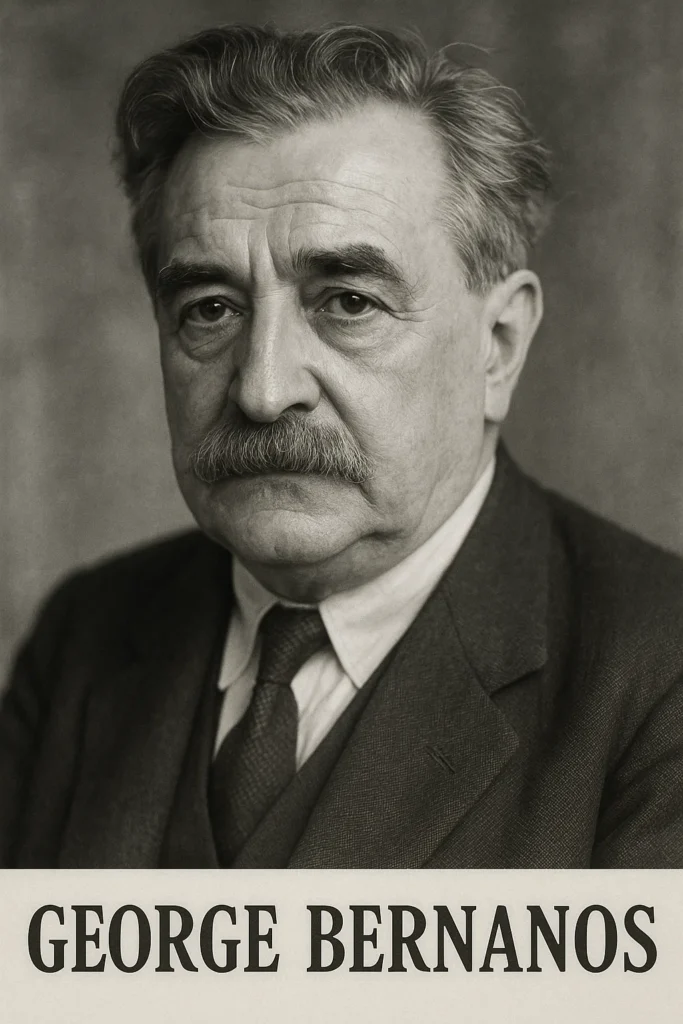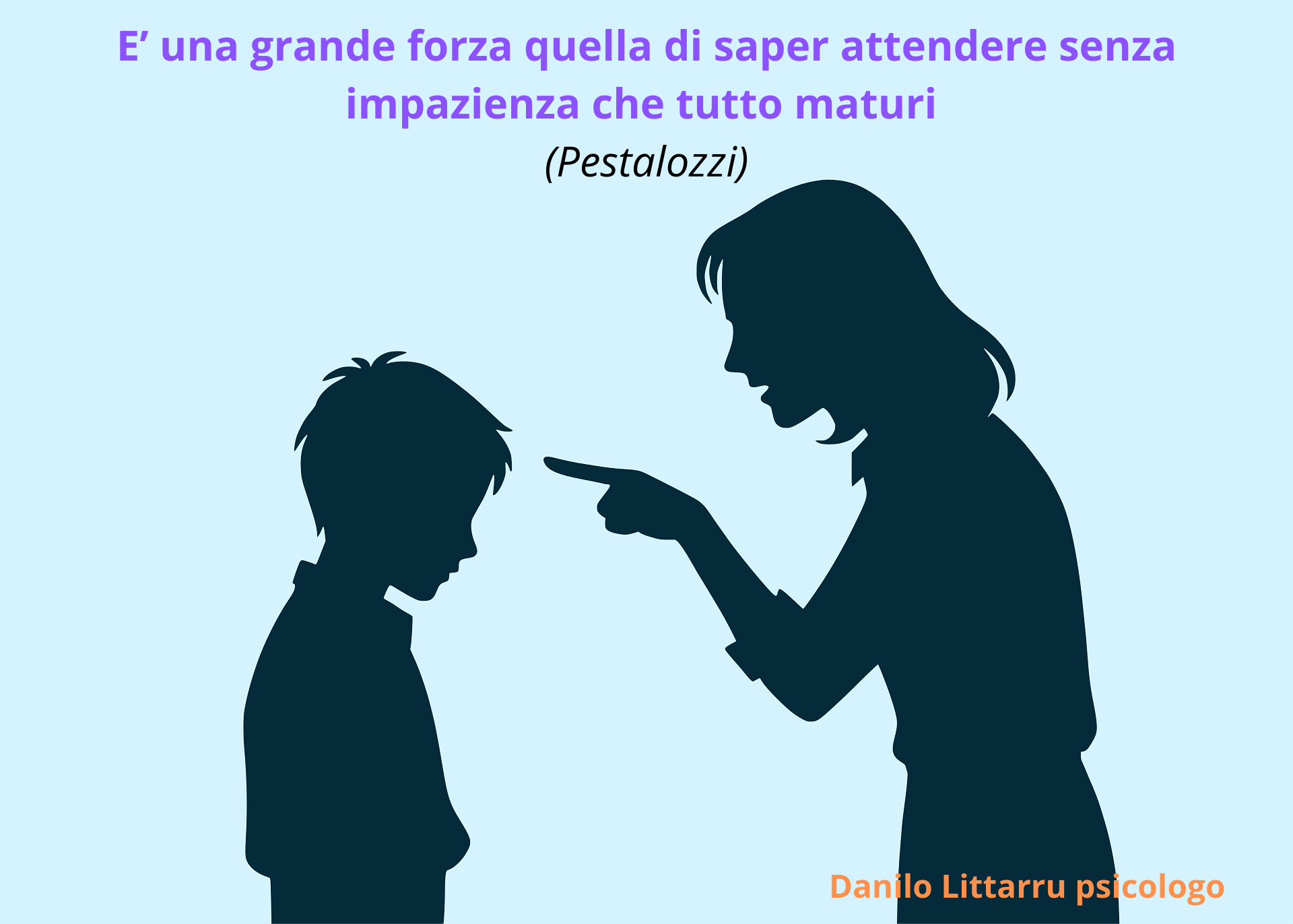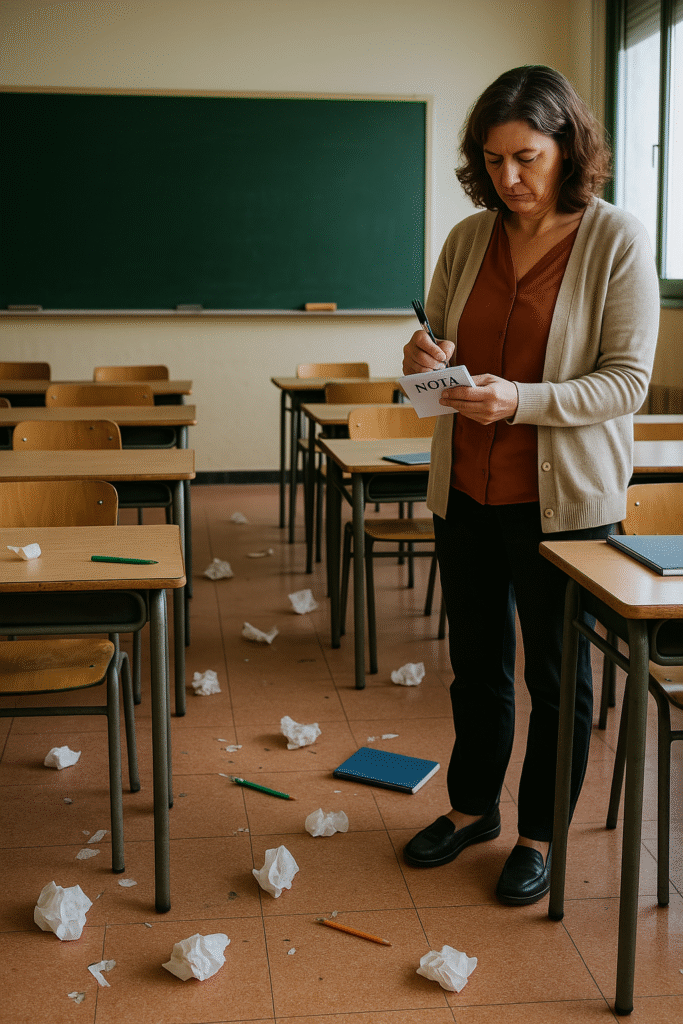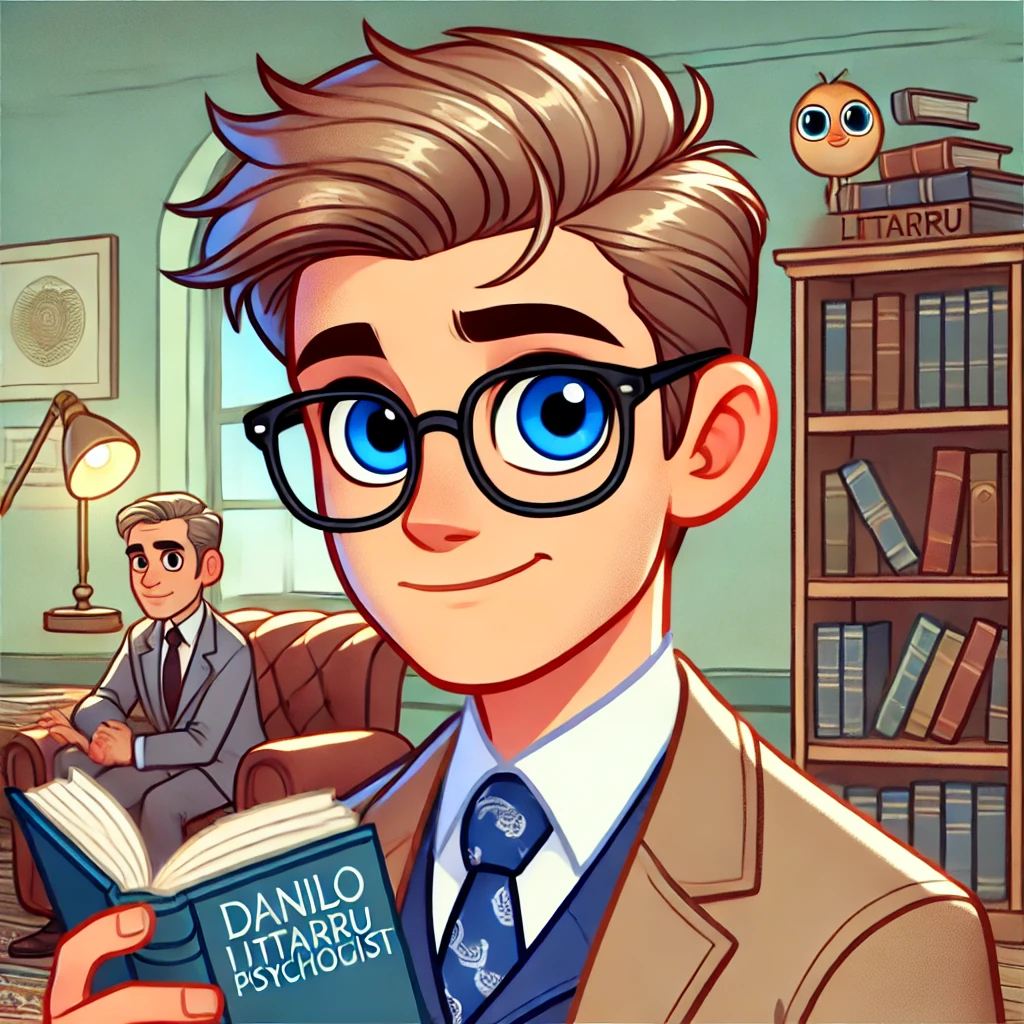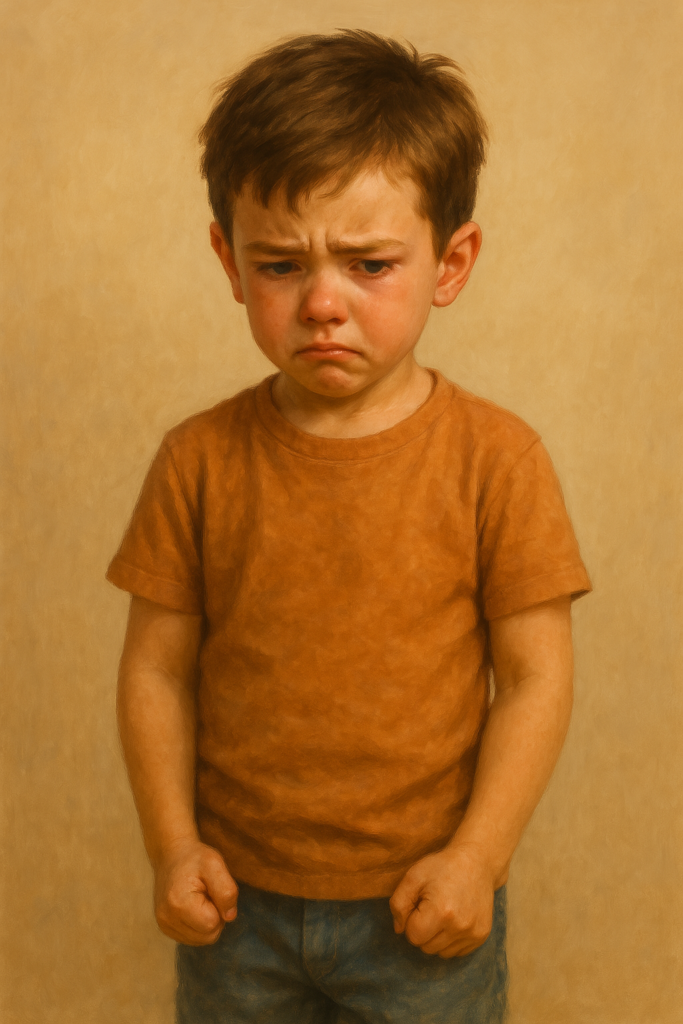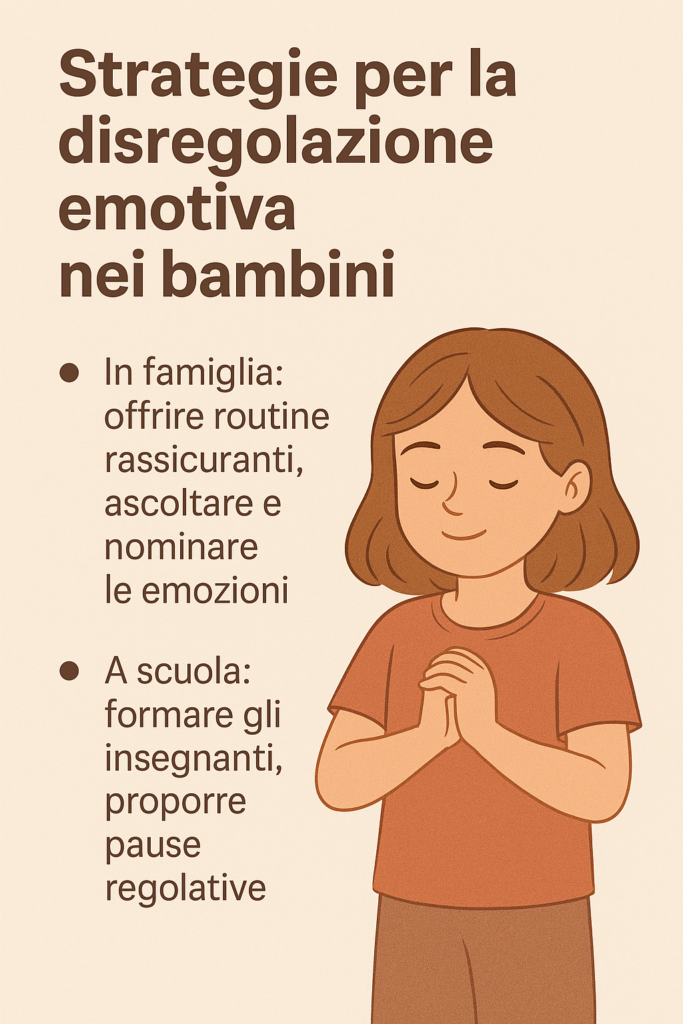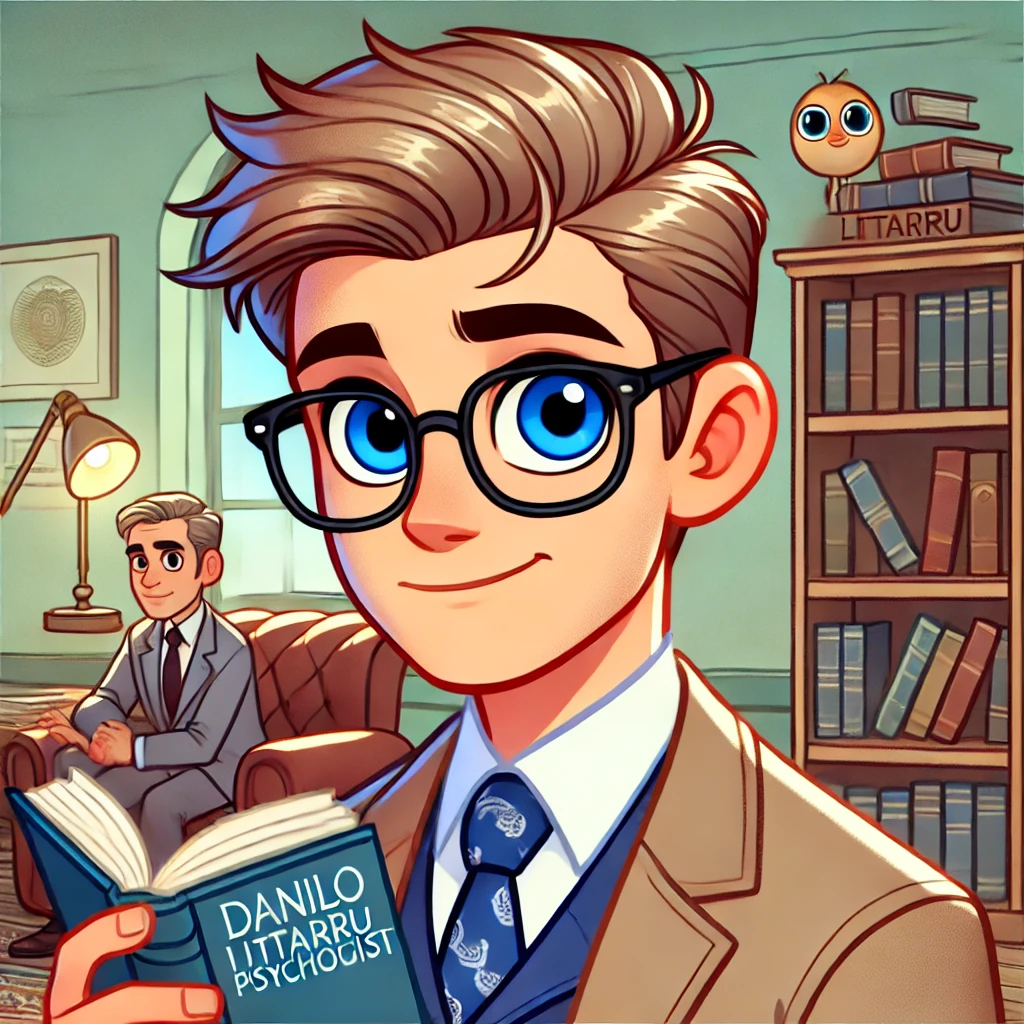Perché la psicologia dello sviluppo invita alla prudenza.
Una lettura psicologica e pedagogica tra Piaget ed Erikson
Introduzione
Il recente caso giudiziario di La Spezia, che ha autorizzato un cambio di sesso a 13 anni, riapre un dibattito complesso e delicato.
Al di là delle letture ideologiche, la questione interpella direttamente la psicologia dello sviluppo e la pedagogia:
è evolutivamente adeguato assumere decisioni irreversibili in una fase in cui l’identità è ancora in costruzione?
Per rispondere in modo rigoroso è necessario tornare ai classici dello sviluppo umano, in particolare Jean Piaget e Erik Erikson.

Adolescenza: un’età di trasformazione, non di cristallizzazione
A 13 anni l’adolescente si trova nel pieno di:
- cambiamenti corporei intensi (pubertà);
- riorganizzazione dell’immagine di sé;
- oscillazioni emotive e identitarie;
- bisogno profondo di riconoscimento.
L’adolescenza non è una fase di stabilità, ma di plasticità.
Proprio per questo motivo, la psicologia evolutiva invita alla prudenza quando si tratta di decisioni definitive.
Piaget: capacità di pensiero astratto ≠ maturità decisionale
Secondo Piaget, intorno ai 12–13 anni il soggetto accede allo stadio delle operazioni formali, che consente:
- ragionamento astratto
- formulazione di ipotesi
- capacità argomentativa
Tuttavia, Piaget sottolinea un aspetto spesso trascurato:
la struttura cognitiva è ancora in riorganizzazione.
L’adolescente può pensare una scelta, ma non necessariamente:
- anticiparne le conseguenze a lungo termine;
- integrarla stabilmente nella propria identità futura;
- sostenerla nel tempo.
Dal punto di vista piagetiano, cristallizzare una decisione irreversibile significa interrompere il processo di accomodamento, fissando un equilibrio prima che si sia realmente formato.
Erikson: identità vs confusione di ruolo
Per Erikson, l’adolescenza è dominata dal conflitto evolutivo:
Identità vs Confusione di ruolo
Questo significa che:
- il dubbio è fisiologico;
- la confusione non è patologica;
- l’oscillazione identitaria è parte integrante dello sviluppo.
Erikson introduce un concetto chiave: la moratoria psicosociale, ovvero un tempo protetto in cui l’adolescente può:
- sperimentare ruoli;
- esplorare vissuti;
- rimandare decisioni definitive.
Una scelta irreversibile a 13 anni annulla la moratoria, trasformando una fase di ricerca in una definizione anticipata.
Le ricadute definitive: un nodo etico ed educativo
Il punto critico non è il riconoscimento della sofferenza, che va sempre ascoltata e accolta.
Il nodo centrale è l’irreversibilità.
Dal punto di vista psicologico e pedagogico:
- ciò che è reversibile favorisce l’esplorazione;
- ciò che è irreversibile chiude il campo esperienziale.
L’adolescente ha diritto:
- al ripensamento;
- alla regressione;
- alla contraddizione;
- al tempo.
Il rischio dei precedenti
Un precedente giuridico non riguarda mai solo il singolo caso.
Produce:
- modelli impliciti;
- aspettative sociali;
- prassi educative e cliniche.
Il rischio pedagogico è che la complessità venga ridotta a procedura, e che una scelta eccezionale venga percepita come scorciatoia.
La pedagogia, invece, lavora sul tempo lungo, non sull’accelerazione.
Una proposta alternativa: accompagnare, non anticipare
Una prospettiva realmente tutelante prevede:
- un percorso pedagogico e psicologico strutturato;
- una durata significativa (almeno 4 anni);
- l’attraversamento completo dell’adolescenza.
Un percorso lungo consente di:
- osservare la stabilità del vissuto nel tempo;
- distinguere tra sofferenza transitoria e nucleo identitario persistente;
- proteggere il minore da decisioni premature.
Non è una negazione dell’identità, ma una cura del processo evolutivo.
Conclusione
La psicologia dello sviluppo insegna che non tutto ciò che è pensabile è già decidibile.
Piaget parlerebbe di strutture cognitive non stabilizzate.
Erikson parlerebbe di identità in moratoria.
Tutelare il tempo dello sviluppo è una responsabilità adulta, clinica ed educativa.