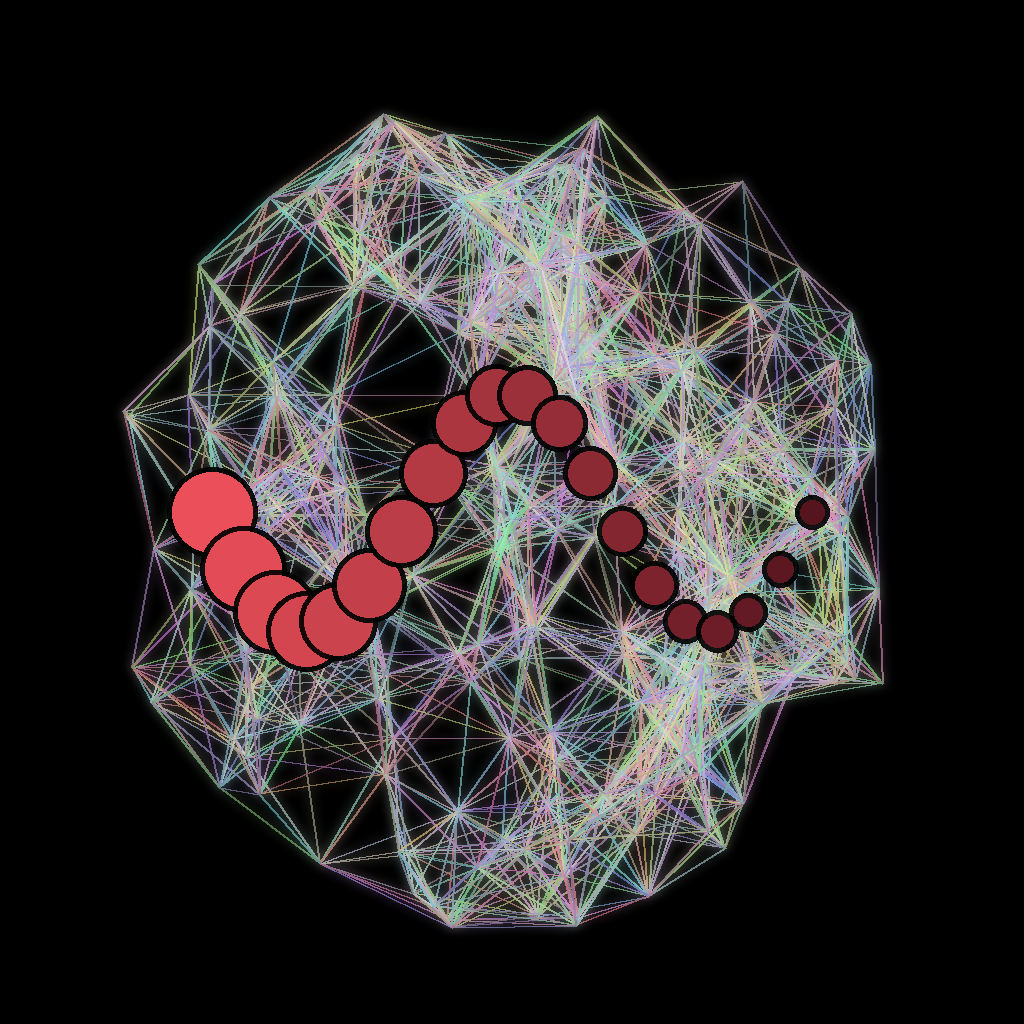Il peso della nostra stessa durezza
Esiste una forma di crudeltà che non ha bisogno di nemici: è quella che esercitiamo contro noi stessi.
È la voce che sussurra: “non sei abbastanza”, “hai fallito di nuovo”, “non te lo meriti”.
Molti di noi convivono con un giudice interiore implacabile, ereditato da antiche esperienze di rimprovero, da modelli educativi inflessibili o da relazioni in cui l’amore era condizionato alla performance.
La durezza verso sé stessi è una corazza, ma anche una prigione: nasce per proteggerci, ma finisce per ferirci.
Secondo la psicologia umanistica di Carl Rogers, “l’essere umano ha una tendenza innata alla realizzazione di sé, ma questa può essere soffocata dal bisogno di approvazione esterna”.
Quando la nostra autostima dipende dal giudizio altrui, ogni errore diventa una minaccia identitaria, un fallimento da espiare.
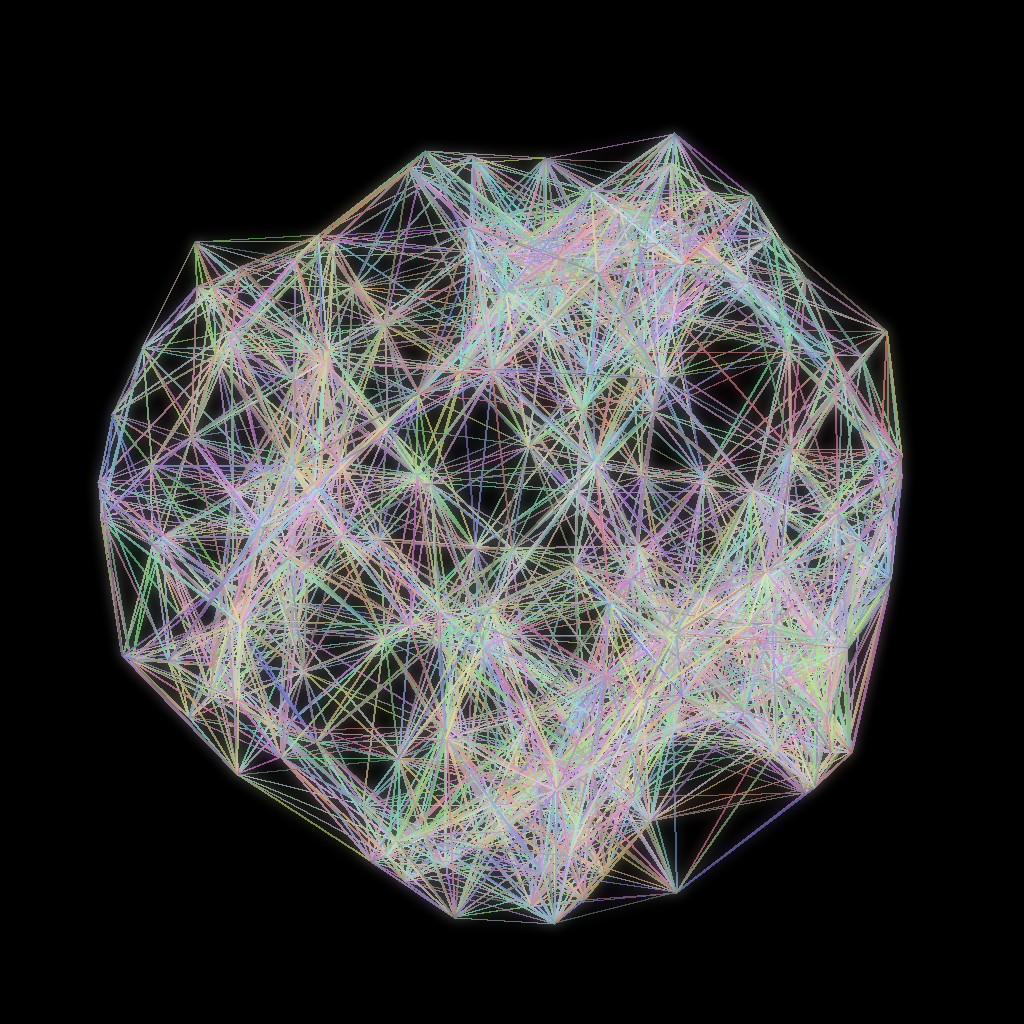
L’autosabotaggio: il nemico invisibile
Perché ci auto-sabotiamo?
Perché, pur desiderando il bene, ci ostacoliamo nei momenti decisivi?
La risposta è complessa, ma spesso radicata nella paura: paura di non essere amabili, paura del successo, paura del cambiamento.
Il cervello, per paradosso, preferisce la sicurezza del dolore conosciuto all’incertezza della libertà.
Si tratta di un meccanismo di omeostasi emotiva: anche se nocivo, ciò che è familiare ci dà l’illusione di controllo.
E così ripetiamo schemi, relazioni tossiche, scelte autolimitanti.
La psicanalista Karen Horney definiva questa tendenza “autodisprezzo inconscio”: la spinta distruttiva dell’Io che cerca, in modo paradossale, di punirsi per non aver corrisposto a un ideale di perfezione.
La colpa come anestetico dell’impotenza
Attribuirsi la colpa di ogni fallimento è un modo per non affrontare la complessità del reale.
Dire “è tutta colpa mia” ci restituisce una sensazione illusoria di controllo: se tutto dipende da me, allora posso rimediare, posso cambiare.
Ma la verità è che molte cose non dipendono da noi.
La colpa diventa così una forma di difesa dalla vulnerabilità.
Nietzsche scriveva che “l’uomo è un animale che può promettere”, ma anche uno che può rimuginare.
Il rimuginio è la punizione che infliggiamo a noi stessi per non poter cambiare il passato.
Riconciliarsi con la propria fragilità
Guarire dalla durezza interiore significa accettare l’imperfezione come forma di umanità.
Non c’è crescita senza errore, né autenticità senza fragilità.
La psicologia della self-compassion (Kristin Neff, 2011) ci insegna che trattarsi con gentilezza non è debolezza, ma un atto di coraggio: riconoscere il proprio dolore, accoglierlo e trasformarlo.
Essere indulgenti con sé stessi non significa deresponsabilizzarsi, ma riconoscere che il cammino umano è fatto di cadute.
Ogni errore, se ascoltato, diventa insegnamento. Ogni fallimento può diventare rivelazione.
Il perdono di sé come atto rivoluzionario
Perdonarsi non è un atto di resa, ma di liberazione.
È smettere di identificarsi con la propria ombra.
È riconoscere che il bambino che siamo stati, con le sue paure e i suoi desideri, merita compassione, non giudizio.
Come scriveva Jung, “nessuno diventa illuminato immaginando figure di luce, ma rendendo cosciente la propria oscurità”.
La dolcezza verso sé stessi è la forma più alta di consapevolezza: il punto in cui smettiamo di combattere contro di noi e iniziamo, finalmente, a vivere con noi.