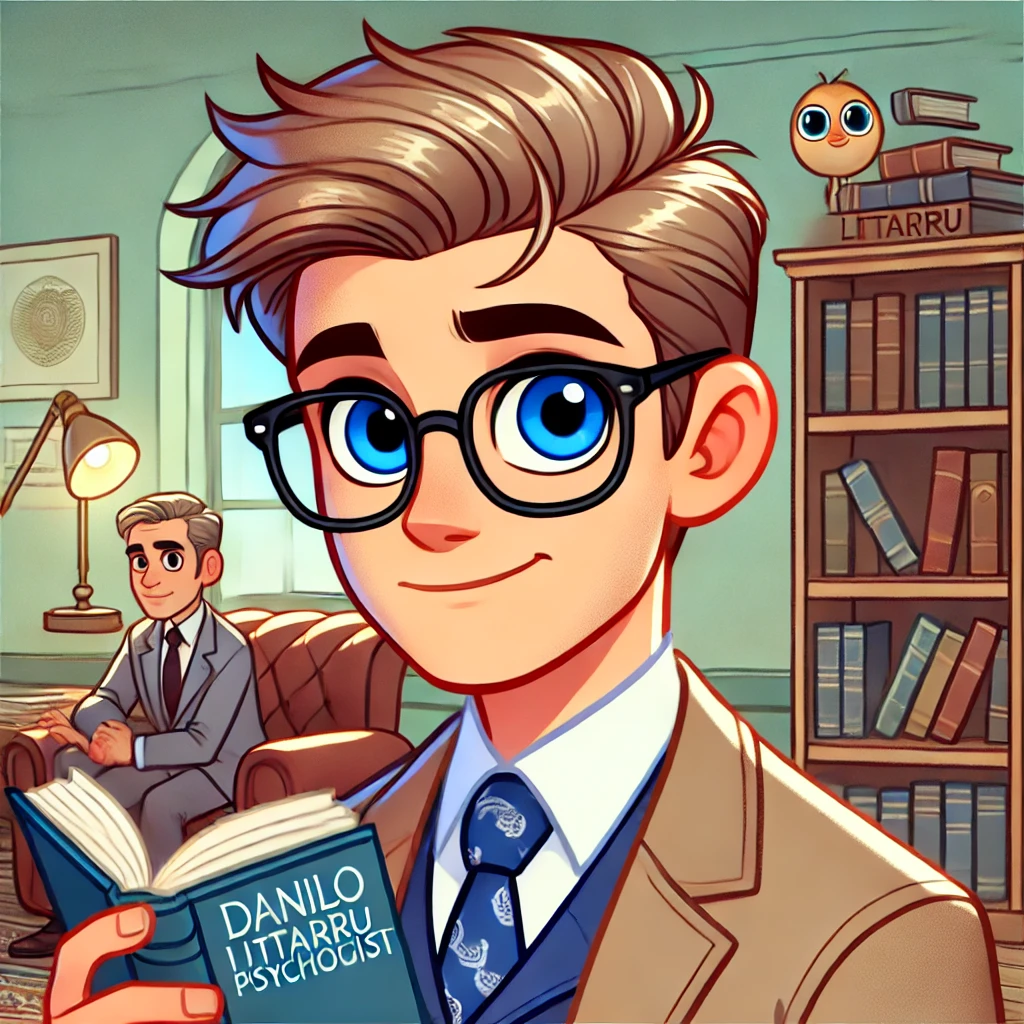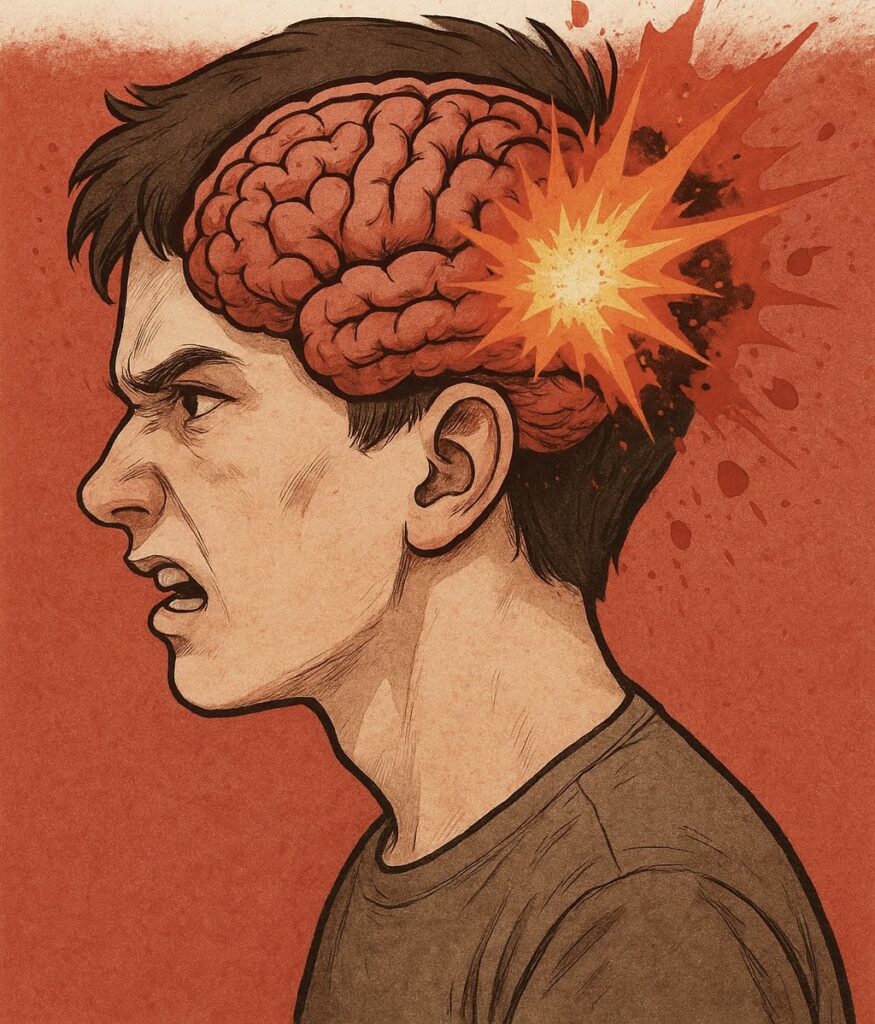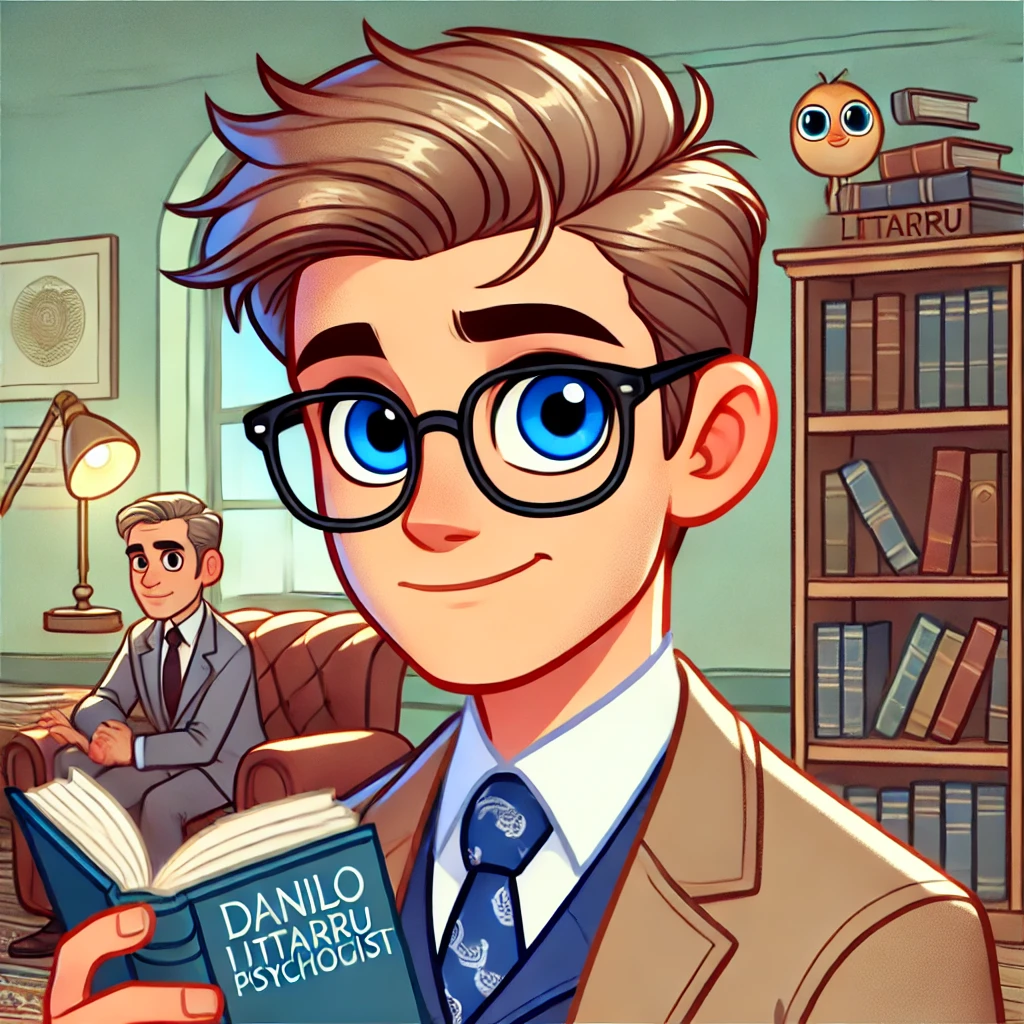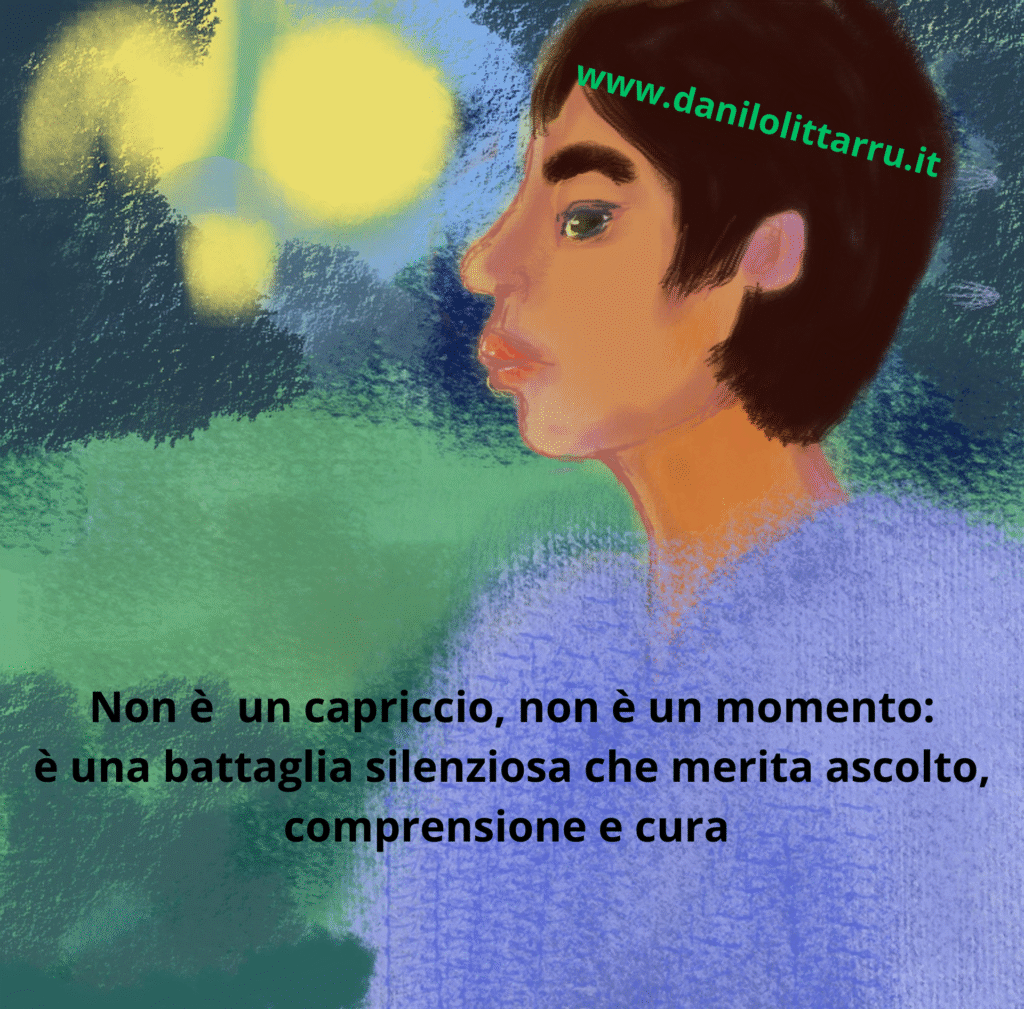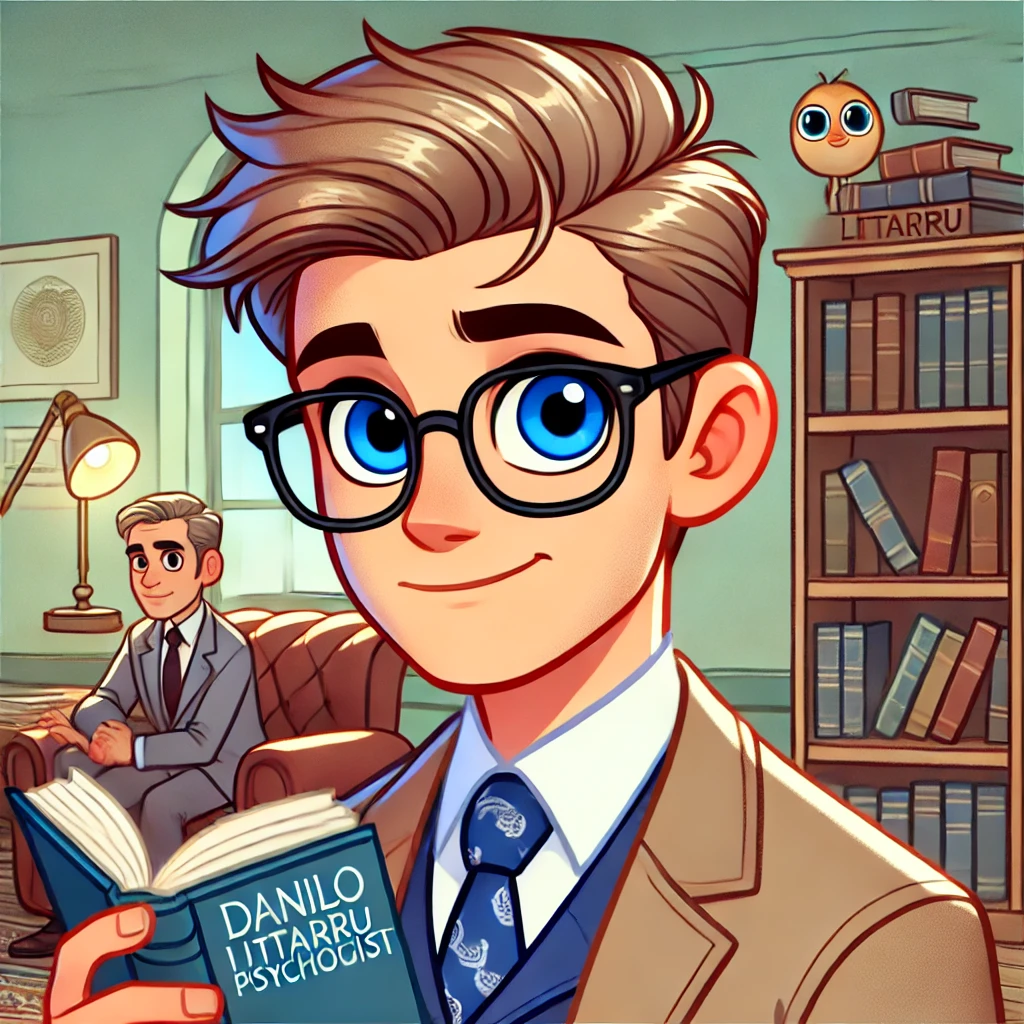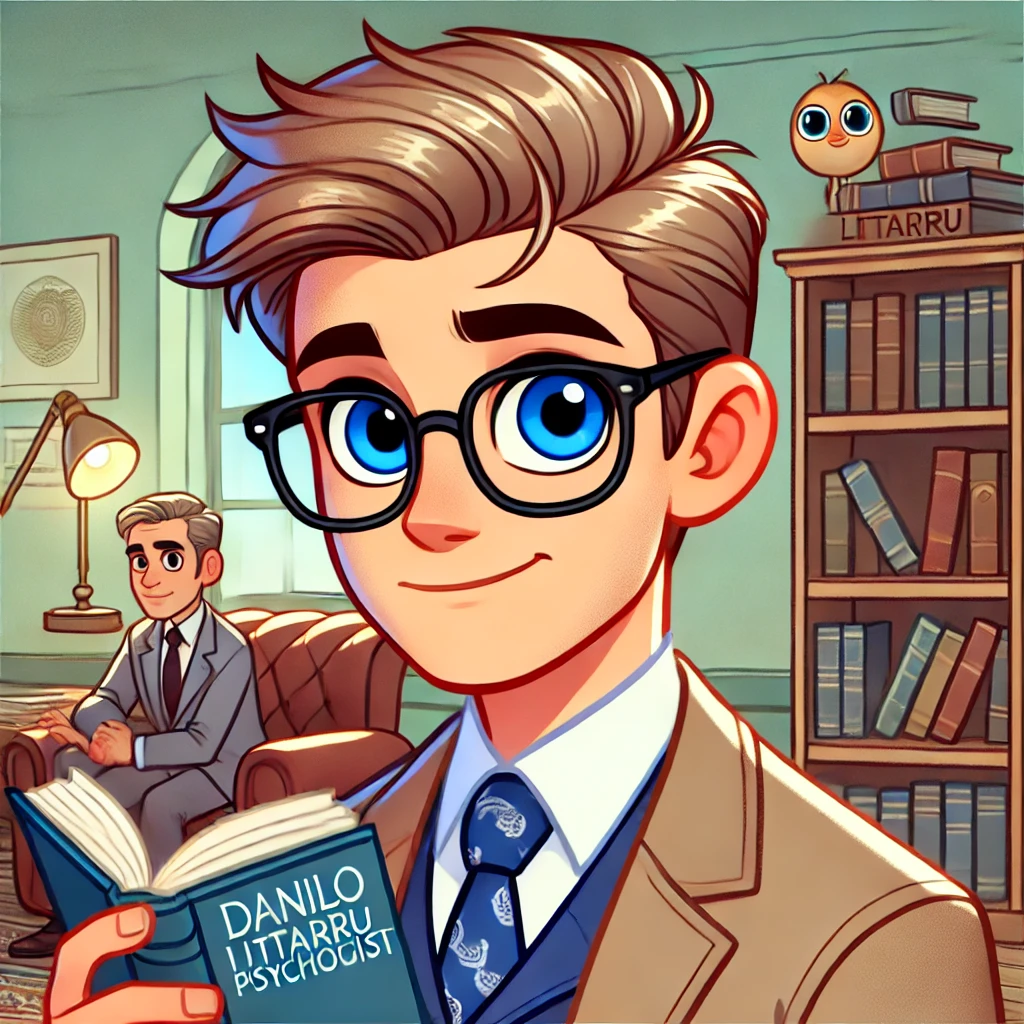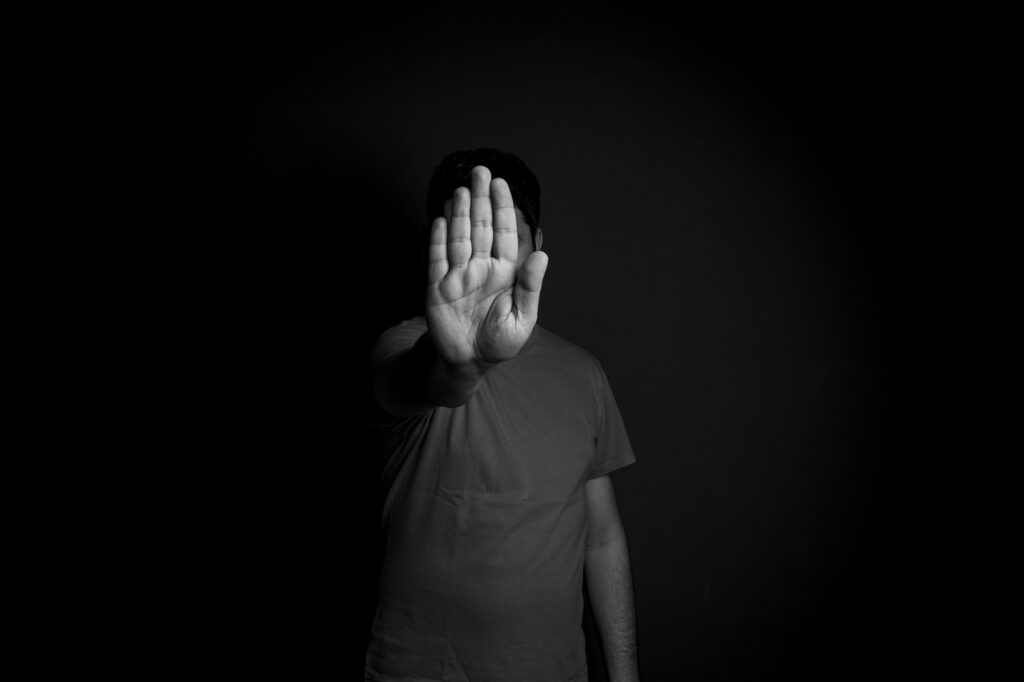Sindrome di Capgras: quando il volto familiare diventa quello di un impostore
Che cos’è la sindrome di Capgras?
La sindrome di Capgras è un delirio di identificazione in cui il soggetto crede fermamente che una persona a lui molto vicina – spesso un familiare – sia stata sostituita da un impostore identico nell’aspetto, ma privo della reale identità originaria. Questo disturbo prende il nome dallo psichiatra francese Joseph Capgras, che nel 1923 descrisse per la prima volta questa illusion des sosies.Caratteristiche cliniche
- Delirio monotematico: il paziente è convinto che il “sosia” sia identico nell’aspetto alla persona amata, ma non prova verso di lui nessuna connessione emotiva.
- Preservazione delle funzioni cognitive: nella maggior parte dei casi, la memoria e il linguaggio restano intatti.
- Convinzione incrollabile: il paziente non si lascia convincere dalla logica né dalle evidenze.
Nei casi più gravi, la sindrome si estende anche agli animali domestici, agli oggetti (Capgras per gli oggetti) o addirittura a se stessi (fenomeno noto come autosostituzione capgrasiana).
Cause e modelli neuropsicologici
Modello doppia via visiva
I principali studi (Ellis & Young, 1990) suggeriscono un disaccoppiamento tra riconoscimento visivo e risposta emotiva. La persona viene riconosciuta visivamente, ma non si attiva il circuito limbico che normalmente genera una risposta affettiva.
In altre parole: vedo mia madre, ma non “sento” che è lei.
Strutture cerebrali coinvolte
- Corteccia fusiforme: sede del riconoscimento facciale.
- Amigdala: responsabile della risposta emozionale.
- Lobo temporale e frontale destro: spesso alterati nei pazienti Capgras.
Connessioni con patologie neurologiche:
- Morbo di Alzheimer (circa 16% dei pazienti presenta deliri di Capgras – Berrios & Luque, 1995)
- Traumi cranici e encefaliti temporali
- Schizofrenia paranoide (il delirio si inserisce in un quadro psicotico più ampio)

Diagnosi differenziale
La diagnosi è complessa e richiede un approccio neuropsicologico integrato. È essenziale distinguere Capgras da:
- Prosopagnosia (incapacità di riconoscere i volti),
- Disturbo delirante di tipo persecutorio,
- Sindrome di Fregoli (disturbo opposto: la convinzione che persone diverse siano in realtà sempre la stessa che si traveste).
Trattamento e presa in carico
Non esiste una cura univoca, ma un intervento multidisciplinare è essenziale.
Interventi principali:
- Farmacoterapia: antipsicotici atipici come olanzapina o risperidone, con monitoraggio degli effetti collaterali.
- Riabilitazione cognitiva: per ricostruire la connessione tra volto e risposta emotiva.
- Psicoterapia di sostegno: per il paziente e per i caregiver, spesso soggetti a elevato stress.
- Neuromodulazione (in casi selezionati): studi recenti hanno esplorato l’uso della TMS (stimolazione magnetica transcranica) nei deliri resistenti.
Prospettive future e casi studio
- Un caso italiano trattato presso l’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia ha mostrato miglioramenti significativi combinando antipsicotici con terapia di realtà virtuale aumentata.
- Studi in corso al Karolinska Institutet stanno analizzando la relazione tra Capgras e alterazioni nella connettività cerebrale destra (fMRI funzionale).
- L’approccio terapeutico integrato proposto nel Progetto SAND (Sindrome da Alterazione del Nucleo dell’Identità) prevede un protocollo specifico per deliri da sostituzione in età geriatrica.
Conclusione
La Sindrome di Capgras rappresenta una delle sfide più affascinanti e destabilizzanti per la neuropsichiatria contemporanea. È la dimostrazione che l’identità non è solo memoria o visione, ma un sottile equilibrio tra percezione, affetto e riconoscimento. In un mondo dove il volto dell’altro può diventare maschera, la psicologia clinica ha il compito di restituire autenticità al legame e verità alla presenza.