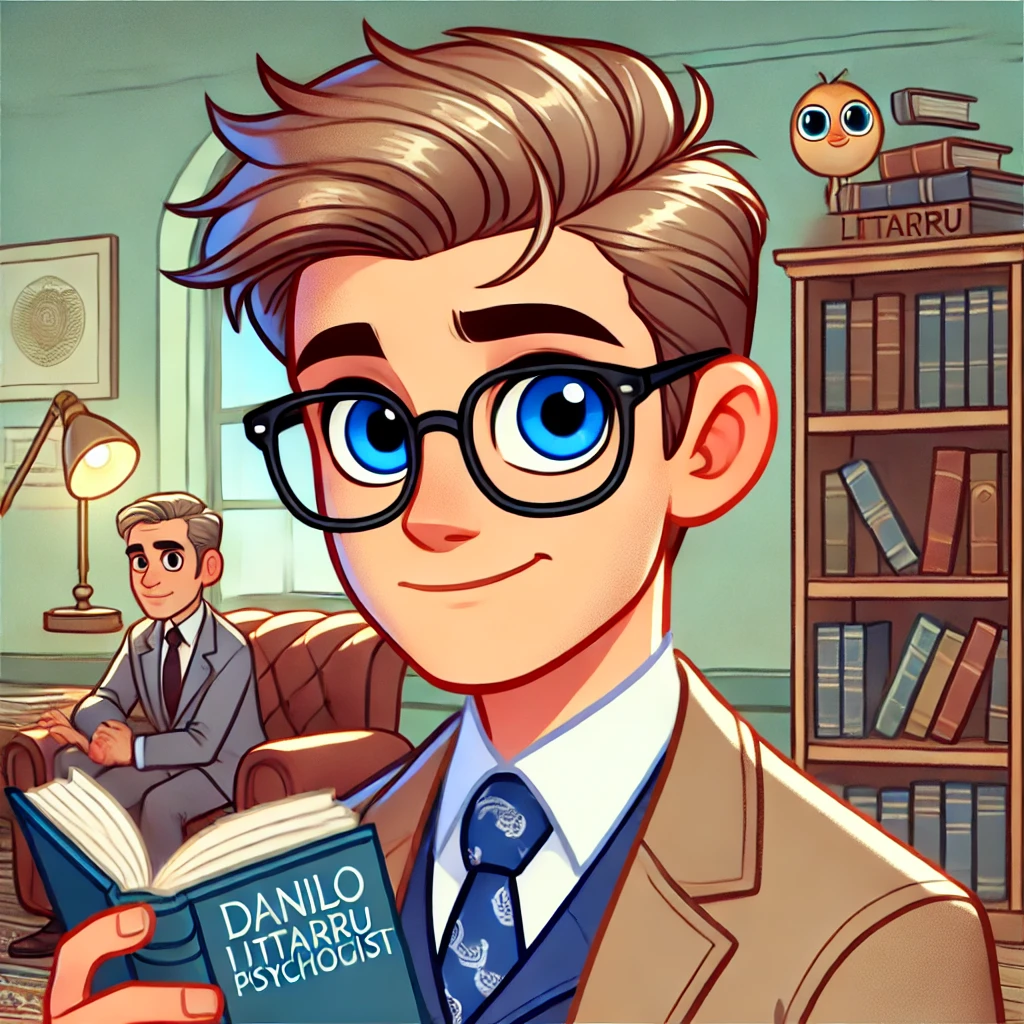Eredità invisibili: la trasmissione transgenerazionale del trauma.
Un trauma non si esaurisce con chi lo vive. In molti casi, esso si incarna nel silenzio familiare, nelle emozioni indicibili, nei gesti che si ripetono come un’eco muta. La psicologia contemporanea ha ormai documentato con rigore che i traumi possono attraversare le generazioni, incidendo profondamente sulla salute mentale e sullo sviluppo psico-affettivo della prole.
La scoperta dell’epigenetica del trauma
L’epigenetica ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’ereditarietà. Non solo i geni, ma le esperienze vissute – soprattutto quelle traumatiche – possono modificare l’espressione genica e queste modificazioni possono essere trasmesse alla generazione successiva.
Uno degli studi più noti è quello condotto sui sopravvissuti all’Olocausto: la ricerca del Mount Sinai Hospital di New York (Yehuda et al., 2016) ha mostrato come i figli di sopravvissuti presentino alterazioni epigenetiche nei geni legati alla risposta allo stress, in particolare al gene FKBP5, coinvolto nella regolazione del cortisolo.

Quando il dolore si eredita: clinica e osservazione
Molti pazienti portano dentro di sé tracce di eventi che non hanno vissuto in prima persona, ma che risuonano nella storia familiare: guerre, migrazioni forzate, lutti, abusi. La clinica parla di “memorie non elaborate”, che possono emergere sotto forma di ansia immotivata, senso di colpa, paura del mondo o difficoltà relazionali.
Il noto psicoanalista Nicolas Abraham parlava di “cripta psichica”, una sorta di sepolcro interiore dove si depositano segreti e dolori indicibili che il discendente finisce per incarnare inconsciamente.
Come si trasmette un trauma?
- Modelli relazionali: i genitori traumatizzati possono manifestare forme di attaccamento disorganizzato, trasmettendo insicurezza e imprevedibilità affettiva.
- Narrazioni spezzate: ciò che non è stato detto, elaborato o raccontato crea buchi neri nella biografia familiare.
- Epigenetica: come accennato, l’esposizione a eventi traumatici modifica l’espressione genica, con effetti sui sistemi neuroendocrini e comportamentali.
- Meccanismi proiettivi: il figlio viene investito di aspettative, paure o ideali che non gli appartengono, ma che riflettono il trauma rimosso del genitore.
E in Italia? Traumi collettivi e familiari
Nel contesto italiano, eventi storici come la Seconda Guerra Mondiale, l’emigrazione di massa, il terrorismo degli anni di piombo e i terremoti hanno generato traumi collettivi non elaborati. In molte famiglie sarde, ad esempio, il trauma migratorio ha inciso su intere generazioni, spesso nel silenzio o nella rimozione.
Un recente studio dell’Università di Torino (2023) ha evidenziato che i figli di migranti italiani degli anni ’50-’70 presentano maggiore incidenza di sintomi depressivi e ansiosi, anche in assenza di eventi traumatici diretti, suggerendo l’effetto a lungo termine delle condizioni stressanti vissute dai genitori.
La cura: dalla consapevolezza alla liberazione
L’elaborazione transgenerazionale del trauma avviene attraverso il riconoscimento, la narrazione e la ristrutturazione delle memorie familiari. Terapie come l’EMDR, l’approccio sistemico-relazionale, la psicogenealogia (Anne Ancelin Schützenberger) o la psicoterapia psicodinamica possono aiutare a “spezzare il cerchio”.
Come sottolinea la psicoanalista Françoise Davoine:
“I traumi che non parlano gridano da una generazione all’altra finché qualcuno non li ascolta.”