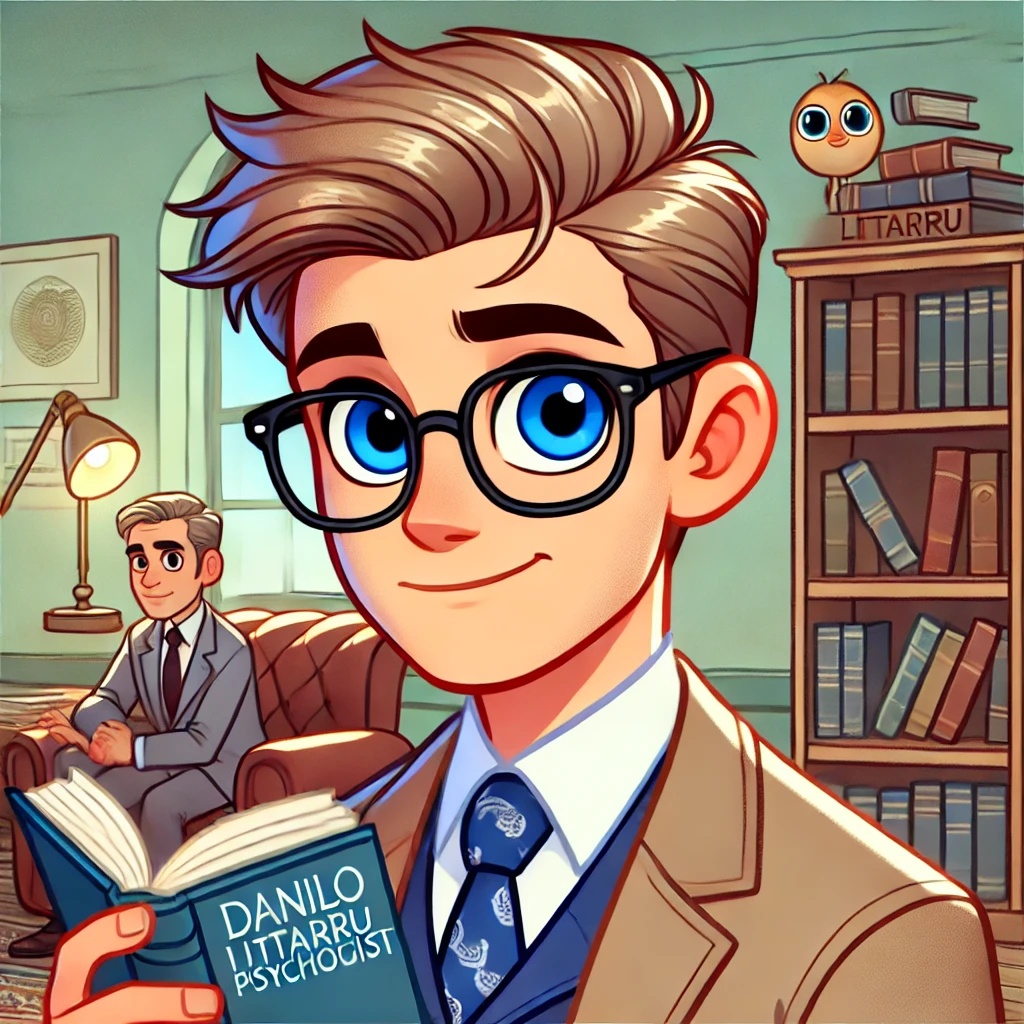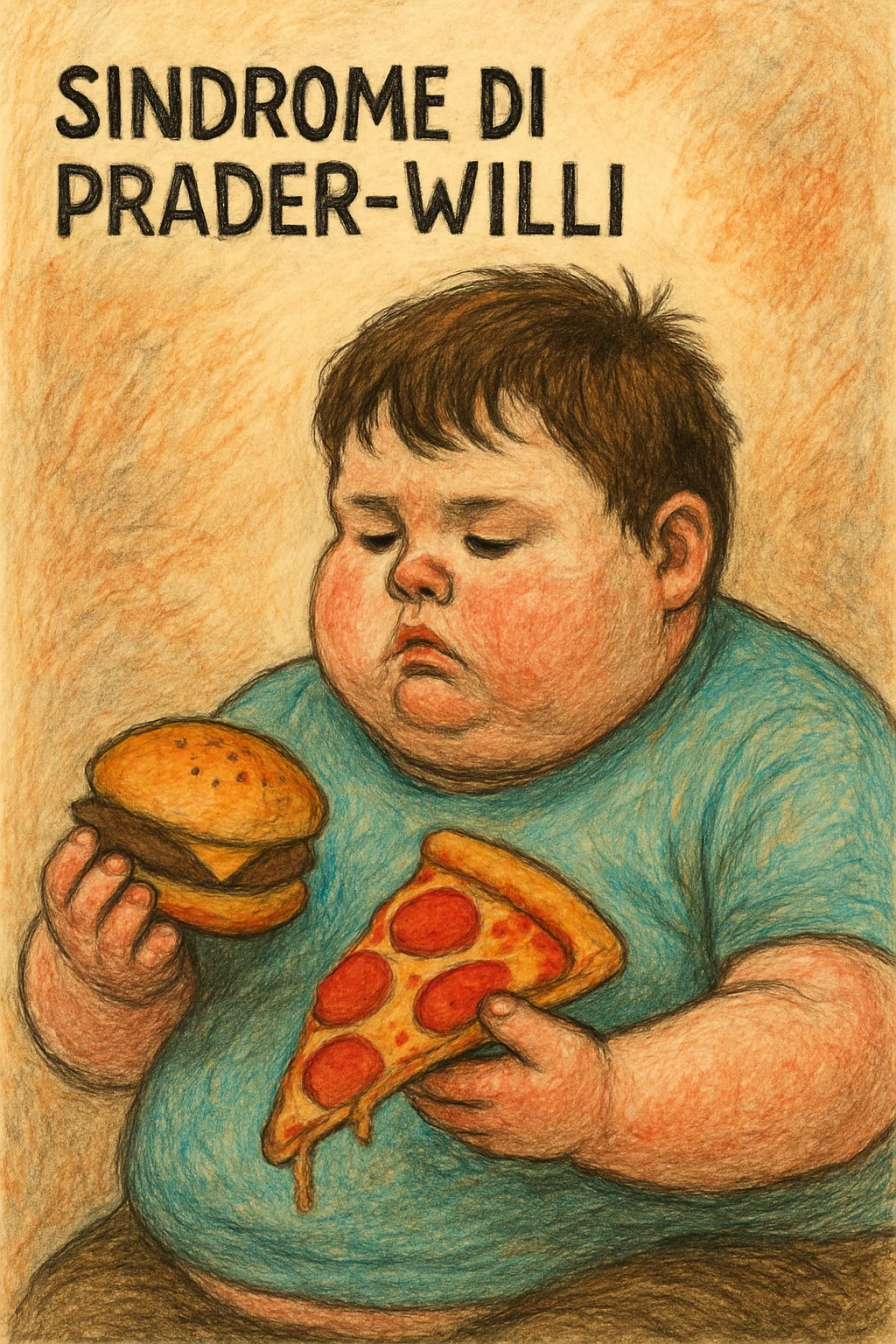Quando la fame diventa una trappola emotiva ed educativa.
Un disordine genetico con profonde ricadute psicoeducative
La Sindrome di Prader-Willi (PWS) è una malattia genetica rara, con una prevalenza stimata di 1 su 10.000-30.000 nati(Butler et al., 2019), causata da un’anomalia sul cromosoma 15 (delezione paterna o disomia uniparentale materna). Sebbene la diagnosi sia oggi precoce grazie ai test genetici, le implicazioni cliniche, psicologiche ed educative rimangono estremamente complesse.
Uno dei tratti distintivi della sindrome è la iperfagia compulsiva, ovvero un desiderio incontrollabile di cibo, che compare già tra i 2 e i 6 anni e tende a persistere a vita. Questo impulso non è attribuibile a semplice golosità, ma a un malfunzionamento dell’ipotalamo, area cerebrale deputata alla regolazione della fame e della sazietà.
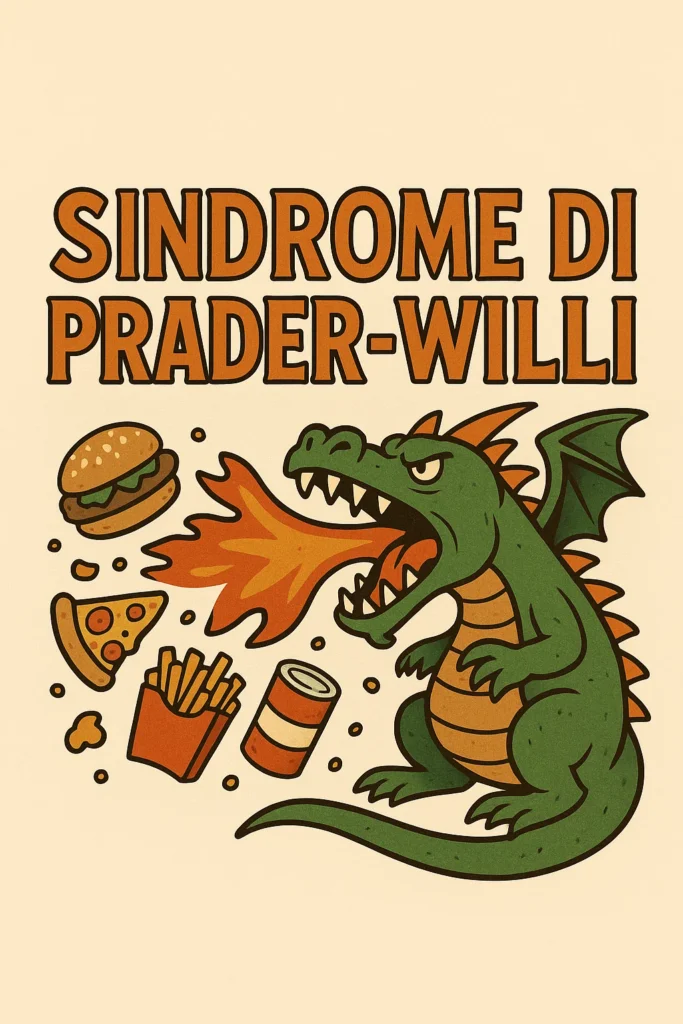
La fame che non si placa: una prigione interna
A differenza della fame fisiologica, che cessa una volta ristabilito l’equilibrio energetico, nella PWS essa è continua, estenuante, inesorabile. Come ricorda lo psicologo clinico Dykens (2008), “vivere con la Prader-Willi è come essere eternamente affamati: una tortura invisibile”.
Questa fame cronica conduce facilmente a forme gravi di obesità infantile, con gravi complicazioni cardiovascolari e respiratorie. Ma la vera trappola è sul piano affettivo: il cibo diventa un sostituto relazionale, un anestetico emotivo, una costante nella costruzione dell’identità.
Educare tra contenimento e riconoscimento
L’approccio educativo con bambini affetti da PWS richiede una pedagogia dell’ambivalenza: contenere senza mortificare, regolare senza umiliare. Le famiglie si trovano spesso in bilico tra l’ansia di controllo e il senso di colpa.
Il controllo ambientale (chiusura di dispense, diete rigide, supervisione costante) è necessario ma può alimentare dinamiche di frustrazione e isolamento. Serve una rete educativa capace di integrare contenimento e compassione, lavorando anche sulla competenza emotiva, sull’autostima e sull’autonomia residua.
Disturbi del comportamento e profilo cognitivo
Accanto all’iperfagia, la sindrome di Prader-Willi comporta ritardo cognitivo lieve-moderato, ipotonia muscolare, deficit attentivi, disturbi dello spettro ossessivo-compulsivo e comportamenti oppositivi-provocatori.
Secondo uno studio condotto da Sinnema et al. (2011), oltre il 70% dei bambini con PWS manifesta sintomi psichiatrici clinicamente rilevanti, con un’elevata incidenza di disturbi dell’umore, rigidità cognitiva e crisi comportamentali.
Tutto ciò rende imprescindibile il coinvolgimento di neuropsichiatri infantili, educatori specializzati e psicologi dell’età evolutiva.
Una sindrome che interroga la società
La PWS è anche una metafora estrema del nostro rapporto col desiderio, dove la fame non è solo corporea ma simbolica: fame di attenzione, di accudimento, di riconoscimento. Come scrive lo psichiatra Armando Ferrari, “Ogni corpo che eccede nasconde una psiche che chiede di essere ascoltata”.
Serve una comunità educante capace di andare oltre la medicalizzazione, che dia senso, voce e dignità alla fragilità. Gli interventi efficaci sono quelli multidimensionali e coordinati, dove l’alleanza scuola-famiglia-servizi è costante e mirata.
Conclusioni
Educare un bambino con la sindrome di Prader-Willi significa entrare in un campo di forze emotive ed etiche: cibo e affetto, regola e libertà, controllo e amore. Non esistono protocolli universali, ma la personalizzazione degli interventi è oggi la chiave per migliorare qualità della vita e benessere psicologico.