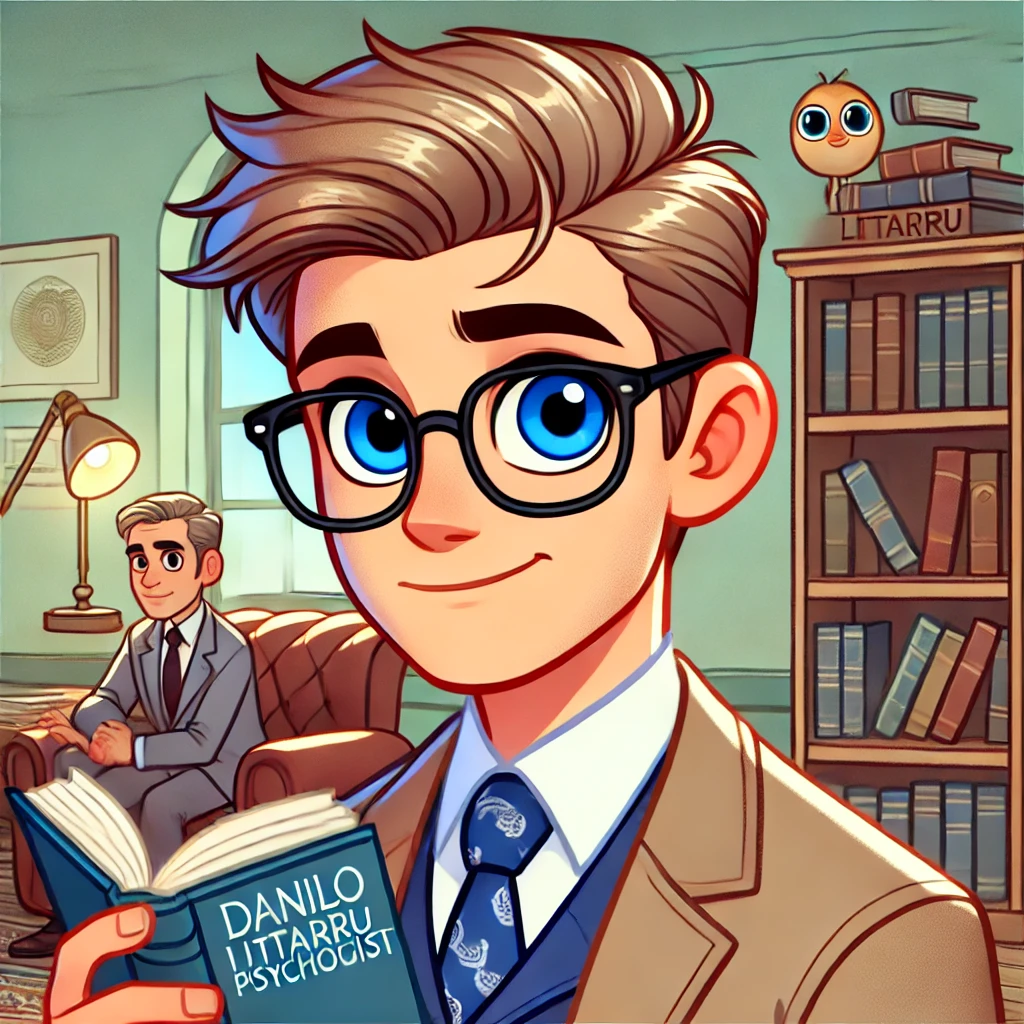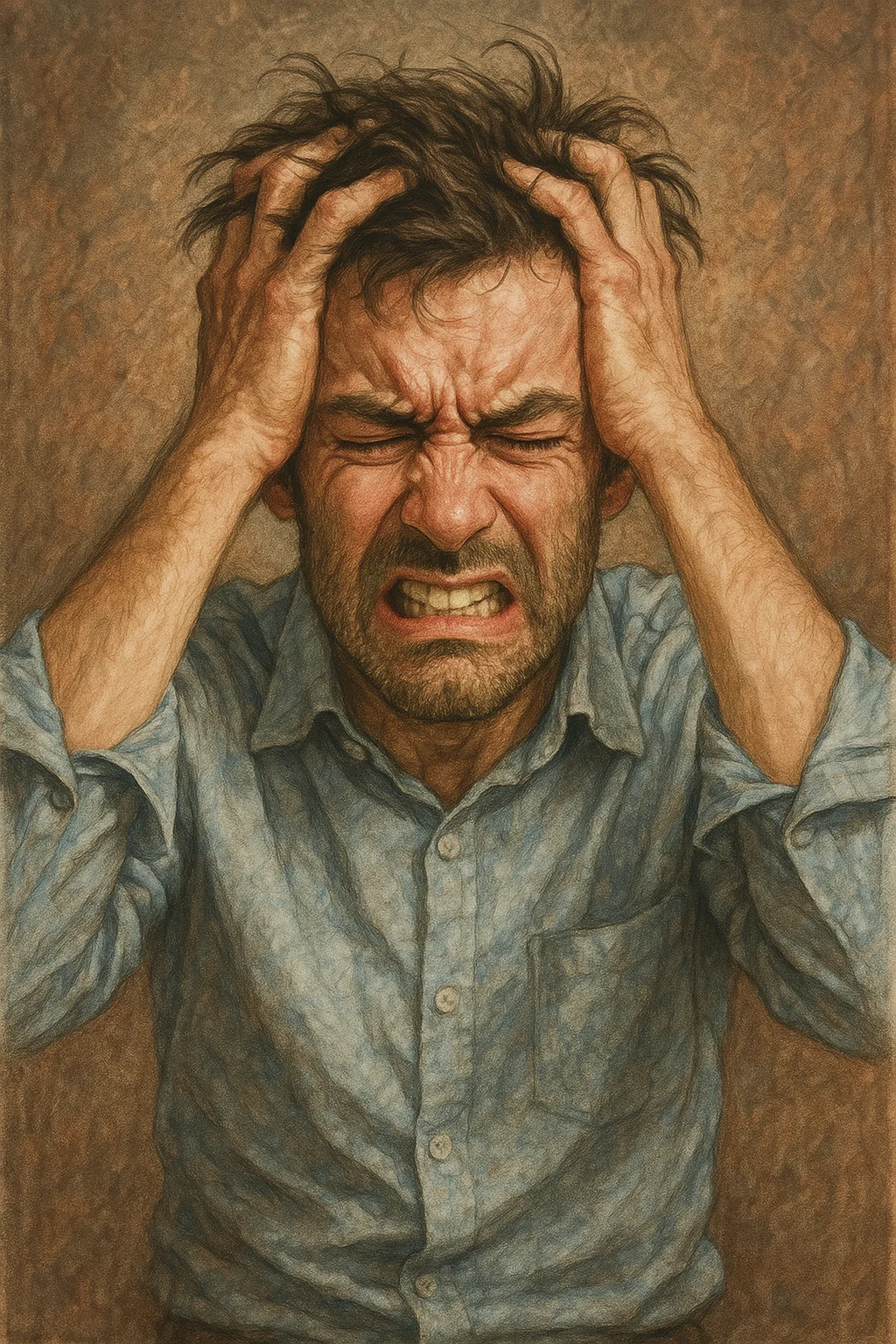l concetto di stress, oggi ampiamente usato in ambito psicologico, medico e sociale, trova le sue radici nella medicina del primo Novecento, grazie agli studi del fisiologo Hans Selye. Fu proprio Selye, nel 1936, a introdurre per la prima volta il termine “stress” in un contesto scientifico, definendolo come la risposta aspecifica dell’organismo a ogni richiesta effettuata su di esso. Da queste osservazioni nacque la teoria della General Adaptation Syndrome, una sindrome che descrive la risposta fisiologica allo stress in tre fasi distinte: allarme, resistenza ed esaurimento. Questo modello rimane un punto di riferimento fondamentale per la comprensione clinica del fenomeno. Negli anni ’80, Lazarus e Folkman riformularono il concetto in chiave cognitiva, definendo lo stress come un’interazione dinamica tra persona e ambiente, influenzata dalla valutazione soggettiva degli eventi stressanti e dalle risorse di coping disponibili.

Lo stress, in questa visione ampliata, si configura non solo come una tensione nervosa ma come una risposta sistemica e complessa, che coinvolge meccanismi neuroendocrini, immunitari e psicologici. Recenti studi hanno confermato il ruolo centrale degli assi HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene) e SAM (sistema simpatico-adreno-midollare) nella risposta allo stress, con attivazione ormonale che prepara l’organismo ad affrontare situazioni percepite come minacciose (NCBI). Questa attivazione, se cronica, può causare disfunzioni nel sistema immunitario, disordini dell’umore e patologie psicosomatiche.
Secondo il rapporto Stress in America 2024 dell’American Psychological Association, oltre il 70% degli adulti americani indica lo stress per il futuro della società come una fonte importante di disagio (APA). A livello globale, lo stress sul posto di lavoro è in forte crescita: un report del 2024 rivela che il 60% dei lavoratori riferisce un aumento dello stress professionale, con il 79% che lo identifica come la principale causa di malessere.
L’impatto dello stress sulla salute mentale è ulteriormente documentato da studi che mostrano come l’attivazione prolungata delle risorse cognitive in condizioni di stress alteri la capacità di regolazione emotiva e decisionale. A livello fisiologico, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) si è rivelata un indicatore affidabile dello stato di stress: livelli ridotti di HRV sono associati a una maggiore vulnerabilità psicologica e a esaurimento emotivo.
La psiconeuroimmunologia, infine, ha dimostrato come lo stress moduli le risposte immunitarie: la presenza prolungata di citochine infiammatorie può facilitare l’insorgenza di malattie croniche, mentre interventi psicologici adeguati — in particolare la terapia cognitivo-comportamentale — hanno mostrato efficacia nel ridurre questi marker biologici e migliorare la qualità della vita.
In definitiva, comprendere lo stress nella sua evoluzione storica e scientifica significa riconoscerne la natura multidimensionale, che richiede un approccio clinico integrato e personalizzato, capace di coniugare diagnosi psicologica, educazione emotiva e promozione del benessere mentale.