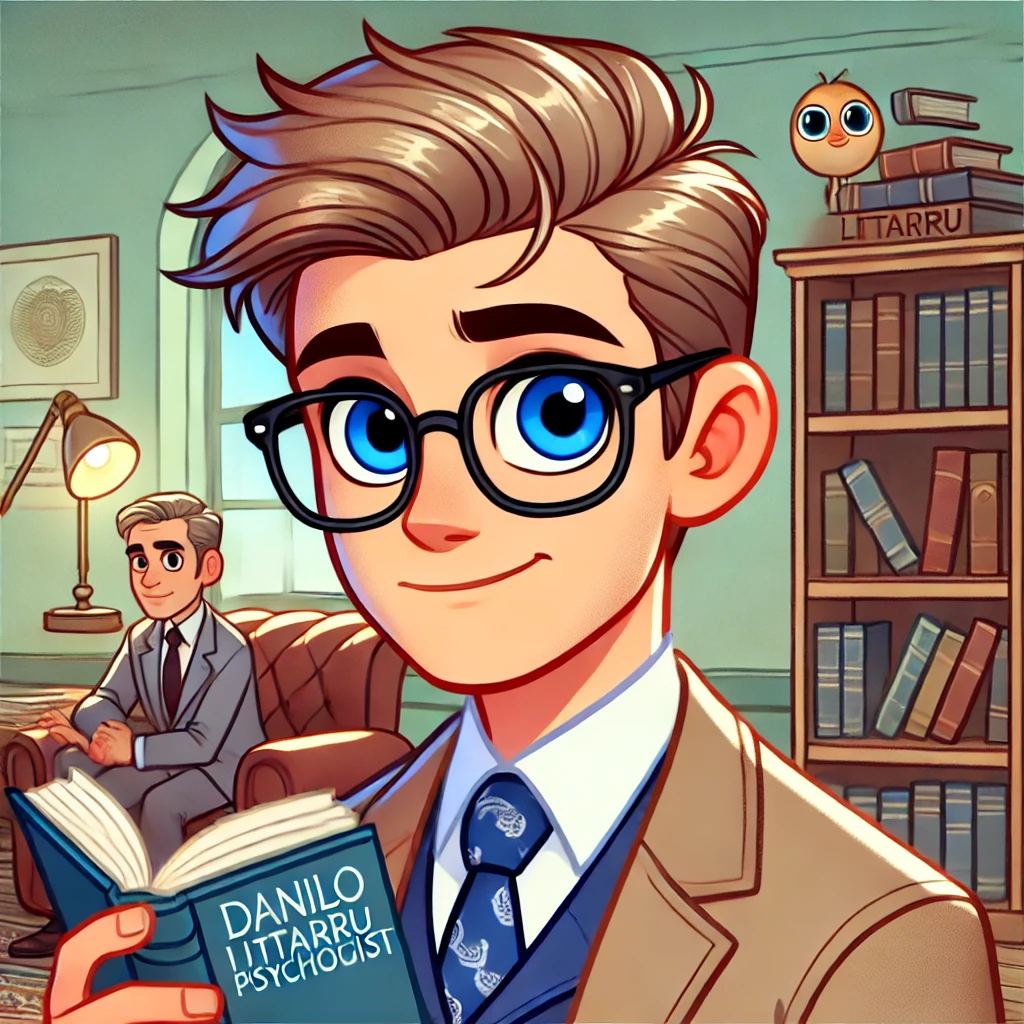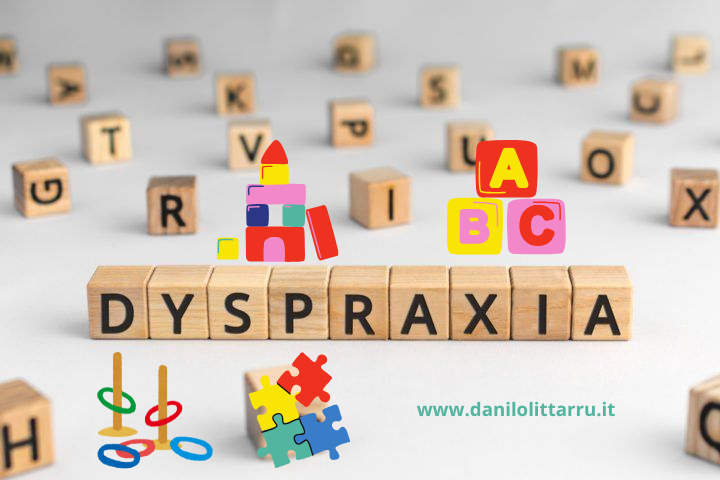“A volte il bambino che inciampa non è distratto: è il mondo che non ha ancora imparato a leggerlo.” D.L.
Un disturbo invisibile ai più
La disprassia evolutiva, nota in ambito internazionale come Developmental Coordination Disorder (DCD), è una condizione neurologica che compromette la pianificazione e l’esecuzione dei movimenti volontari, in assenza di deficit motori primari o cognitivi espliciti. Secondo il DSM-5 (APA, 2013), rientra tra i disturbi del neurosviluppo, con una prevalenza stimata intorno al 5-6% della popolazione infantile globale, sebbene i dati siano verosimilmente sottostimati a causa di diagnosi tardive o erronee.
In Italia, l’Istituto Superiore di Sanità rileva che circa il 4% dei bambini in età scolare presenta sintomi compatibili con una forma di disprassia, ma solo una parte riceve una valutazione specialistica entro i primi otto anni di vita. Un’indagine europea promossa da European Academy of Childhood Disability (2021) ha evidenziato un preoccupante ritardo nella presa in carico nei Paesi mediterranei rispetto a quelli nordici, dove le prassi diagnostiche risultano più sistematiche.

Le cause: un mosaico di fattori neurobiologici
Non esiste un’unica causa della disprassia. Studi condotti con tecniche di neuroimaging funzionale (Forde et al., 2020; Licari et al., 2021) hanno evidenziato alterazioni nei circuiti fronto-parietali, in particolare nella corteccia premotoria e nel cervelletto, suggerendo una disfunzione nella comunicazione interemisferica e nella rappresentazione interna del movimento.
Alcune ipotesi etiologiche includono:
- Complicanze perinatali (ipossia, prematurità)
- Disregolazioni sensoriali precoci
- Alterazioni nei geni legati alla motricità fine (ad esempio DYX1C1, associato anche alla dislessia)
Segnali clinici e criticità scolastiche
I bambini disprassici manifestano difficoltà nel vestirsi, allacciarsi le scarpe, scrivere, utilizzare le posate o partecipare a giochi sportivi. La componente motoria impatta direttamente sulla sfera psicologica, generando vissuti di frustrazione, esclusione sociale e una possibile comorbilità con disturbi internalizzanti come ansia o depressione (Zwicker et al., 2018).
In adolescenza, una diagnosi tardiva può comportare un impatto significativo sull’autostima e sulla performance scolastica. Le difficoltà nella gestione dello spazio, nella coordinazione occhio-mano e nella scrittura (disgrafia) spesso vengono erroneamente interpretate come svogliatezza o disattenzione, aggravando il ritardo nella presa in carico.
Diagnosi tardiva: non è mai troppo tardi per intervenire
Quando la disprassia viene riconosciuta oltre i 10 anni, è necessario un approccio multimodale, che coinvolga:
- Valutazione neuropsicologica integrata, con particolare attenzione alle funzioni esecutive e visuo-spaziali.
- Riabilitazione psicomotoria individualizzata, basata su esercizi progressivi di organizzazione spazio-temporale, equilibrio e pianificazione.
- Strumenti compensativi, come tastiere facilitanti, sintesi vocale, o mappe concettuali.
- Supporto psicologico, mirato al rinforzo dell’identità personale e della motivazione scolastica.
Un efficace protocollo di intervento è stato illustrato dal progetto Move to Learn (Cairney et al., 2019), che ha dimostrato significativi miglioramenti nella coordinazione motoria e nell’integrazione sociale di adolescenti con DCD.
Il ruolo della scuola e della famiglia
La sinergia tra scuola e famiglia è essenziale. L’introduzione di Piani Didattici Personalizzati (PDP), come previsto dalla normativa italiana (Legge 170/2010), può rappresentare un valido strumento per garantire equità e accessibilità all’apprendimento. La formazione degli insegnanti sul tema della disprassia resta tuttavia disomogenea: secondo una recente indagine ANPE (2022), solo il 28% dei docenti ha ricevuto un’adeguata preparazione in merito ai disturbi della coordinazione motoria.
Conclusioni
La disprassia non è sinonimo di goffaggine, ma una complessa condizione neuroevolutiva che richiede attenzione, diagnosi precoce e interventi mirati. Anche in caso di diagnosi tardiva, è possibile promuovere uno sviluppo armonico e rafforzare il senso di autoefficacia nel soggetto, a patto che vi sia una rete competente e solidale attorno a lui.